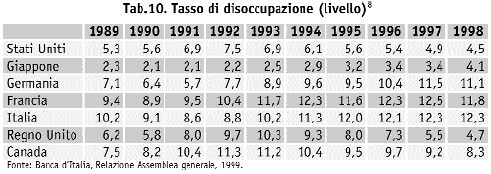![]()
Rubrica
L’analisi-inchiesta
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Luciano Vasapollo Docente di Economia Aziendale, Fac. di Scienze Statistiche, Università’ “La Sapienza”, Roma; Direttore Responsabile Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali (CESTES) - Proteo. Rita Martufi Consulente ricercatrice socio-economica; membro del Comitato Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico Sociali (CESTES) - PROTEO
Ristrutturazione capitalistica
Le tendenze macroeconomiche del processo di ristrutturazione capitalistica
Tutti gli articoli della rubrica: analisi-inchiesta(in tutti i numeri di Proteo)
|
Ma quanto incidono i processi di internazionalizzazione nell’occupazione? I dati ufficiali della Banca d’Italia evidenziano un netto calo dell’occupazione in Italia, cosa che si nota anche negli altri paesi; è chiaro quindi che i costi degli attuali processi di internazionalizzazione della competizione globale significano riduzione dei costi, in particolare del costo del lavoro, riduzione dei salari, aumento della produttività del lavoro, quindi dello sfruttamento, diminuzione dei posti di lavoro. Le tabelle seguenti evidenziano quanto scritto; va ricordato che il lieve aumento degli occupati registrato negli Stati Uniti va comunque interpretato, in quanto è diverso il modo di rilevamento; in questo paese infatti essendo molto diffusa la flessibilità e la precarizzazione del lavoro si reputano occupati anche coloro che lavorano pochi mesi l’anno; lo stesso si può dire per il Canada; per altre osservazioni si veda la 1a e la 2a parte di questa analisi-inchiesta.
Se si guarda al tasso di disoccupazione per il 1998 di alcuni tra i principali paesi industrializzati ci si accorge subito che l’aumento riguarda tutti con l’eccezione degli USA e del Regno Unito; da evidenziare il 12,3% dell’Italia (vedi Tab. 10).
2. I nuovi processi di internazionalizzazione produttiva nella competizione globale post-fordista
La globalizzazione dei mercati è un elemento caratterizzante di questi ultimi decenni; le istituzioni politiche, economiche e culturali devono confrontarsi ogni giorno con questo fenomeno che sta provocando una disgregazione delle culture, dei confini e delle economie nazionali anche perché ha sempre più assunto la forma di competizione globale post-fordista nell’era dell’accumulazione flessibile. Anche in un’ottica puramente di modalità di sviluppo capitalistico vi sono diversi problemi giuridici , sociali e più direttamente economici legati a questo fenomeno. In primo luogo non vi sono controlli efficaci nel funzionamento dei mercati finanziari in quanto gli operatori possono decidere di spostare ingenti somme di denaro da una parte all’altra del mondo, che in un contesto di deregolamentazione significa agire esclusivamente secondo le proprie esigenze di profitto senza avere nessun controllo politico nè tanto meno strumenti di intervento delle autorità monetarie. Vi sono inoltre effetti devastanti sul modello e sul ciclo produttivo, in quanto vi è sempre maggiore richiesta di risorse specializzate e con un alto livello di immaterialità e flessibilità; le fasi del ciclo più deboli, a basso contenuto di valore aggiunto, quindi, sono escluse, esternalizzate, delocalizzate all’estero alla ricerca di lavoro specializzato, non normato e a basso salario. I nuovi metodi di comunicazione, veloci e dinamici hanno cambiato le varie politiche di localizzazione e quindi il concetto di distretto ha perso alcune delle sue specificità, prendendo forma di filiere produttive e reti a carattere internazionale. In questi ultimi anni si sta diffondendo un nuovo concetto nella produzione delle imprese : quello di filiera produttiva. Questo termine sta ad indicare una serie di operazioni di trasformazione che permettono di produrre beni e prodotti in forma diversa rispetto all’epoca fordista-taylorista. La Scuola Francese di Economia Industriale è stata la prima ad introdurre questo termine per cercare di trovare affinità tra i diversi stadi della produzione in modo da indicare i settori più soggetti alla concorrenza, alla competizione globale e a maggiore contenuto di valore. In una prima visione il concetto di filiera descriveva un ipotetico processo produttivo come diverse operazioni tecniche che accadevano nel corso del tempo; nel passaggio dalle fasi a monte a quelle a valle non deve esserci necessariamente la stessa tecnologia in quanto l’elemento unificante è solo il prodotto trasformato, quindi più che altro in questo modo si identifica una filiera a carattere temporale. Questa visione semplicistica è stata mutata da alcuni industriali francesi che considerano non soltanto la divisione del ciclo in fasi ma anche l’organizzazione di ciascuna fase e i processi di trasferimento tra le fasi successive. In questo modo si evidenzia il grado di interdipendenza del tessuto produttivo e si descrivono le strategie di integrazione e le forme di organizzazione individuate tradizionalmente nell’impresa, nel mercato e nella cooperazione tra le imprese attraverso accordi di natura commerciale, di subfornitura, di trasferimento di tecnologie, ecc.; si identifica così una sorta di filiera a carattere produttivo di tipo spazio-temporale. Stigler nel 1951 riprende il teorema sulla divisione del lavoro per dire che, a parità di condizioni, le imprese che operano su mercati limitati assumono in tendenza strutture più integrate, ed arriva alla conclusione che vista la ristrettezza del mercato non vi sono le condizioni per l’esistenza di un unico produttore; le imprese tenderanno quindi ad assumere una struttura integrata [1]. I nuovi mercati sono globali sia nel campo della produzione sia in quello dei capitali, i quali oggi possono essere trasferiti in pochi secondi da una parte all’altra del mondo; si tratta della cosiddetta “globalizzazione finanziaria” che, come si è visto nei numeri precedenti di questa analisi-inchiesta, comunque non assicura investimenti più efficaci, ma diventa fenomeno che si coniuga alle nuove forme di internazionalizzazione produttiva centrati sui processi dell’accumulazione flessibile delle risorse del capitale intangibile, determinando una vera e propria competizione globale internazionale, ma più accesa fra poli imperialistici (in questo momento in particolare fra USA e UE). Da parte dei diversi organismi istituzionali e legati al mondo imprenditoriale tale nuovo contesto della globalizzazione viene assimilato ad un concetto di libertà ed abbattimento di ogni tipo di barriera economico-sociale in quanto, si sostiene, attraverso gli investimenti, le ristrutturazioni, le alleanze, le acquisizioni e le delocalizzazioni, ci si illude di poter realizzare un’organizzazione d’impresa in grado di occupare aree geografiche e settori di mercato profondamente legati tra di loro, migliorando le condizioni di vita generali della popolazione. Ma come si è visto nelle puntate precedenti dell’inchiesta, questa è, nella migliore delle ipotesi, pura illusione, spesso supportata da trucchi contabili; si tratta in effetti di falsità per far digerire meglio i costi sociali dell’accumulazione capitalistica flessibile post-fordista. La competizione globale caratterizza questa nuova fase del capitalismo che potremmo riassumere in competizione senza sviluppo e quando c’è sviluppo è senza occupazione e si traduce in “impoverimento assoluto”, imponendo la trasformazione delle classi, delle fasce medie in fasce sempre più marginali della società. Questo fenomeno è strettamente associabile allo sviluppo delle nuove tecnologie soprattutto quelle informatiche e telematiche che permettono aumento di produttività, calo dell’occupazione e processi delocalizzativi in quanto si è sempre più in un contesto produttivo meno legato al posto fisico e al territorio. I classici criteri di internazionalizzazione diventano così sempre meno efficaci soprattutto a causa dell’ampliamento dell’ambiente imprenditoriale e della sua dinamicità. Ma cosa significa processo di internazionalizzazione? La crescente internazionalizzazione dei mercati e l’innovazione tecnologica hanno cambiato tutti i sistemi locali di impresa; i vantaggi derivanti dalla localizzazione a distretti, ossia cooperazione, vicinanza dei mercati, circolazione veloce delle comunicazioni, ecc. non sono stati sufficienti a consentire un complessivo vantaggio del sistema. Il processo di internazionalizzazione è ormai affermato nei mercati come processo di competizione globale per l’impresa sociale generalizzata post-fordista nell’epoca dell’accumulazione flessibile. Infatti escludendo il circuito dei consumi locali e tradizionali, per la stragrande maggioranza dei prodotti ormai non vi è differenza di status o di percezione dei prodotti nazionali e dei prodotti trasnazionali; di solito i prodotti che provengono da altri paesi o sono diretti ad altri paesi vengono trattati allo stesso modo dei prodotti domestici. Le imprese ormai tendono a considerare il mercato interno come una delle parti di un mercato più ampio, articolato in molte unità nazionali: un mercato transnazionale in cui sviluppare la competizione globale in chiave microeconomica come competizione fra imprese e in un’ottica macroeconomica come competizione fra poli imperialisti. Le imprese comunque sono un asso portante dell’internazionalizzazione in quanto da una parte hanno creato la trasnazionalità e dall’altra ne hanno tratto il massimo beneficio. Lo sviluppo dell’internazionalizzazione si collega con la crisi del fordismo; infatti la liberalizzazione nei mercati nazionali ha un effetto molto dirompente nella struttura di potere e di equilibrio del fordismo. Da un lato infatti le imprese spinte da una concorrenza internazionale si distaccano dalla protezione pubblica mentre dall’altro lato diminuisce il potere regolatore dello Stato che diventa Profit State Globale. In pratica quindi l’internazionalizzazione diventa “deregulation” nel quale non vi è una riorganizzazione post-fordista ma una perdita di vecchia organizzazione per realizzare un’organizzazione funzionale all’accumulazione flessibile. La prospettiva post-fordista non deve avere meno organizzazione ma anzi necessita di un’organizzazione più complessa che deve governare una rete di interdipendenze molto più ampia di quella dell’impresa fordista; deve altresì coordinare il cambiamento che si attua anche sulle risorse del capitale che hanno sempre più valenza intangibile. Comunque la crescente internazionalizzazione dei mercati e l’espansione del processo di innovazione tecnologica e dell’espansione dell’accumulazione informativa e cognitiva hanno cambiato le strategie e le modalità di crescita tradizionali delle imprese. Dal punto di vista dell’identificazione delle zone di attività produttiva vi sono due modalità tra loro complementari: il nuovo settore post-fordista e la filiera internazionale. Si parla di settore quando è possibile trovare una certa omogeneità della manifattura oppure se la materia prima impiegata svolge il ruolo di denominatore comune a più cicli produttivi; nella filiera invece non vi è omogeneità tecnologica nelle varie fasi del ciclo e quindi il principio unificante è dato dal prodotto finale trasformato; in questo modo vi è l’acquisizione all’estero di alcune fasi della lavorazione attraverso processi di delocalizzazione produttiva.
Sono tre i momenti che caratterizzano la filiera internazionale:
La filiera internazionale è quindi costituita da una rete di connessioni sia economiche sia tecnologiche che consentono di attuare delle strategie di partnership in ambiti nazionali diversi; un esempio di filiera può essere quello del settore agroalimentare nel quale dalla produzione agricola di base si passa ai settori che fanno la prima lavorazione e che producono il prodotto finito per il consumatore. [1] Questa tesi comunque pur spiegando il fenomeno dell’integrazione in termini statici non spiega il fenomeno nel caso in cui il termine di confronto sia il tasso di crescita del mercato stesso ossia nel caso di un mercato dinamico. Adelman (1955) ha evidenziato per primo la limitatezza della tesi di Stigler. L’analisi dei vari contributi teorici sul tema dell’integrazione verticale evidenzia comunque che ciascun contributo sviluppa aspetti e condizioni particolari ma non spiega il fenomeno a prescindere da riferimenti specifici.
|