Quarta parte: Le dinamiche evolutive dei processi di internazionalizzazione
1. Caratteri ed alcuni dati macroeconomici della competizione globale
Come si è approfondito nelle precedenti puntate di questa analisi-inchiesta, negli anni che vanno dal secondo dopoguerra ad oggi si sono avute due fasi fondamentali; la prima che si è protratta fino all’inizio degli anni ‘70 è stata caratterizzata da tassi di occupazione e crescita del prodotto abbastanza alti e stabili; la seconda che arriva fino a questi ultimi anni si distingue per una crescita del prodotto molto più ridotta e per una diminuzione dell’occupazione.
L’economia internazionale ha subito in questi ultimi anni gli effetti della grave crisi finanziaria dell’Asia sudorientale; l’oscillazione del mercato dei cambi cominciata con la svalutazione della moneta tailandese si è diffusa rapidamente alle Filippine, alla Malesia e all’Indonesia provocando svalutazioni, crolli di borse locali e fallimenti bancari. Questa crisi ha messo in evidenza le gravi lacune esistenti di quelle economie: l’eccessiva disponibilità di lavoro e di capitale, i disavanzi nei conti con l’estero e con settori finanziari fragili, la vulnerabilità del settore finanziario.
La crisi dell’Unione Sovietica, la disgregazione dal 1989 al 1991 dell’Europa dell’est hanno determinato la crisi del bipolarismo e rafforzato la posizione anche commerciale e di internazionalizzazione produttiva degli Stati Uniti, facendo però allo stesso modo evidenziare il maggior peso nei processi di competizione globale dell’Europa, in tendenza come polo capace di ostacolare lo strapotere nordamericano.
E’ chiaro che al momento gli USA traggono vantaggio da questa situazione ed anzi si preoccupano di mantenere in ogni modo questo predominio; il timore è di competere con l’Europa unita e con il Giappone.
Proprio per mantenere ed anzi rafforzare il predominio sugli altri paesi, gli USA hanno portato avanti il progetto del trattato del libero scambio dell’America del Nord (NAFTA) con cui togliendo i dazi doganali dei paesi aderenti vengono integrati i diversi settori industriali ed agricoli. Questo trattato però registra una mancanza di una vera consultazione pluralistica sul negoziato eventuale del trattato commerciale con gli USA e il Canada; inoltre vi sono considerevoli svantaggi commerciali e produttivi per il Messico in quanto lascia fuori dal negoziato la mobilità della manodopera, aumenta il controllo degli USA sul mercato agricolo del Messico e subordina al controllo straniero i servizi nazionali finanziari e quelli degli autotrasportatori.
In sostanza quindi il NAFTA ha dei limiti notevoli e non è sicuramente utile per una crescita effettiva dei paesi dell’America Latina. Si rileva, infatti, la posizione di svantaggio dei paesi dell’America Latina che a causa delle politiche monetariste, le privatizzazioni delle imprese statali, l’eliminazione dei dazi e le politiche e gli accordi antiflazionistici, hanno registrato un impoverimento di settori sempre più ampi di popolazione. In questi paesi si è avuta una drastica diminuzione dei salari reali, la perdita di molti posti di lavoro e un accentuamento della crisi agricola. Essi hanno, invece, la necessità di vedere ridotto o annullato completamente il debito pubblico, riorganizzare in loro favore le decisioni degli organismi finanziari internazionali, quali la Banca Mondiale, la Banca Panamericana di Sviluppo e il Fondo Monetario Internazionale per eliminare i condizionamenti e le politiche di “nuovo colonialismo” imposto proprio attraverso le politiche di questi organismi; è inoltre necessario regolamentare e controllare il capitale straniero e stabilire regole per la conservazione dell’ambiente, per il reinvestimento, le tassazioni e i trasferimenti di tecnologia netta. E’ anche indispensabile la negoziazione degli accordi sulla migrazione internazionale per evitare la violazione dei diritti umani, sociali ed economici dei lavoratori emigrati che sistematicamente vengono assoggettati a forme sempre più dure e subdole di sfruttamento nei paesi sviluppati.
Un elemento importante che ha caratterizzato questi ultimi decenni è rappresentato dal trasferimento del centro di gravità economico dell’Asia dal Giappone alla Cina; negli ultimi 15 anni infatti la Cina ha registrato straordinari tassi di crescita; il PIL ha avuto un incremento annuo medio del 9,7% a fronte del 2,9% dei paesi del Terzo Mondo, quelli in via di sviluppo ma con buoni risultati economici.
La crescita economica della Cina non è realizzata dall’andamento delle esportazioni (va ricordato infatti che in ogni altro paese il rapporto tra esportazioni e crescita del PIL annua è circa del doppio), anche l’indebitamento internazionale è ridotto e l’inflazione è sotto controllo.
La crescita della Cina va imputata a diversi fattori; in primo luogo pur essendo presente un sistema abbastanza complesso dei prezzi non vi è una liberalizzazione del mercato; in secondo luogo non si sono avute privatizzazioni, ossia pur essendo stato attivato un settore privato nuovo non vi è stata privatizzazione di ciò che già era in precedenza a carico del settore statale. A ciò si aggiunge una estesa decentralizzazione alle regioni; infatti, la proprietà di Stato rispetto al PIL è diminuita dall’85% al 54% mentre la proprietà collettiva regionale è cresciuta dal 21% al 35% grazie al decentramento, mentre il settore privato è aumentato dal 2% al 6%.
Il fenomeno della crescita cinese è, quindi, più facilmente spiegabile; infatti, anche se questo paese si caratterizza per avere la popolazione più numerosa del mondo e per la presenza di molte ineguaglianze, vi è, però, una notevole redistribuzione del reddito e una crescita generale di tutte le regioni. E’ chiaro quindi che se la Cina si svilupperà con questo livello di crescita economica continuando a rafforzarsi sul piano militare, fra non molto sostituirà il ruolo del Giappone, potendo insieme all’India costituire il terzo polo che si affiancherà alle attuali superpotenze che dominano l’economia mondiale.
In questo senso la costruzione dell’Europa di Maastricht, viene vista e vissuta dai governi continentali ancor più come la possibilità di costruire un forte polo a caratteri imperialisti da opporre a quello degli USA e asiatico.
L’istituzione dell’Euro è stata giustificata dall’idea di una integrazione europea nel contesto internazionale, con l’obiettivo di creare una stabilità monetaria attraverso una politica monetarista che ha come principale obiettivo il tasso di inflazione e ridurre i deficit pubblici dei paesi appartenenti all’UE. Questo ha provocato, come si è ampiamente visto nelle precedenti puntate dell’analisi-inchiesta, uno smantellamento dello Stato sociale e l’aumento della disoccupazione e la flessibilizzazione e precarizzazione del lavoro, dei salari, dell’intero vivere sociale. Ciò perché per essere in regola con il trattato di Maastricht, ossia per mantenere un determinato rapporto tra PIL e deficit, è fondamentale che il surplus primario si attesti per una decina di anni intorno al 5%; questo è un obiettivo impossibile in tutti i paesi in cui il livello della disoccupazione rimane compreso tra l’11% e il 15%; allora per cercare di rispettare il trattato c’è solo una possibilità: effettuare manovre finanziarie pesanti che però non risolvono il problema ma lo rimandano ed inoltre richiedono enormi sacrifici ai lavoratori, alla popolazione in genere, in special modo alle fasce più deboli.-----
Ed ancora: il trattato di Maastricht si è occupato del problema dell’immigrazione solo per l’ordine e la sicurezza (droga, terrorismo, criminalità); non si vuole, invece, cercare di porre un freno al traffico di manodopera clandestina, allo sfruttamento e al razzismo; non ci si è preoccupati di garantire agli immigrati assistenza sanitaria o legale; quello che è compatibile con il polo europeo della competizione globale è il massimo sfruttamento della manodopera immigrata, come esercito salariale di riserva immediatamente disponibile a condizioni sempre più al ribasso e usabile come massa di manovra per rendere sempre più precarizzata e ricattabile l’intera forza-lavoro, locale e non. Va ricordato che dagli anni ottanta l’offerta di manodopera, ad esempio di Turchia, Marocco e Tunisia è aumentata di oltre 5.800.000 unità; il mercato di lavoro locale di questi paesi ha fornito 2.600.000 posti di lavoro lasciando fuori oltre 3.000.000 di persone.
Va rilevato che la disoccupazione è presente ovunque nei paesi europei; la competizione globale dell’economia e la sfrenata concorrenza, in cui si bada ad aumentare la produttività del lavoro, e del capitale riducendo i costi soprattutto del lavoro sta provocando una riduzione dei salari, dei contributi sociali, della spesa sociale insomma dell’intero Welfare State; la politica dominante il trattato di Maastricht è di assoluto neoliberismo, di puro mercato e al primo posto vi è la crescita del profitto dell’impresa e la trasformazione del Welfare State nel Profit State, nello Stato delle compatibilità d’impresa.
Di questi temi si è già trattato nelle precedenti parti dell’analisi-inchiesta, ne è emerso che la privatizzazione del pubblico impiego, dell’istruzione, della sanità creano nuova precarietà e aumentano i problemi delle fasce più deboli della società, sempre meno garantite, aumentano il differenziale sociale ed economico finalizzando i processi redistributivi sempre più verso il capitale o meglio verso il profitto non reinvestito produttivamente.
E’ necessario ricordare che circa l’85% del reddito mondiale va al 23% della popolazione mondiale; ogni giorno muore un milione di donne a causa di problemi che interessano l’apparato riproduttivo; un miliardo e trecento milioni di persone sono in uno stato di assoluta indigenza dovendo vivere con meno di un dollaro al giorno; 200 milioni di bambini vivono in strada come manovalanza disponibile per la malavita; oltre un miliardo di persone adulte non sa leggere e scrivere; il reddito di oltre il 20% della popolazione mondiale è sceso dal 2,3% all’1,2%, le quote medie di reddito tra le persone più ricche e quelle più povere è cambiato dal 30 a 1 del 1960 al 65 a 1 di oggi.
Se a questo quadro si aggiunge la situazione ambientale dovuta a processi produttivi che non si pongono minimamente nell’ottica di una seria e reale compatibilità socio-ambientale, ci si rende conto della “triste realtà” nella quale viviamo, una triste realtà che si chiama sfrenata competizione globale finalizzata al profitto. Va ricordato infatti, che l’anidride carbonica è cresciuta di oltre il 35% nel ventesimo secolo, la temperatura della superficie terrestre diventa sempre più calda, il buco dell’ozono cresce in misura doppia di quella prevista; ogni giorno circa 150 specie di animali e vegetali sono destinati all’estinzione mentre, dal 1990 ad oggi, ogni anno viene annientata una tribù amazzonica; ogni anno scompaiono 19 milioni di ettari di foreste, delle circa 3000 tonnellate di petrolio estratte ogni anno un milione finisce disperso nel Mediterraneo; la popolazione aumenta di 93 milioni l’anno dei quali 88 sono del Terzo Mondo.
Se si analizzano più da vicino i paesi dell’UE va ancora ricordato che, ad esempio, l’inquinamento delle acque sotterranee (in particolare di nitrati) è più che triplicato in trenta anni e in molti posti si beve acqua con contenuto di nitrati più alto di quello fissato dalle direttive; va poi aggiunto che la metà delle popolazioni dell’UE vive in luoghi che non hanno impianti di depurazione; occorre tenere presente che una quantità considerevole di rifiuti prodotti ogni anno sono nocivi e tossici. Nonostante tutto ciò il trattato di Maastricht non si riferisce molto all’ambiente rimandando soprattutto alle direttive dei singoli Stati membri; quello che si pensa è soltanto che i lavoratori anche sul piano della protezione dagli infortuni e dalla nocività della produzione non siano affatto protetti, anzi anche i lavori cosiddetti a protezione dell’ambiente diventano a forte contenuto precario, non normato ad alto carico di mobilità e flessibilità peggiorando così la protezione del danno per tutti i cittadini.
In sostanza, comunque, dalla firma del trattato di Maastricht non si sono avuti miglioramenti poiché la disoccupazione è cresciuta, lo sviluppo economico rallenta e lo Stato sociale è in crisi, e anzi si trasforma in Profit State, la competizione globale danneggia le condizioni di vita complessive, come si è avuto modo di evidenziare nelle precedenti parti dell’analisi-inchiesta, e tutto ciò non ha portato neppure a sviluppo in termini di assetti macroeconomici capitalistici. Anzi la contrazione della crescita appare chiara se si analizzano i dati di contabilità nazionale , gli indicatori del commercio estero ed altri selezionati indicatori economici di competitività esplicativi dei processi di internazionalizzazione; tali indicatori e aggregati macroeconomici sono stati già evidenziati nelle altre parti dell’analisi-inchiesta e qui di seguito si presentano alcune tabelle di aggiornamento (vedi Tabb. da 1 a 9).
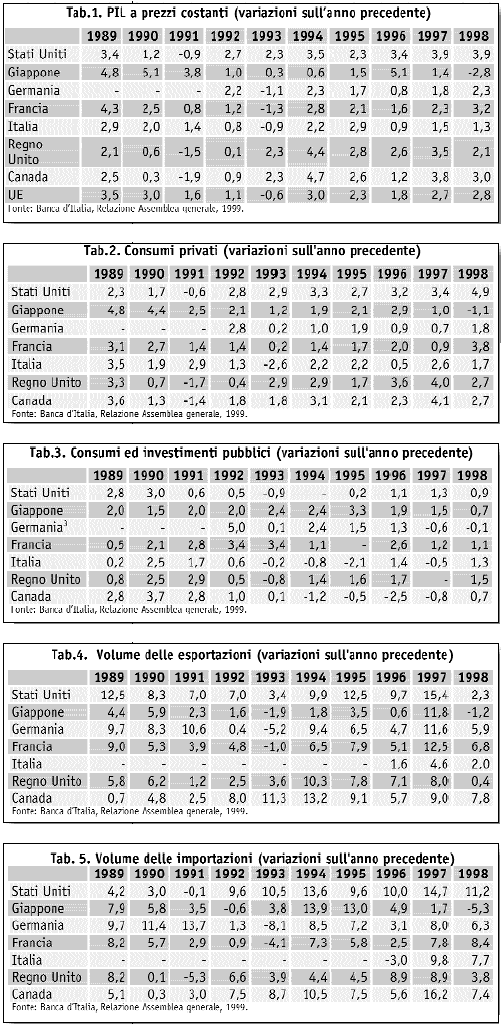
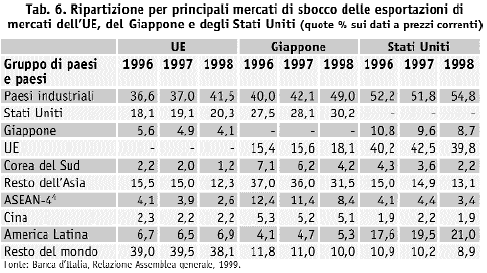
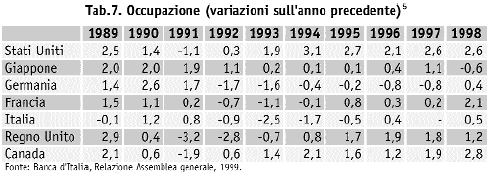

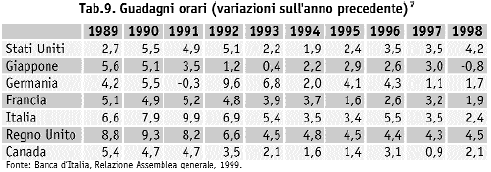
-----
Ma quanto incidono i processi di internazionalizzazione nell’occupazione?
I dati ufficiali della Banca d’Italia evidenziano un netto calo dell’occupazione in Italia, cosa che si nota anche negli altri paesi; è chiaro quindi che i costi degli attuali processi di internazionalizzazione della competizione globale significano riduzione dei costi, in particolare del costo del lavoro, riduzione dei salari, aumento della produttività del lavoro, quindi dello sfruttamento, diminuzione dei posti di lavoro. Le tabelle seguenti evidenziano quanto scritto; va ricordato che il lieve aumento degli occupati registrato negli Stati Uniti va comunque interpretato, in quanto è diverso il modo di rilevamento; in questo paese infatti essendo molto diffusa la flessibilità e la precarizzazione del lavoro si reputano occupati anche coloro che lavorano pochi mesi l’anno; lo stesso si può dire per il Canada; per altre osservazioni si veda la 1a e la 2a parte di questa analisi-inchiesta.
Se si guarda al tasso di disoccupazione per il 1998 di alcuni tra i principali paesi industrializzati ci si accorge subito che l’aumento riguarda tutti con l’eccezione degli USA e del Regno Unito; da evidenziare il 12,3% dell’Italia (vedi Tab. 10).
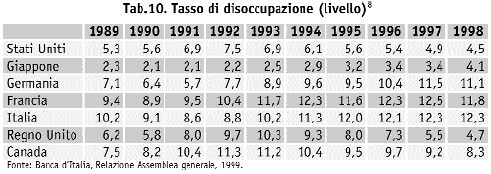
2. I nuovi processi di internazionalizzazione produttiva nella competizione globale post-fordista
La globalizzazione dei mercati è un elemento caratterizzante di questi ultimi decenni; le istituzioni politiche, economiche e culturali devono confrontarsi ogni giorno con questo fenomeno che sta provocando una disgregazione delle culture, dei confini e delle economie nazionali anche perché ha sempre più assunto la forma di competizione globale post-fordista nell’era dell’accumulazione flessibile.
Anche in un’ottica puramente di modalità di sviluppo capitalistico vi sono diversi problemi giuridici , sociali e più direttamente economici legati a questo fenomeno. In primo luogo non vi sono controlli efficaci nel funzionamento dei mercati finanziari in quanto gli operatori possono decidere di spostare ingenti somme di denaro da una parte all’altra del mondo, che in un contesto di deregolamentazione significa agire esclusivamente secondo le proprie esigenze di profitto senza avere nessun controllo politico nè tanto meno strumenti di intervento delle autorità monetarie. Vi sono inoltre effetti devastanti sul modello e sul ciclo produttivo, in quanto vi è sempre maggiore richiesta di risorse specializzate e con un alto livello di immaterialità e flessibilità; le fasi del ciclo più deboli, a basso contenuto di valore aggiunto, quindi, sono escluse, esternalizzate, delocalizzate all’estero alla ricerca di lavoro specializzato, non normato e a basso salario.
I nuovi metodi di comunicazione, veloci e dinamici hanno cambiato le varie politiche di localizzazione e quindi il concetto di distretto ha perso alcune delle sue specificità, prendendo forma di filiere produttive e reti a carattere internazionale.
In questi ultimi anni si sta diffondendo un nuovo concetto nella produzione delle imprese : quello di filiera produttiva. Questo termine sta ad indicare una serie di operazioni di trasformazione che permettono di produrre beni e prodotti in forma diversa rispetto all’epoca fordista-taylorista.
La Scuola Francese di Economia Industriale è stata la prima ad introdurre questo termine per cercare di trovare affinità tra i diversi stadi della produzione in modo da indicare i settori più soggetti alla concorrenza, alla competizione globale e a maggiore contenuto di valore. In una prima visione il concetto di filiera descriveva un ipotetico processo produttivo come diverse operazioni tecniche che accadevano nel corso del tempo; nel passaggio dalle fasi a monte a quelle a valle non deve esserci necessariamente la stessa tecnologia in quanto l’elemento unificante è solo il prodotto trasformato, quindi più che altro in questo modo si identifica una filiera a carattere temporale.
Questa visione semplicistica è stata mutata da alcuni industriali francesi che considerano non soltanto la divisione del ciclo in fasi ma anche l’organizzazione di ciascuna fase e i processi di trasferimento tra le fasi successive. In questo modo si evidenzia il grado di interdipendenza del tessuto produttivo e si descrivono le strategie di integrazione e le forme di organizzazione individuate tradizionalmente nell’impresa, nel mercato e nella cooperazione tra le imprese attraverso accordi di natura commerciale, di subfornitura, di trasferimento di tecnologie, ecc.; si identifica così una sorta di filiera a carattere produttivo di tipo spazio-temporale.
Stigler nel 1951 riprende il teorema sulla divisione del lavoro per dire che, a parità di condizioni, le imprese che operano su mercati limitati assumono in tendenza strutture più integrate, ed arriva alla conclusione che vista la ristrettezza del mercato non vi sono le condizioni per l’esistenza di un unico produttore; le imprese tenderanno quindi ad assumere una struttura integrata [1].
I nuovi mercati sono globali sia nel campo della produzione sia in quello dei capitali, i quali oggi possono essere trasferiti in pochi secondi da una parte all’altra del mondo; si tratta della cosiddetta “globalizzazione finanziaria” che, come si è visto nei numeri precedenti di questa analisi-inchiesta, comunque non assicura investimenti più efficaci, ma diventa fenomeno che si coniuga alle nuove forme di internazionalizzazione produttiva centrati sui processi dell’accumulazione flessibile delle risorse del capitale intangibile, determinando una vera e propria competizione globale internazionale, ma più accesa fra poli imperialistici (in questo momento in particolare fra USA e UE).
Da parte dei diversi organismi istituzionali e legati al mondo imprenditoriale tale nuovo contesto della globalizzazione viene assimilato ad un concetto di libertà ed abbattimento di ogni tipo di barriera economico-sociale in quanto, si sostiene, attraverso gli investimenti, le ristrutturazioni, le alleanze, le acquisizioni e le delocalizzazioni, ci si illude di poter realizzare un’organizzazione d’impresa in grado di occupare aree geografiche e settori di mercato profondamente legati tra di loro, migliorando le condizioni di vita generali della popolazione. Ma come si è visto nelle puntate precedenti dell’inchiesta, questa è, nella migliore delle ipotesi, pura illusione, spesso supportata da trucchi contabili; si tratta in effetti di falsità per far digerire meglio i costi sociali dell’accumulazione capitalistica flessibile post-fordista.
La competizione globale caratterizza questa nuova fase del capitalismo che potremmo riassumere in competizione senza sviluppo e quando c’è sviluppo è senza occupazione e si traduce in “impoverimento assoluto”, imponendo la trasformazione delle classi, delle fasce medie in fasce sempre più marginali della società. Questo fenomeno è strettamente associabile allo sviluppo delle nuove tecnologie soprattutto quelle informatiche e telematiche che permettono aumento di produttività, calo dell’occupazione e processi delocalizzativi in quanto si è sempre più in un contesto produttivo meno legato al posto fisico e al territorio.
I classici criteri di internazionalizzazione diventano così sempre meno efficaci soprattutto a causa dell’ampliamento dell’ambiente imprenditoriale e della sua dinamicità. Ma cosa significa processo di internazionalizzazione?
La crescente internazionalizzazione dei mercati e l’innovazione tecnologica hanno cambiato tutti i sistemi locali di impresa; i vantaggi derivanti dalla localizzazione a distretti, ossia cooperazione, vicinanza dei mercati, circolazione veloce delle comunicazioni, ecc. non sono stati sufficienti a consentire un complessivo vantaggio del sistema.
Il processo di internazionalizzazione è ormai affermato nei mercati come processo di competizione globale per l’impresa sociale generalizzata post-fordista nell’epoca dell’accumulazione flessibile. Infatti escludendo il circuito dei consumi locali e tradizionali, per la stragrande maggioranza dei prodotti ormai non vi è differenza di status o di percezione dei prodotti nazionali e dei prodotti trasnazionali; di solito i prodotti che provengono da altri paesi o sono diretti ad altri paesi vengono trattati allo stesso modo dei prodotti domestici. Le imprese ormai tendono a considerare il mercato interno come una delle parti di un mercato più ampio, articolato in molte unità nazionali: un mercato transnazionale in cui sviluppare la competizione globale in chiave microeconomica come competizione fra imprese e in un’ottica macroeconomica come competizione fra poli imperialisti.
Le imprese comunque sono un asso portante dell’internazionalizzazione in quanto da una parte hanno creato la trasnazionalità e dall’altra ne hanno tratto il massimo beneficio.
Lo sviluppo dell’internazionalizzazione si collega con la crisi del fordismo; infatti la liberalizzazione nei mercati nazionali ha un effetto molto dirompente nella struttura di potere e di equilibrio del fordismo. Da un lato infatti le imprese spinte da una concorrenza internazionale si distaccano dalla protezione pubblica mentre dall’altro lato diminuisce il potere regolatore dello Stato che diventa Profit State Globale.
In pratica quindi l’internazionalizzazione diventa “deregulation” nel quale non vi è una riorganizzazione post-fordista ma una perdita di vecchia organizzazione per realizzare un’organizzazione funzionale all’accumulazione flessibile.
La prospettiva post-fordista non deve avere meno organizzazione ma anzi necessita di un’organizzazione più complessa che deve governare una rete di interdipendenze molto più ampia di quella dell’impresa fordista; deve altresì coordinare il cambiamento che si attua anche sulle risorse del capitale che hanno sempre più valenza intangibile.
Comunque la crescente internazionalizzazione dei mercati e l’espansione del processo di innovazione tecnologica e dell’espansione dell’accumulazione informativa e cognitiva hanno cambiato le strategie e le modalità di crescita tradizionali delle imprese.
Dal punto di vista dell’identificazione delle zone di attività produttiva vi sono due modalità tra loro complementari: il nuovo settore post-fordista e la filiera internazionale. Si parla di settore quando è possibile trovare una certa omogeneità della manifattura oppure se la materia prima impiegata svolge il ruolo di denominatore comune a più cicli produttivi; nella filiera invece non vi è omogeneità tecnologica nelle varie fasi del ciclo e quindi il principio unificante è dato dal prodotto finale trasformato; in questo modo vi è l’acquisizione all’estero di alcune fasi della lavorazione attraverso processi di delocalizzazione produttiva.
Sono tre i momenti che caratterizzano la filiera internazionale:
1) una successione di operazioni produttive svolte in paesi diversi;
2) un raggruppamento di relazioni economiche e finanziarie;
3) un raggruppamento di comportamenti ed azioni economiche.
La filiera internazionale è quindi costituita da una rete di connessioni sia economiche sia tecnologiche che consentono di attuare delle strategie di partnership in ambiti nazionali diversi; un esempio di filiera può essere quello del settore agroalimentare nel quale dalla produzione agricola di base si passa ai settori che fanno la prima lavorazione e che producono il prodotto finito per il consumatore.-----
Oltre alla nuova organizzazione della produzione in filiera in questi ultimi anni si è assistito anche alla nascita dei distretti industriali a carattere internazionale, ossia raggruppamenti di zona nazionali o trasnazionali di aziende integrate tra loro in filiere produttive [2].
I distretti industriali a carattere internazionale non sono da considerarsi sistemi locali nazionali indipendenti, fermi e stabili in quanto attraversano molte tensioni interne; alcuni si sono esauriti, altri si sono adattati. In questa modalità dell’internazionalizzazione produttiva vi possono essere diverse soluzioni funzionali ed organizzative: l’apertura verso l’esterno trasnazionale, la dissoluzione, la ricomposizione e ristrutturazione. Così come per i distretti locali nazionali [3] vi possono essere quindi diversi tipi di distretti a carattere internazionale a seconda del grado di avanzamento tecnologico delle produzioni, dell’età del distretto, della natura dei rapporti fra le imprese, ecc.. Vi è comunque una tendenza che sembra accomunare i vari tipi di distretti, ossia quella della loro trasformazione attraverso la collaborazione offerta da categorie di imprese che diventano un punto di riferimenti e di coagulo di “reti” di imprese. Le imprese dei distretti sono organizzate in modo verticale per operare attraverso economie esterne che permettano di essere competitivi anche con la dimensione ridotta. In questo caso le relazioni strategiche che riguardano l’area commerciale sono di solito al di fuori del distretto e assumono sempre più carattere trasnazionale; l’impresa cerca comunque di controllare le politiche di commercializzazione attraverso forme di gestione associata tra filiali in paesi diversi.
Le relazioni del distretto prevalenti sono monosettoriali mentre quelle necessarie per lo sviluppo delle piccole e medie imprese sono plurisettoriali. Va rilevato che l’entrata di nuovi attori provenienti dall’esterno, specialmente se provenienti da altri paesi, può determinare cambiamenti sulla forma e sul funzionamento del distretto. Un esempio è dato dalle acquisizioni di imprese localizzate nel distretto da parte di imprese esterne al distretto, attraverso anche gli investimenti diretti esteri (IDE), soprattutto se queste imprese sono di grandi dimensioni; in questo caso ci si può trovare davanti a un processo di concentrazione.
Si tratta in sostanza di un processo, anche a carattere internazionale, organizzato verticalmente che può creare non pochi problemi in fase di interdipendenza; ad esempio è difficile capire quali siano i confini tra le varie filiere o tra le subfiliere, speicalmente quando hanno carattere trasnazionale.
In questo caso, quindi, l’obiettivo delle imprese che costituiscono la filiera non è quello di avere la parte maggiore del ciclo produttivo ma di assicurarsi il controllo di una sua parte e nella filiera internazionale ciò avviene attraverso i flussi in entrata e in uscita dei diversi dei paesi degli investimenti diretti esteri (IDE). Ed allora il perno fondamentale delle filiera sta nel suo centro di gravità che in chiave internazionale significa il paese dove è la sede dell’impresa madre. Per arrivare al prodotto finito occorre passare per una serie di operazioni che necessitano a loro volta di un numero sempre maggiore di nuove produzioni (beni intermedi, approvvigionamenti materiali, e sempre più di risorse immateriali imballaggi, ecc.); ognuna di queste fasi richiede la creazione di una nuova filiera specifica con singole imprese riguardanti singole fasi del ciclo produttivo localizzate in paesi diversi; si comprende allora quanto sia importante il perno centrale della filiera che spesso significa paese centrale che deve poter organizzare le filiere intermedie.
Il fenomeno dei distretti e delle filiere internazionali è interessante da analizzare per seguire l’evoluzione e l’andamento del mercato negli ultimi decenni e per interpretare e rappresentare le dinamiche della “delocalizzazione” verso l’estero di attività produttive (maggiormente attività manifatturiere, e di settori di nuove tecnologie, soprattutto informatica). [4]
|
Vi sono molte teorie su questo argomento: ad esempio all’inizio dello scorso secolo, Von Thunen ha analizzato il problema della localizzazione delle strutture agricole ed ha rilevato che queste si posizionano in cerchi concentrici intorno ad una città, in vari terreni posti a distanze diverse da questo centro; ogni agricoltore avrà il massimo profitto producendo, sulla terra posta ad una certa distanza dal centro, la coltura che gli dà il rendimento netto più alto. [5]In seguito Achille Loira [6]ha esplicitato la tesi citata che presiede alla distribuzione delle colture razionale e può essere applicata alle industrie manifatturiere fondando il problema della localizzazione delle imprese nella logica della massimizzazione del profitto. Weber [7]invece ritiene che il costo del prodotto finito, del lavoro, del trasporto e delle materie prime sono i fattori fondamentali di ordinamento delle attività produttive nello spazio e spingono le imprese a localizzarsi vicino a uno o all’altro dei fattori produttivi. Va ricordato che il modello weberiano è caratterizzato tra l’altro dall’as-sunzione di alcune ipotesi semplificatrici quali costi di trasporto proporzionali alla distanza, il costo del lavoro fisso ed un’offerta illimitata di lavoro. Marshall A. invece impernia la sua teoria sulle economie esterne delle quali usufruiscono i piccoli produttori sufficientemente concentrati sul territorio. I vantaggi della produzione su larga scala si possono ottenere sia raggruppando molti piccoli produttori in uno spazio limitato e suddividendo il processo di produzione in diverse fasi (ognuna delle quali può essere attuata in diversi stabilimenti di piccoli dimensioni), sia costruendo pochi grandi impianti con masse di lavoratori. Le economie esterne stabiliscono dei processi di specializzazione spaziale favoriti dalla diminuzione progressiva dei costi di trasporto; fra queste vi sono lo sviluppo del commercio, dei trasporti, la diffusione di capacità e di know-how, la continuità delle innovazioni e delle invenzioni, ecc. In tempi a noi più vicini vanno ricordate le teorie di Wilson e Harris [8] che evidenziano l’importanza dei costi di trasporto, degli investimenti e della produzione settoriale preesistente, mentre diventano meno fondamentali fattori quali i costi delle aree e la densità demografica. |
In sostanza comunque, tra i fattori che influenzano il processo di delocalizzazione vi sono fattori naturali quali la disponibilità del terreno, la disponibilità dell’acqua, i caratteri geologici del terreno, il clima, ecc.; vi sono ancora i fattori tecnici quali la fornitura di energia, l’organizzazione de trasporti, ecc. Vi sono poi fattori demografici: è chiaro infatti che la popolazione è fondamentale per l’impresa sia per la possibilità di reperire manodopera sia per la vendita dei prodotti; è comunque evidente che i fattori di localizzazione più importanti in questa fase dello sviluppo capitalistico post-fordista dell’accumulazione flessibile sono quelli più direttamente di natura economica ossia capitale libero di circolare là dove è più alto il profitto atteso e minori le forme di tassazione, dove è più specializzato il lavoro, meno pagato e meno normato, dove sono facilmente fruibili in termini produttivi e di controllo l’informazione e le risorse del capitale intangibile. Il capitale finanziario è portato a localizzarsi dove lo sviluppo è consolidato per ridurre al minimo il rischio; anche il lavoro agisce come fattore di localizzazione anche se in modo diverso a seconda del tipo di industria; da un lato infatti per le industrie tradizionali e le produzioni standardizzate la necessità del controllo spinge le localizzazioni in aree periferiche internazionali che si caratterizzano per lavoro a basso costo e non regolamentato; dall’altro lato invece le industrie innovative hanno bisogno di maggiore autonomia e di una più alta qualificazione del lavoro, quindi le localizzazioni si indirizzano verso aree a volte più centrali, ma che comunque offrono un mercato del lavoro molto specializzato e ad alto contenuto di flessibilità.
Le imprese sono portate a delocalizzare la propria attività produttiva sia per penetrare in nuovi mercati che hanno a disposizione manodopera a basso costo, sia per acquisire nuove competenze tecniche sia per avere accesso a materie prime a prezzi più bassi.
Negli ultimi anni comunque, dopo un periodo di alta concentrazione delle attività produttive, è iniziato un processo di decentramento che partito dagli Stati Uniti è arrivato in Europa e anche nel nostro Paese e che va ad interessare paesi periferici ma molto più vicino al centro del processo, ad esempio l’Italia e l’Europa che delocalizzano sempre più verso l’Europa Balcanica e Centro-Orientale interessandosi fortemente ai mercati euroasiatici.-----
In questo senso le imprese di piccola e media dimensione sono diventate le protagoniste di un sistema di “specializzazione flessibile” con un modello alternativo a quello della grande produzione di massa, coniugando la ricerca di risorse e materie prime, di lavoro specializzato e a basso prezzo e di disponibilità immediatamente fruibile di forti concentrazioni di risorse del capitale intangibile.
Il decentramento produttivo costituisce in sostanza un fenomeno opposto alla concentrazione territoriale della produzione e quindi l’abbandono delle aree più centrali demandando a queste l’assemblaggio produttivo e il comando del ciclo, poichè il decentramento è anche una deconcentrazione tecnica con conseguente scomposizione dei cicli produttivi.
Ed è proprio a seguito di questi fenomeni di decentramento che si è arrivati a parlare di delocalizzazione attraverso le dinamiche degli IDE che riguardano l’acquisizione e trasferimento all’estero di alcune fasi della produzione, di interi stabilimenti, di investimenti tecnici-materiali e di natura immateriale. Queste acquisizioni e trasferimenti possono avere carattere temporaneo nel caso in cui vengano trasferiti semilavorati che poi saranno reimportati dopo alcune fasi di lavorazione, ma comunque si tratta sempre di delocalizzazioni di natura produttiva e non commerciale.
Se si considerano, in generale, i livelli degli Investimenti Diretti Esteri (IDE) va rilevato che negli ultimi anni hanno raggiunto dei livelli molto elevati; basti pensare che i flussi in uscita hanno registrato un incremento del 27% tra il 1996 e il 1997 arrivando quasi a 425 miliardi di dollari. (Cfr. Tab.11)
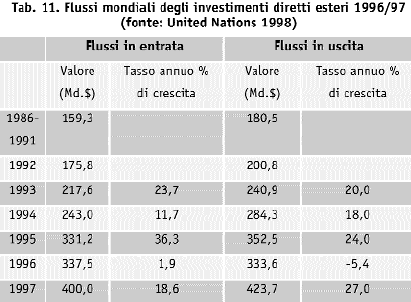
Va evidenziato che la crescita media annua si è mantenuta nel corso degli anni novanta al di sopra del livello del PIL, delle esportazioni e degli investimenti interni lordi. Le Tabb.12,13,14 e 15 evidenziano che le economie dei paesi industrializzati nel 1997 hanno investito oltre il 90% del totale dei flussi degli IDE a livello mondiale e ne hanno catturato oltre il 60%. Va rilevato che Stati Uniti, Giappone e UE assorbono l’83,5% dei flussi in entrata e l’83,7% di quelli in uscita; è importante raffrontare gli IDE in termini di flussi e di stock con alcuni selezionati indicatori economici per individuarne il peso macroeconomico relativo.
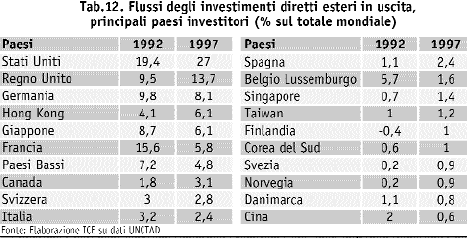
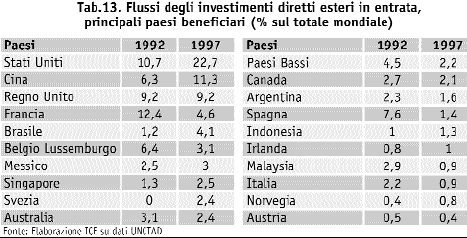
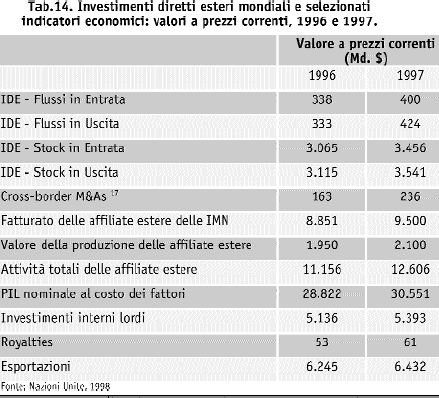
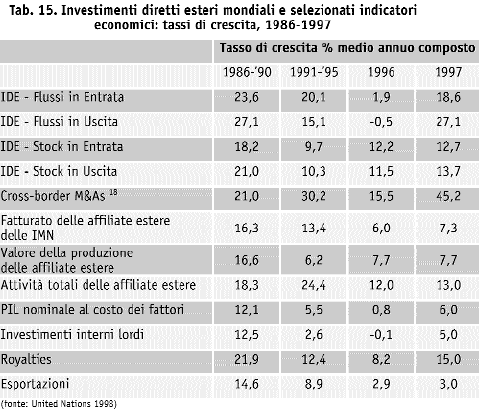
La Tab. 16 evidenzia i flussi degli IDE per aree
economiche negli anni 1992-1997; si nota con immediatezza che Giappone, Stati
Uniti e Regno Unito hanno avuto valori molto elevati soprattutto nel 1997 dei
flussi in uscita (rispettivamente 26 miliardi di dollari il Giappone, 115 gli
USA e 58 il Regno Unito); da evidenziare il dato relativo ai Paesi in Via di
Sviluppo: dal 1992 al 1997 sono passati da un valore di 21 ad un valore di 61;
hanno cioè triplicato gli IDE in uscita. Anche se si guardano gli IDE in entrata
si evidenziano forti incrementi per USA, UE, Cina e per i Paesi in via di Sviluppo
che sono passati da 51 a circa 150 miliardi di dollari nel 1997.
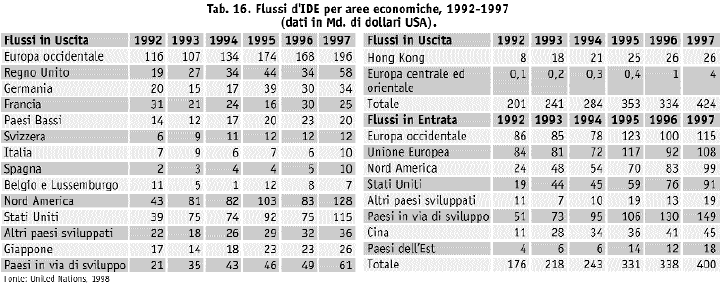
Gli IDE dei paesi europei sono molto cresciuti in questi anni ; la tabella evidenzia ancora che soprattutto nel 1997 si è avuto un aumento degli IDE verso i paesi dell’Europa centrale ed orientale ( o paesi dell’est).
Nei successivi Prospetti da 1 a 10 si può seguire l’andamento degli IDE rispettivamente da e verso gli altri singoli paesi per i diversi paesi considerati (USA, Giappone e Germania) e il totale per paese (Regno Unito, Francia, Giappone, Germania e Stati Uniti). [9]
Nel parlare di internazionalizzazione inoltre occorre innanzitutto distinguere tra l’orientamento al commercio internazionale e quello al marketing internazionale; mentre il primo corrisponde alla cosiddetta “internazionalizzazione passiva”, il secondo corrisponde all’”internazionalizzazione attiva”. [10]
Passando ora ad esaminare il ruolo del commercio estero va evidenziato che mentre gli Stati Uniti negli ultimi 15 anni hanno avuto una energica crescita economica che ha causato un esteso deficit commerciale, i paesi dell’Unione Europea hanno mantenuto il loro ruolo di prima potenza esportatrice. Questi due elementi hanno provocato un contrasto commerciale sempre più aspro tra Europa e America, contrasto che si individua soprattutto nelle importazioni dei prodotti agricoli. La maggior parte degli scambi commerciali dei paesi dell’UE avviene soprattutto a livello intra-area; gli Stati Uniti comunque rappresentano ancora il principale partner commerciale, mentre si è avuto un incremento del commercio con i paesi dell’Europa Centro-Orientale, del Medio Oriente e dell’America Latina.-----
Se si analizzano i movimenti commerciali degli ultimi 30 anni ci si accorge se ci si riferisce alle esportazioni, che l’Unione Europea scende del 4,3% tra il 1965 e il 1998 della quota del commercio mondiale anche se mantiene una posizione di preminenza con il 15% del totale. Gli USA passano dal 17,1% del 1965 al 12,2% nel 1998 mentre il Giappone che fino al 1985 ha registrato una crescita fino al 9,5% a partire dal 1993 ha cominciato a scendere fino ad arrivare nel 1998 al 7,1% del totale (cfr.Tab.17 pagina seguente).
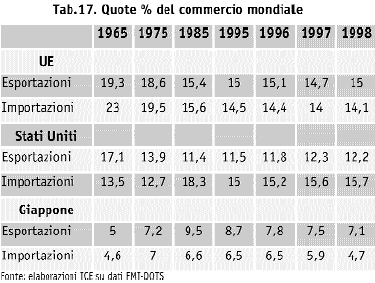
Per quanto riguarda le importazioni invece i paesi dell’Unione Europea passano da una quota del commercio mondiale totale del 23% nel 1965 al 14,1% nel 1998; gli Stati Uniti fra incrementi diversi passano comunque dal 13,5% del 1965 al 15,7% del 1998, mentre il Giappone che nel 1965 si attestava su un 4,6%, dopo una iniziale crescita (nel 1985 era arrivato al 6,6%) scende di nuovo e nel 1998 registra un 4,7%.
E’ importante anche mostrare le esportazioni e le importazioni dell’Unione Europea per aree geografiche (escluso il commercio intra-area). La Tab.18 evidenzia che i principali partner commerciali dell’UE sono gli Stati Uniti cui fa seguito il Giappone e la Svizzera, anche i paesi dell’Europa orientale rappresentano una quota significativa mentre sempre più importante diventa il ruolo dei Paesi in Via di Sviluppo.
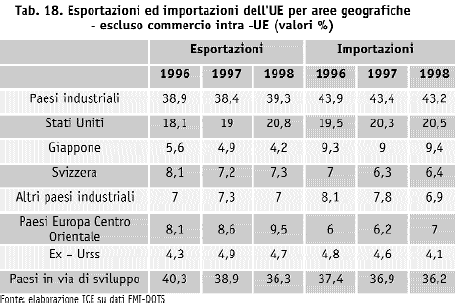
La Tab.19 evidenzia che oltre il 50% delle esportazioni e quasi i due terzi delle importazioni italiane sono da imputare al mercato europeo.
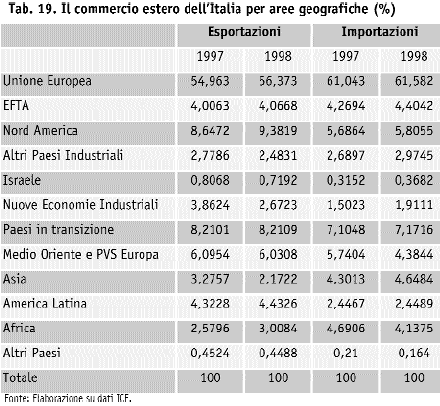
E’ interessante ora analizzare i principali paesi verso i quali sono rivolte le esportazioni e le importazioni italiane (vedi Tabb. 20, 21); si nota immediatamente che più del 50% dei rapporti commerciali (sia di export sia di import) del nostro paese sono tenuti con Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Stati Uniti e Regno Unito, mentre risultano poco rilevanti i rapporti con i paesi asiatici.
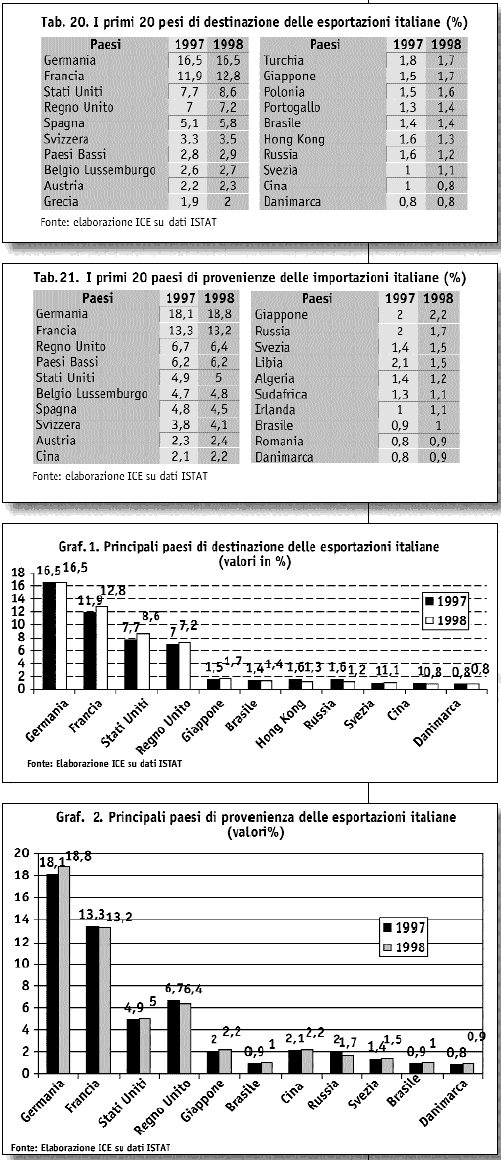
Se si analizza più da vicino la situazione del nostro Paese va evidenziato che nel 1998 gli esportatori italiani sono stati più di170.000 di cui 160.000 specializzati nel commercio di manufatti. Gli addetti delle aziende esportatrici sono stati nel 1996 circa 4.600.000 (quasi un terzo dell’intera occupazione interna nei corrispondenti settori di attività; inoltre più del 92% è rappresentato da piccole imprese (ossia con meno di 50 addetti), che incidono per il 32% in termini di occupati, il 7% sono medie imprese (da 50 a 249 addetti), con una percentuale del 22% sugli occupati e solo lo 0,5% da imprese grandi, che però incidono per il 46% degli occupati. Va rilevato che nel 1998 le esportazioni e la produzione delle partecipate estere ha rappresentato oltre 600.00 miliardi di lire, valore che si è quasi raddoppiato rispetto al 1991. La crescita del numero di esportatori negli anni novanta è supportato dall’aumento del ricavo medio all’esportazione, che va da 1,3 a 2,4 miliardi di lire tra il 1992 e il 1998; dalla minore rilevanza dei micro-esportatori; dall’aumento del numero di esportatori stabili (ossia non episodici), e dalla migliore diversificazione geografica delle attività delle aziende esportatrici che hanno esteso la loro presenza a paesi dell’Africa, del Medio Oriente e dell’America Latina. Le imprese esportatrici risultano essere collocate per il 69% nell’Italia settentrionale, per il 19% nell’Italia centrale e solo per il 12% al Sud (va rilevato che negli anni 1994-1998 si è avuto un aumento della quota del Mezzogiorno dell’1,7% e dello 0,5% al Centro.
Il Graf.1 invece evidenzia i principali paesi di destinazione delle esportazioni italiane; si nota immediatamente che i paesi maggiormente interessati sono la Germania, la Francia e gli Stati Uniti; tra gli ultimi invece si collocano la Cina, la Svezia e la Danimarca.
D’altro canto se si esamina la situazione dal versante opposto (cfr. Graf.2) ci si accorge che le aziende che di più esportano in Italia sono soprattutto di paesi quali Germania, Francia e Regno Unito, che insieme negli anni 1997, 1998 interessano circa il 38% del totale delle importazioni in Italia.
Continuando l’analisi delle dinamiche di internazionalizzazione per l’Italia va rilevato che vi è un coinvolgimento sempre maggiore delle piccole e medie imprese nel processo di competizione globale produttiva; le imprese minori, infatti, soprattutto negli anni ‘90, per il continuo estendersi del fenomeno della liberalizzazione e globalizzazione dei mercati, hanno visto crescere molto la loro quota di gli investimenti diretti esteri (IDE).-----
Va considerato che quasi i tre quarti delle multinazionali italiane con attività produttiva all’estero è rappresentato da imprese di piccole e medie dimensioni, anche se in termini di addetti totali all’estero il loro contributo è del 13,5% e in termini di imprese estere partecipate è del 37% (dati relativi al 1997). A conferma di ciò si ricorda che negli anni tra il 1990 e il 1996 il numero delle imprese di piccola e media dimensione che ha esteso la propria attività a livello internazionale è aumentato di due volte e mezzo. La gran parte di queste imprese concentra la propria attività nei settori specialistici quali quelli della elettronica e meccanica strumentale oppure in settori tradizionali quali metallo, tessile, cuoio, calzature e prodotti in legno.
Se si esamina la destinazione geografica va detto che le piccole e medie imprese italiane si sono indirizzate soprattutto verso i paesi dell’Europa Centrale ed Orientale; le grandi imprese multinazionali invece si sono orientate più verso i paesi dell’Europa Occidentale e del Nord America.
Ed ancora : la distribuzione geografica delle imprese multinazionali italiane è molto polarizzata; le piccole e medie imprese italiane con partecipazioni estere, infatti, appartengono per oltre l’80% all’Italia settentrionale a fronte di un 15 dell’Italia centrale e di un 5 dell’Italia Meridionale. (Cfr. Tab.23)
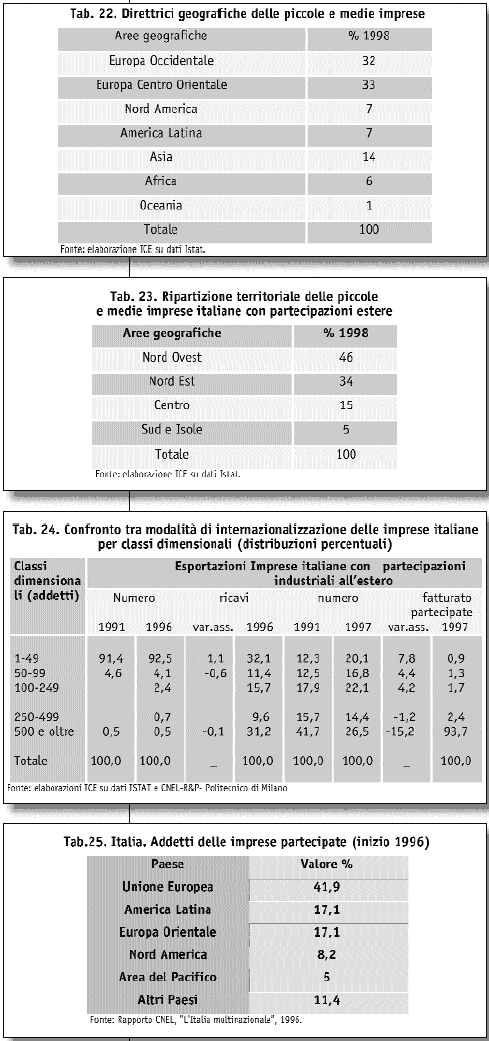
E’ interessante poi confrontare dal punto di vista delle dimensioni aziendali le imprese italiane che hanno realizzato IDE nell’industria e imprese esportatrici che appartengono ai settori dell’industria e dei servizi. (Cfr. Tab.24)
Di solito sono più interessate a processi di delocalizzazione le imprese con dimensioni medio-grandi; il nostro Paese si indirizza in questo processo soprattutto verso i paesi dell’Unione Europea, l’America Latina e l’Europa Orientale; la Tab.25 che indica la percentuale degli addetti delle imprese partecipate infatti, dimostra quanto scritto precedentemente.
Va rilevato poi che il nostro Paese si caratterizza per le specializzazioni settoriali nei comparti tradizionali (soprattutto manifatturiero, quali tessile, abbigliamento).
Il Traffico di Perfezionamento Passivo (TPP), (ossia l’esportazione momentanea di parti del prodotto in un altro paese affinché sia lavorato e poi reimportato) nel settore manifatturiero consente di trarre un vantaggio dal costo basso della manodopera; si ricorda che la Comunità Economica Europea dal 1975 ha permesso ai paesi che effettuano un TPP vari benefici tariffari per agevolare questo processo.
Una ricerca dell’Eurostat ha rilevato che, ad esempio, negli anni 1988-93 l’Italia in particolare ha avuto una rapida evoluzione di importazioni in traffico di perfezionamento passivo nell’abbigliamento (si è passati da uno 0,4% del 1988 al 9,4% del 1993).(Cfr. Tab.26)
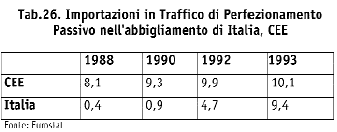
Si è già detto che nel nostro Paese sono state soprattutto le imprese medio-grandi ad avviare un processo di delocalizzazione produttiva internazionale anche con carattere di filiera; le piccole imprese, infatti, per quanto riguarda i settori tradizionali hanno quasi sempre seguito le grandi aziende e si sono indirizzate soprattutto verso i paesi dell’Europa Orientale; i settori di alta tecnologia invece offrono maggiori opportunità alle imprese medio-piccole.
Risulta che le imprese italiane che hanno realizzato IDE nell’industria a fine 1997 erano per due terzi di grandi dimensioni (ossia con più di 250 addetti) mentre più del 92% delle imprese esportatrici era nel 1966 di dimensioni piccole; oltre il 40% delle esportazioni era controllato da grandi imprese con un valore del 96% del fatturato da IDE. Se si considerano invece le aziende che hanno avviato delle attività produttive all’estero (controllate totalmente o in partecipazione con altri) si nota che dal 1991 il numero delle multinazionali è cresciuto di oltre il 60%; questa crescita è stata facilitata dal coinvolgimento di imprese di piccole e medie dimensioni anche se va rilevato che l’incidenza delle grandi rimane prevalente in quanto ad esse è possibile riferire più del 67% del totale delle partecipazioni estere, il 96% del fatturato totale estero e l’88% dei relativi addetti.
La distribuzione geografica degli investimenti ha visto una quota di oltre il 42% delle imprese partecipate nell’Europa Occidentale; vi è poi l’Europa Orientale con una quota del 20%, l’Asia con il 13%, l’America Settentrionale con il 10% e l’America Latina con l’8%. (Cfr. Graf. 3)
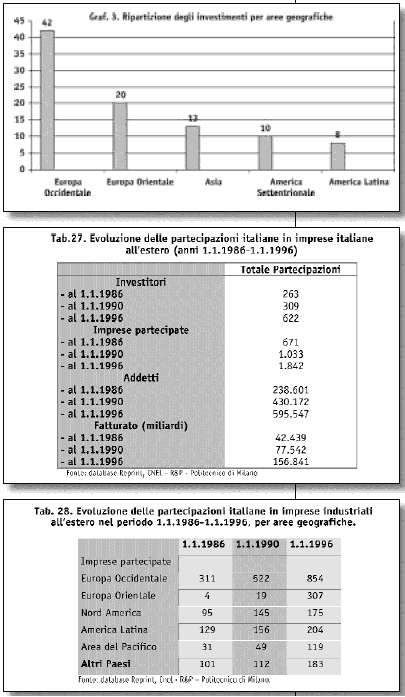
E’ interessante ora mostrare alcuni dati ricavati da una ricerca effettuata dal CNEL nel 1997. La Tab.27 che segue evidenzia la dinamica evolutiva delle imprese italiane con almeno uno stabilimento produttivo all’estero: si nota, infatti, che nel 1996 vi sono 622 imprese che hanno partecipazioni in 1842 imprese industriali estere, hanno un fatturato di 156.841 miliardi di lire e occupano 595.547 addetti.-----
Le imprese italiane partecipate dall’estero sono invece 1.630, con l’intervento di 966 investitori esteri; il fatturato al 1995 delle imprese partecipate è stato di 212.000 miliardi di lire mentre il numero degli addetti è stato di 527.000 unità.
Se si esamina la distribuzione geografica delle partecipazioni italiane all’estero si nota che mentre dalla seconda metà degli anni ottanta fino al 1992 l’espansione delle imprese italiane si è indirizzata verso l’Europa Occidentale seguita dal Nord America, a partire dal 1993 si è avuto un forte incremento degli investimenti in Europa Orientale, in America Latina e nell’area del Pacifico.
3. Ancora sulla concentrazione
Come si è già scritto in più punti delle precedenti parti dell’analisi-inchiesta i due grandi sistemi di capitalismo internazionale sono rappresentati dal cosiddetto modello renano (i cui principali esponenti sono il Giappone e la Germania) e dal modello anglosassone (Stati Uniti e Gran Bretagna). Tra le molte differenze esistenti tra questi due modelli è fondamentale nuovamente sottolineare quella inerente il diverso grado di concentrazione proprietaria. Infatti mentre il modello renano si caratterizza per la presenza di imprese che hanno a capo un soggetto (spesso bancario) che ha in mano uno stock di azioni molto elevato (nocciolo duro), nel modello anglosassone vi sono soggetti che molto di rado hanno più del 5 % del capitale e quindi la proprietà delle imprese risulta essere molto diffusa (Public Company) [11]. Va ancora ricordato che mentre nel modello renano le banche assumono un ruolo principale poiché sono in sostanza i soggetti che detengono il potere aziendale sia attraverso una proprietà diretta sia attraverso una concentrazione dei diritti di voto, invece, nel modello anglosassone i livelli di concentrazione sono molto bassi e quindi rivestono un ruolo predominante i fondi pensione, i fondi di investimento, con solo apparenti forme di democrazia economica attraverso l’azionariato diffuso.
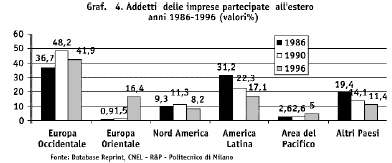
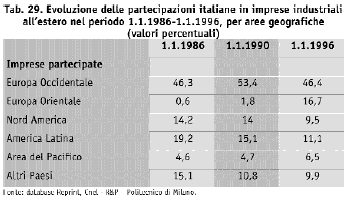
Di seguito si mostra come, ad esempio, in Germania il livello medio di concentrazione C1 [12] arriva al 61,5% mentre è molto inferiore per gli Stati Uniti e la Germania (cfr. Tab.30).
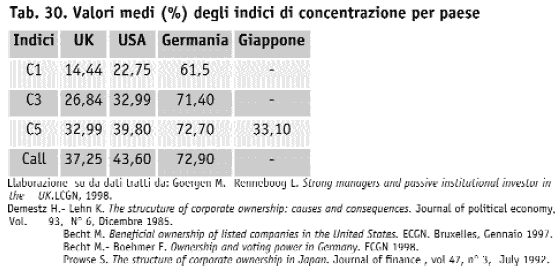
E’ importante sottolineare fino a che punto e in che modo le aziende sono “concentrate” nelle mani di pochi e quanto incide la proprietà di un’impresa; per far ciò va rilevato in primo luogo che vi sono cinque tipi di proprietari:
1) una famiglia o un soggetto individuale;
2) lo Stato;
3) un’istituzione finanziaria;
4) un’impresa;
5) una insieme misto (o miscellanea) ossia cooperative o patti di voto, ecc.
E’ stato evidenziato molto spesso che vi è una netta separazione tra proprietà e controllo di un’impresa, in quanto sempre più nel modello post-fordista i proprietari di un’azienda non sono nella condizione di esercitare i propri diritti; questo avviene sia quando la proprietà si dimostra disinteressata sia quando il frazionamento delle azioni è così diffuso da rendere difficile la costituzione di un gruppo di controllo.
La Tab.31 evidenzia molto chiaramente le varie tipologie di concentrazione proprietaria.
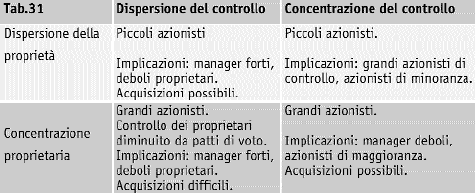
Ed ancora se si guarda al Graf.5 seguente ci si accorge che nel modello di Public Company si hanno valori di concentrazione proprietaria dello 0,4% per il Canada, dello 0,18% per l’Australia e di appena lo 0,2% per la Gran Bretagna e lo 0,19% per gli Stati Uniti. Questi paesi sono caratterizzati da un mercato azionario molto veloce, da un’alta liquidità e da una legislazione che pur dichiarando di tutelare i piccoli azionisti di fatto favorisce i processi di finanziarizzazione dell’economia con la diffusione azionaria a favore dei diversi tipi di fondi di investimento.
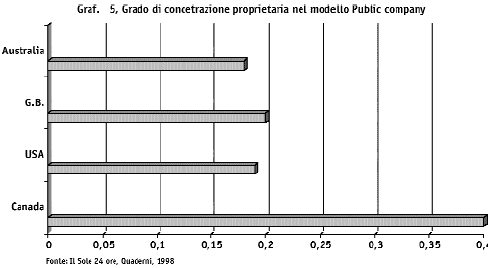
La Tab.32, invece, analizza un altro gruppo di paesi che si caratterizzano per la struttura proprietaria basata sul modello di gruppo; è facile notare le differenze rispetto alla prima fascia di paesi più portati a preferire la struttura delle Public Company (per gruppo si intende “un’aggregazione di imprese costituite in forma societaria legate fra loro da relazioni di controllo). [13]
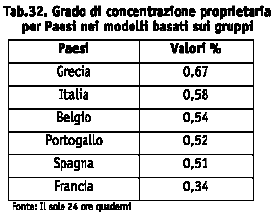
Ma è altresì chiaro che “sul piano formale il gruppo è una forma giuridico-organizzativa alla quale i soggetti imprenditoriali possono far ricorso per dar vita alle proprie iniziative produttive; sul piano sostanziale si tratta di uno strumento per mobilitare e impiegare capitale” [14]
I gruppi si distinguono in gruppi patrimoniali, nei quali la capogruppo gestisce solo il portafoglio e non esercita un’influenza sulle singole società e gruppi finanziari nei quali la capogruppo gestisce le strategie delle altre imprese e ne coordina le attività; vi sono infine i gruppi industriali ed imprenditoriali nei quali la capogruppo cerca il modo migliore per coordinare le attività delle altre imprese e le influenza nelle loro strategie.-----
Ed ancora è interessante analizzare la Tab.33 che mette a confronto le strutture proprietarie di alcuni paesi; dall’esame dei dati si rileva facilmente il ruolo fondamentale che rivestono i fondi pensione in Gran Bretagna e negli Stati Uniti (nel primo paese il 50% delle azioni e negli Stati Uniti il 28%); in Italia e in Francia invece rivestono un ruolo preminente le grandi famiglie (rispettivamente il 50 e il 19%); anche in Germania la proprietà è in mano alle grandi famiglie per il 15% mentre in Giappone per il 24%.
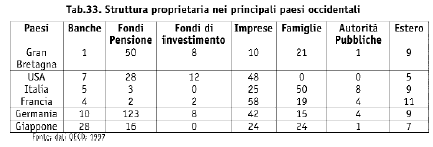
Se si analizza la Tab.34 si nota che circa il 36% delle grandi imprese nel mondo è a proprietà diffusa, il 30% appartiene a famiglie; il 18% appartiene allo Stato e il rimanente 16% è suddiviso nelle altre categorie. Va evidenziato che in base ai dati del 1998 solo lo 0,5% delle aziende è gestito dalle agenzie assicurative o dalle banche. Ed ancora: mentre per gli Stati Uniti e in Gran Bretagna l’azienda a proprietà diffusa rappresenta circa l’80%, in Italia la percentuale è del 20% mentre lo Stato detiene il 40% della proprietà e le famiglie il 15%. Si nota una notevole differenza tra i due gruppi di paesi relativamente al numero di imprese a proprietà diffusa in quanto mentre i valori del primo gruppo sono del 48% per i secondi si scende al 27%.
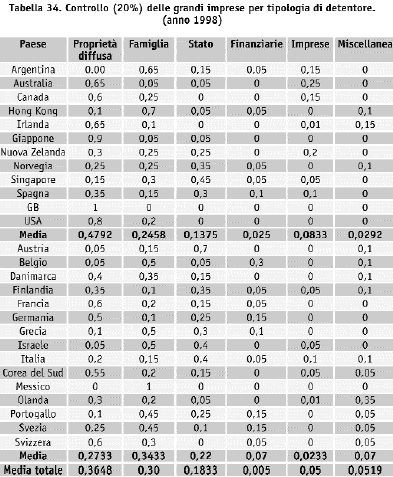
Se si analizza la struttura della concentrazione secondo una definizione di controllo più “leggera”, ossia controllo del 10%, la situazione è allora deducibile dalla Tab.35. Si nota subito che in questo caso i valori percentuali riferiti alle imprese a proprietà diffusa scendono al 24% mentre gli altri valori si attestano su percentuali simili alle precedenti. Nel nostro Paese la percentuale delle aziende a proprietà diffusa scende al 15%.
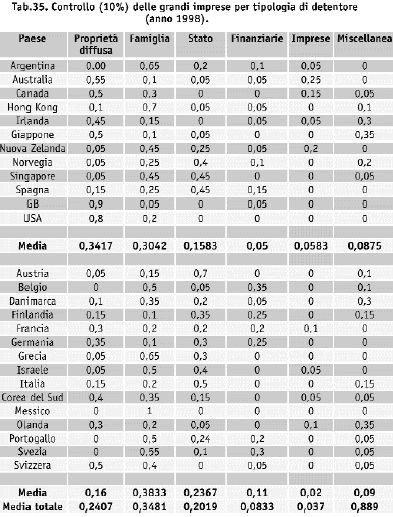
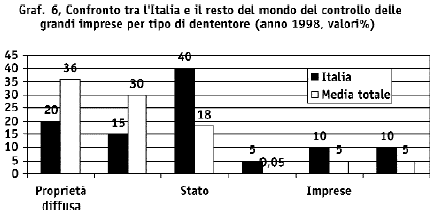
Va rilevato che persiste la differenza tra i due gruppi di paesi relativamente al numero di imprese a proprietà diffusa, in quanto mentre i valori del primo gruppo sono del 34% per i secondi si scende al 16%.
Se si esamina invece la situazione delle imprese medie ci si accorge che in questo caso per il 45% la proprietà è gestita dalle famiglie; se si guarda l’Italia ci si accorge che circa il 60 % delle imprese è in mano alle famiglie poichè in sostanza non ci sono imprese medie a proprietà diffusa o che sono gestite dallo Stato (cfr. Tab.36).
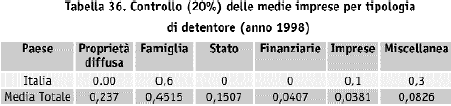
In Italia in sostanza le famiglie risultano essere i soggetti proprietari più presenti nelle aziende mentre le imprese a proprietà diffusa sono quasi inesistenti poichè di solito sono presenti in quei paesi nei quali è più alta la protezione degli azionisti e in cui la scelta da anni è stata effettuata verso un peso determinante del sistema finanziario; ancora, in Italia, le finanziarie, le banche non hanno un ruolo prevalente mentre le aziende a controllo statale sono ancora molto diffuse, così come è superiore alla media il controllo tramite le altre imprese private e il controllo di insieme misto (o miscellanea).
-----
BibliografiA
AA.VV., Il giusto lavoro per un mondo giusto. Dalle 35 ore alla qualità del tempo di vita. Interventi di: Luigi Vinci, Fausto Bertinotti, Ken Coates, Jean-Marie Martin, Salvador Jové, Helmut Schauer, Sergio Bologna, Mario Agostinelli, Dini Greco, Andrea Fumagalli, Giorgio Lunghini, Giovanni Mazzetti, Samir Amin, Giorgio Nebbia, Gianfranco La Grassa, Carla Ravaioli, Costanzo Preve, Alfonso Gianni, Mimmo Porcaro. Ed. Punto Rosso.
AA.VV., La mondializzazione capitalistica nell’epoca presente. Interventi di: Samir Amin, Jorge A. Calderòn Salazar, Josè Luiz Del Roio, Fausto Bertinotti. Ed. Punto Rosso.
AA.VV., Contro Maastricht. Una nuova prospettiva per il vecchio continente. Interventi di: Farid Adli, Bruno Amoroso, Pietro Barcellona, Heinz Bierbaum, Massimo Cacciari, Francois Chesnais, Philippe Herzog, Emilio Molinari, Manuel Monereo, Manfred Muller, Luigi Vinci, Fausto Bertinotti. Ed. Punto Rosso.
AA.VV., United states patterns of ownership and control: the emergence of fiduciary capitalism. 1996
AA.VV., Introduzione alla conferenza dell’ European Corporate Governance Network. Bruxelles 1997.
Arcaini E., PMI milanesi e internazionalizzazione produttiva, da Impresa & Stato n.35.
Barbetta G.P. - Piga C. - Vivarelli M., Il fenomeno dei gruppi d’imprese in Italia. Mediocredito Centrale, Roma 1996.
Barca F., Allocazione e riallocazione della proprietà e del controllo delle imprese: ostacoli, intermediari e regole. Temi di discussione n°194, Banca d’Italia, Roma 1993.
Barca F. - Casavola A.P.- Perassi M., Controllo e gruppo tutela economica e natura giuridica. Temi di discussione n°201, Banca d’Italia, Roma 1993.
Barca F. - Magnani M., L’industria tra capitale e lavoro, Il Mulino, Bologna, 1992.
Becattini G. (a cura di), Mercato e forze locali: il distretto industriale, il Mulino, Bologna, 1987.
Becht M.- Boehmer E., Ownership and voting power in Germany. ECGN, Bruxelles 1998.
Becht M., Beneficial ownership of listed companies in the United States. ECGN. Bruxelles, Gennaio 1997.
Becht M., Corporate ownership and control: The european experience. ECGN, Bruxelles 1997.
Becht M. - Roell A., Blockholdings in Europe: an international comparison. Working paper 1998.
Becht M., Introduction to ECGN conference, Ottobre 1998.
Bellon B., La filiera di produzione, da Economia e politica industriale N.42 1984.
Bettalle L., Delocalizzazione e integrazione della filiera: il caso del tessile / abbigliamento in Italia, da Results Vol. 4 N. 3 1995.
Bianco M., Il controllo nelle public-company. Temi di discussione n°195, Banca d’Italia, Roma 1993.
Bianco M.- Signorini P.E., Evoluzione degli assetti di controllo: gli investitori istituzionali. Temi di discussione n°243, Banca d’Italia, Roma, Dicembre 1994
Camagni R., De Blasio G., Le reti di città: teoria, politiche e analisi nell’era padana, Angeli, Milano, 1983.
Caracciolo Lucio Euro No. Non morire per Maastricht. Ed. Laterza.
Cardilli D.- Pinzani L.- Signorini P.E., Mercato ed istituzioni della riallocazione proprietaria in Germania, Regno Unito e Francia. Temi di discussione n°197, Banca d’Italia, Roma, Maggio 1993.
Chiri S:- Panetta F., Privatizzare: come? Spunti da una ricognizione comparata dei casi inglese e francese. Temi di discussione n°198, Banca d’Italia, Roma, Maggio 1993.
CNEL, Rapporto 1998; l’Italia multinazionale.
Conti G. - Merghinello S., Modelli di impresa e di industria nei contesti di competizione globale: l’internazionalizzazione produttiva dei sistemi locali nel made in Italy, da L’industria N.2 1998.
Conti Vittorio - Hamaui Rony, Operatori e mercati nel processo di liberalizzazione, Mulino, Bologna 1990.
Costa P., I fondamenti della teoria di localizzazione industriale: il contributo di Achille Loira, in Cappellin R., L’evoluzione delle strutture economiche regionali, Franco Angeli, Milano, 1986.
Cristaller W., Die Zentraler Orte in Suddentshland, Fischer Verlag Ed., Jena 1933; traduzione italiana Le località centrali della Germania meridionale, Franco Angeli, Milano 1980.
Del Colle E., Le Aree Produttive Struttura economica dei sistemi regionali in Italia, ed. Franco Angeli, 1997.
Demestz H.- Lehn K., The strucuture of corporate ownership: causes and consequences. Journal of political economy, Vol. 93, N° 6, Dicembre 1985.
De Nardis S. - Malgarini M., Cambiamento, stabilità, rafforzamento, i vantaggi comparati dei paesi europei nell’era della globalizzazione, ICE Area Studi, Statistica e documentazione, Quaderni di ricerca N.8, Novembre 1998.
Di Bernardo B. - Rullani E., Il management e le macchine: teoria evolutiva dell’impresa, Mulino, Bologna 1990.
Forti A. - Silva F., Deindustrializzazione e delocalizzazione, da La ricostruzione industriale: settimo rapporto CER/IRS sull’industria e la politica industriale italiana, 1995.
Franks J.- Mayer C., Corporate control: a synthesis of the international evidence. London Business School and City University Business School, 1992.
Franks J.- Mayer C., German capital markets, corporate control and the obstacles to hostile takeover: lesson from three case studies. London Business School and City University Business School, 1993.
Frank J.- Mayer C., Corporate ownership and control in the UK, Germany and France. Journal of applied corporate finance. 1997, vol. 9, n°4.
Gilson J.R.-Roe M., Understanding the japanese keiretsu: overlaps between corporate governance and industrial organization. The institutional investor project, New York 1993.
Gobbo F., Distretti e sistemi produttivi alla soglia degli anni ’90, Franco Angeli, Milano 1989.
Grandinetti R. - Rullari E., Impresa transnazionale ed economia globale. ED. NIS 1997 Assetti proprietari e mercato delle imprese. Vol. I, II. Ed. il mulino 1995.
Grandinetti R. - Rullari E., (a cura di) Impresa transnazionale ed economia globale. Nis 1997
Goergen M.- Renneboog L., Strong managers and passive institutional investor in the UK. ECGN, Bruxelles 1998.
Goergen M.-Renneboog L., Prediction of ownership and control concentration in german and UK initial public offering., Tilburg University, Ottobre 1999.
Harris B. - Wilson A.G., Equilibrium value and Dynamics Attractiveness Terms in Production-Constrained Spatial-interaction Model, in Environment and Planning, n. 10, 1978.
Harvey David, La crisi della modernità, Saggiatore, Milano 1993.
Yasui T., Corporate governance in Japan. Conference on “Corporate governance in Asia: a comparative perspective”. OECD, Seoul 3-5 Marzo 1999.
La Porta R.- Lopez De Silanes F.- Shleifer A., Corporate ownership around the world. National Bureau of Economic Research, Giugno 1998.
Lorenzetti G., L’architettura di sviluppo delle imprese minori, costellazioni e piccoli gruppi. ED. il Mulino 1990.
Losch A., Die Raumliche Ordnung der Wirtschaft, fiscer Ed. Jena, 1940; traduzione inglese The Economics of Location, Yale University, New Haven, 1954.
Lunghini G. - Rampa L., Struttura, interdipendenza e tecnologia nell’economia italiana, Franco Angeli, Milano 1992.
Maher M. - Andersson T.,Corporate governance: effects on firm performance and economic growth. OECD, 1999.
Mayer C., Corporate governance in UK. OECD, Seoul, Marzo 1999.
Mariotti S. - Mutinelli M., Le trasformazioni strutturali dell’internazionalizzazione produttiva delle imprese italiane, ICE Ufficio Studi Economici, Quaderni di ricerca N.4, Ottobre 1997.
Mariotti M., L’internazionalizzazione produttiva, da Impresa & Stato N.41.
Martufi R. - Vasapollo L., Profit State, redistribuzione dell’accumulazione e reddito sociale minimo, La città del Sole, 1999.
Mazzetti G., Economia e orario. Le ragioni economiche della riduzione a parità si salario. Ed. Datanews.
Michel A., Capitalismo contro capitalismo. Il Mulino, Bologna 1986.
Mori A. e Rolli V., Investimenti diretti all’estero e commercio: complementari o sostituibili?, BANCA D’ITALIA, temi di discussione del Servizio Studi, N.337 Ottobre 1998.
OECD Policy Brief N° 3- 1998; Les nouvelles orientations de la politique industrielle Prospectives de la science, de la tecnologie et de l’industrie 1998: principales conclusions (OCDE)
Onida F., Dal Locale al globale, da Impresa & Stato N.35.
Pozzolo A. F., Gli effetti della liberalizzazione valutaria sulle transazioni finanziarie dell’Italia, Temi di discussione, Banca d’Italia, 296, 1997.
Prowse S., The structure of corporate ownership in Japan. Journal of finance , vol 47, n° 3, July 1992.
Rapporto ICE , L’Italia nell’economia internazionale, 1998-99.
Renneboog L., Corporate governance system; the role of ownership, external finance and regulation. CEPS, working document n°133, Bruxelles 1999.
Roe M.J., Some difference in corporate structure in Germany, Japan, and the United States. The institutional investor project, Center for law and economic studies, Columbia University school of law. N.Y. 1993.
Rossi N. - Toniolo G., Un secolo di sviluppo economico, il progresso economico dell’Italia, Mulino, Bologna 1994.
Saba A., Il modello italiano: la “specializzazione flessibile” e i distretti industriali, Franco Angeli, Milano 1995.
Trento S., Il gruppo di imprese come modello di controllo nei Paesi ritardatari. Temi di discussione n°196, Banca d’Italia, Roma, Maggio 1993.
Yasui T., Corporate governance in Japan. OECD, Seoul, Marzo 1999.
Varaldo R. - Ferrucci L. (a cura di) La distribuzione industriale tra logiche di impresa e logiche di sistema. Ed. Franco Angeli, Milano 1997.
Von Thüned J.H., Der Isolier Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie, Puthes, Hambourg, 1875.
Weber A., Alfred Weber’s Theory of the Location of Industries, University of Chicago Press, Chicago, 1929.
Zampi V., Proprietà e governo delle aziende, Il Mulino, Bologna 1995.
[1] Questa tesi comunque pur spiegando il fenomeno dell’integrazione in termini statici non spiega il fenomeno nel caso in cui il termine di confronto sia il tasso di crescita del mercato stesso ossia nel caso di un mercato dinamico. Adelman (1955) ha evidenziato per primo la limitatezza della tesi di Stigler. L’analisi dei vari contributi teorici sul tema dell’integrazione verticale evidenzia comunque che ciascun contributo sviluppa aspetti e condizioni particolari ma non spiega il fenomeno a prescindere da riferimenti specifici.
[2] Secondo la definizione di Becattini (1989) il distretto industriale è “un’entità socio-territoriale caratterizzata dalla copresenza attiva, in un’area territorialmente circoscritta, naturalisticamente e storicamente determinata, di una comunità di persone e di una popolazione di imprese industriali”.
[3] Il nostro Paese conta una rete molto forte di distretti industriali (va considerato che in questi ultimi anni si contano più di 100 distretti industriali con oltre 600.000 addetti).
[4] Va ricordato innanzitutto che il termine “localizzazione” sta ad indicare il processo di scelta dei posti per la collocazione delle attività economiche.
I primi modelli di localizzazione avevano evidenziato il ruolo centrale dello spazio, nel senso di distanza fisica ed avevano affermato l’obiettivo di minimizzare i costi di trasporto necessari per sfruttare le risorse naturali disperse nel territorio e limitare quindi lo svantaggio dei rendimenti decrescenti.
[5] Von Thünen J.H., Der Isolier Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie, Puthes, Hambourg, 1875.
[6] Costa P., I fondamenti della teoria di localizzazione industriale: il contributo di Achille Loira, in Cappellin R., L’evoluzione delle strutture economiche regionali, Angeli, Milano, 1986.
[7] Weber A., Alfred Weber’s Theory of the Location of Industries, University of Chicago Press, Chicago, 1929.
[8] Harris B. - Wilson A.G., Equilibrium value and Dynamics Attractiveness Terms in Production-Constrained Spatial-interaction Model, in Environment and Planning, n.10, 1978.
[9] Se i Grafici seguono un andamento rispetto a valori negativi significa che prevalgono sempre gli investimenti (numeri negativi perchè per il paese considerato denotano uscita in denaro) rispetto ai disinvestimenti (numeri positivi perchè per il paese considerato denota entrata di denaro).
[10] Nel caso dell’internazionalizzazione passiva sono gli operatori economici esteri (importatori, distributori, ecc.) che acquistano il prodotto nel proprio paese.
[11] Va ricordato che le Public Company sono imprese caratterizzate dalla presenza alla guida delle imprese da manager assunti dagli azionisti per gestire l’azienda; il principale strumento di controllo dei manager è rappresentato dal consiglio di amministrazione che ha il potere di rimpiazzare, se necessario i manager. Lo strumento più efficiente per osservare i manager è il mercato del controllo azionario; infatti se il management non è efficace il prezzo delle azioni scende.
[12] Ossia la media, per le aziende tedesche quotate, dello stock più alto presente in queste aziende è del 61,5%.
[13] Cfr. F. Barca, P. Casavola, M. Perassi, “Controllo e gruppo natura economica e tutela giuridica”, Banca d’Italia, temi di discussione, numero 201, Roma, Luglio 1993.
[14] M. Donato, G.Pala, “La catena e gli anelli”, ed.La città del Sole”, Napoli, 1999, pag.43.