![]()
Rubrica
L’analisi-inchiesta
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Rita Martufi Consulente ricercatrice socio-economica; membro del Comitato Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico Sociali (CESTES) - PROTEO
I diversi modelli del capitalismo internazionale si confrontano sulle strategie di privatizzazione Le diverse forme di privatizzazione Privatizzazioni e mercati finanziari La via alle privatizzazioni nel modello capitalistico italiano. Un’indagine statistico-aziendale
Tutti gli articoli della rubrica: analisi-inchiesta(in tutti i numeri di Proteo)
|
3. Le diverse strategie di privatizzazione nel contesto internazionaleModelli neoliberisti e modelli d’impresa
In qualsiasi contesto capitalistico l’impresa ha come obiettivo fondamentale quello di massimizzare il profitto attraverso l’ottimizzazione degli indici di efficiacia e di efficienza in modo da soddisfare tutti i portatori di interesse (stakeholders) che a vario titolo partecipano alla vita e alle vicende dell’impresa stessa. Sono tre le categorie di stakeholder diretti: gli azionisti, i managers ei lavoratori; ma in contesti di capitalismo come quello renano e nipponico alle tre classi di portatori diretti vanno aggiunti anche i fornitori, le banche, i clienti, gli investitori finanziari e la pubblica amministrazione. Se fra gli oppositori all’impresa, cioè i soggetti che hanno interessi contrastanti rispetto agli obiettivi e alle finalità d’impresa vanno sicuramente ricordati i concorrenti, gli azionisti ostili, le forze ostili di natura politica, sociale e del mondo dell’informazione, si deve con altrettanta chiarezza ricordare che i portatori di interesse positivo ( i veri e propri stakeholders) hanno, a vario titolo, interesse alla partecipazione ai risultati d’impresa, comunanza di obiettivi e solidarietà di intenti con l’impresa stessa e a loro spetta il reale controllo aziendale. In tal senso il controllo non va inteso in termini giuridico-formali (che di fatto spetta agli azionsiti di maggioranza), ma si tratta di quel controllo gestionale messo in essere da soggetti che decidono le strategie d’impresa e la misura e distribuzione dei risultati economici conseguiti. Si tratta cioè di soggetti economici che guidano effettivamente l’impresa determinandone e modificando se necessario le traiettorie della pianificazione strategica. In tale determinazione che ridefinisce gli stessi modelli d’impresa gli azionisti diventano spesso spettatori e allora il controllo da formale diventa sostanziale, dividendosi, in vario modo, fra gli stakeholder. Tale linea di tendenza è maggiormente presente nel modello di capitalismo anglosassone in cui forte è presente il modello di public company realizzando un capitalismo manageriale in cui continua è la riallocazione fra proprietà e controllo. In base alle modalità di gestione d’impresa, ai processi riallocativi fra proprietà e controllo, alle scelte di collocazione del singolo paese nelle aree di influenza del capitalismo internazionale molti studiosi sono giunti ad individuare e distinguere tre forme principali di capitalismo. Con la prima forma, più caratterizzata da forte competizione aziendale ed individuale, ci si riferisce al capitalismo degli Stati Uniti che, sviluppatosi attraverso la nascita della grande impresa, si caratterizza per la presenza di un efficiente apparato manageriale, dotato di imponenti mezzi finanziari che vedono la prevalenza di un mercato borsistico dominato da un elevato azionariato imprenditoriale. Il modello di capitalismo personale-individualistico, riferito soprattutto al capitalismo britannico, pur essendo per molti versi simile a quello americano, è di natura più personale-familiare; la natura familiaristica e non manageriale della proprietà ha portato in Inghilterra allo sviluppo di un sistema economico e sociale chiuso che mira soprattutto alla conservazione dei privilegi acquisiti; questo situazione non ha permesso la nascita di un efficiente e competitivo sistema manageriale in grado di consentire uno sviluppo adeguato dell’economia britannica. La Germania, e in modo simile il Giappone, invece, ha caratterizzato il proprio sviluppo capitalistico su dei caratteri comunitari, nei quali l’impresa è costituita da diversi soggetti economici che lavorano ognuno secondo i propri ruoli per il perseguimento di uno scopo comune: lo sviluppo di lungo periodo. Al profitto immediato richiesto dagli stakeholders americani viene sostituito un incremento valoriale aziendale di lungo periodo, nel quale il profitto immediato è minore ma più forte è la preoccupazione di una vita aziendale di più lunga durata. Simile al capitalismo tedesco, come si è scritto, è il modello esistente in Giappone, forse più basato sul senso di appartenenza alla “comunità nazione”, e per molti studiosi il sistema esistente in questi due paesi viene denominato modello renano-nipponico. Vi sono comunque dei Paesi nei quali, più di altri, è interessante analizzare i modelli di capitalismo operanti, in quanto oltre a rappresentare delle situazioni proposte in aree territoriali molto estese, sono caratterizzati a volte dal successo e comunque dall’originalità dei modelli stessi; tra questi modelli meritano particolare attenzione i sistemi di gestione adottati negli Stati Uniti ed Inghilterra (Public Company), in Giappone e Germania ( impresa consociativa di stile renano e nipponico) e in Italia ( impresa padronale-familiare) [1]. Nel modello di capitalismo anglosassone le Public Companies si caratterizzano, infatti, per la fluidità del capitale poiché gli investitori, per minimizzare i rischi tendono a detenere i pacchetti azionari per poco tempo; e il carattere prevalentemente speculativo dell’investimento volto a ottenere risultati nel breve periodo fa si che gli investimenti che non producono rendimenti immediati siano quindi comunque poco apprezzati. E’ chiaro che l’incertezza minima caratteristica delle Public Companies ha come principale conseguenza un minore redditività del capitale; gli azionisti infatti sopportano un rischio minimo nei loro investimenti ma realizzano anche una redditività inferiore a quella di investimenti caratterizzati da alto rischio. Per supplire a questa carenza, diventa necessario l’intervento di manager altamente qualificati in grado di assumersi la responsabilità degli investimenti e dell’uso dei capitali acquisiti dall’impresa. Ed è proprio in questo contesto di “rivoluzione manageriale” che le Public Companies hanno caratterizzato il mercato. La distinzione tra detentori di capitale e coloro che effettivamente esercitano il controllo dell’impresa è favorita dalla capillarizzazione del capitale azionario; essendo il capitale suddiviso tra una miriade di piccoli azionisti diventa impossibile stabilire delle linee di comportamento da parte dei Consigli di Amministrazione; di qui il ruolo fondamentale del manager che, svincolato dalla proprietà dei capitali, condiziona e decide la politica d’azienda. Gli obiettivi del top management sono comunque tendenti alla realizzazione di profitti immediati, per meglio soddisfare le esigenze di redditività degli azionisti i quali sono chiamati a fine esercizio a valutare l’operato del manager confermandolo o meno alla guida dell’azienda. La conseguenza di tale impostazione è che gli esigui investimenti destinati allo sviluppo futuro, all’espansione caratterizzano queste imprese per un certo grado di immobilità e rigidità. In generale il modello di capitalismo anglosassone si è fondamentalmente basato sul mercato finanziario, dove si realizzano in effetti forti processi di finanziarizzazione dell’economia, poiché è la finanza che diventa autoreferente ed è proprio su ciò che si basano i processi di globalizzazione. Infatti in questa logica il capitale viene spostato dove rende di più, insegue il profitto ad ogni costo e ad ogni condizione, utilizzando lavoro dove costa meno, realizzando produzione laddove minori sono i controlli sull’impatto ambientale, assorbendo risparmio e realizzando sempre più processi di separazione con l’economia reale. Si viene così a creare una realtà in cui sempre più alta è la divaricazione e lo sdoppiamento fra economia reale e finanza, anzi una realtà nella quale la finanza premia gli andamenti negativi dell’economia reale (quali ad es. la flessibilità dei salari e la riduzione dell’occupazione). Si tratta in un’ultima analisi di un modello di capitalismo e di un corrispondente sistema d’impresa che si concretizza in un’economia finanziaria fortemente speculativa che prevale e affossa le esigenze della produzione e dell’economia reale; un sistema nel quale globalizzazione significa dominazione del mondo attraverso l’usura del capitale, l’espulsione dal mercato delle imprese deboli in termini di esclusiva corsa al profitto, la crescita della disoccupazione e l’utilizzo sempre più di lavoro supersfruttato, allargando le sacche e le aree in cui prevalente è la miseria assoluta. [2] Nell’impresa consociativa, tipica del sistema tedesco e giapponese, caratterizzata da un orientamento all’incremento valoriale di lungo periodo, dalla forte presenza di operatori finanziari tra gli azionisti e da una elevata managerialità, vi è una struttura particolare della compagine azionaria: si ha infatti il cosiddetto “nocciolo duro” costituito dagli azionisti stabili i quali possiedono la maggiore quota del capitale, e una moltitudine di azionisti minori che possiedono la parte di capitale effettivamente trattabile sul mercato. Le banche, gli investitori finanziari ed i portatori di forti interessi aziendali, come gli originari proprietari, detengono somme elevate di capitale; in questo tipo di impresa però non vi è la possibilità per nessun azionista di raggiungere posizioni di maggioranza assoluta. Di conseguenza nell’interesse dello sviluppo e della crescita dell’azienda stessa assume una importanza fondamentale la figura del manager che ha come obiettivo prioritario la massimizzazione del valore d’impresa, nell’ottica dell’espansione, tentando di realizzare un mix ottimale fra crescita aziendale, redditività del capitale investito e dinamiche dello sviluppo complessivo. La Germania si caratterizza per le numerose analogie con il sistema d’impresa giapponese; in questo modello d’impresa si realizzano, infatti, degli equilibri tra azionisti, strutture pubbliche e banche. Va rilevato, però, che per quanto concerne la struttura azionaria nell’arco degli ultimi trenta anni si è verificato un calo consistente nella presenza degli azionisti privati e del settore pubblico a favore di una crescente presenza delle assicurazioni e delle banche. Gli incroci azionari si verificano frequentemente tra le banche e le imprese e tra le stesse imprese (vedi Tab.8).
In Germania il sistema bancario è caratterizzato dalla proprietà privata delle banche; dall’esistenza della Hausbank, cioè di una relazione bancaria fondamentale e fiduciaria, che nasce dalla convinzione che la stabilità dei rapporti di finanziamento e di interscambio cooperativo fra banca e impresa costituiscono un fattore imprescindibile per la crescita dell’impresa stessa; dal conferimento diretto al sistema bancario di specifici importanti compiti nei confronti del mercato del capitale di rischio; dalla presenza di dirigenti dell’Hausbank nei Consigli di Sorveglianza d’impresa, in modo da ridurre le asimmetrie informative migliorando e realizzando una più corretta valutazione nel merito del credito e del suo relativo costo. Va segnalato che il modello tedesco, al pari di quello giapponese, è caratterizzato anche dalla presenza del sistema della “cogestione”; in sostanza tra gli stakeholders presenti nella gestione vi sono anche i lavoratori, attraverso i loro rappresentanti sindacali. In pratica la corresponsabilità si applica attraverso i sindacati, il Consiglio d’Azienda, nel quale vengono interpellati i lavoratori per le questioni riguardanti il personale, e il Consiglio di Sorveglianza che nomina il direttivo, ossia i manager responsabili della gestione. Si determina in tal modo una compressione forzata dei conflitti sociali e una quasi mancanza di conflitti interni all’azienda; il senso di appartenenza e di cooperazione rendono l’organizzazione d’impresa tedesca molto stabile e forte. I lavoratori che in questo contesto ottengono, in contropartita di una concordata “pace aziendale e sociale”, dei salari più elevati e lavorando meno ore rispetto alle medie anglosassoni, dimostrano un maggiore senso di “fedeltà” all’impresa aumentando così la potenza del sistema economico tedesco [3]. A partire dagli anni ’80 negli Stati Uniti, ci si è resi conto della necessità di limitare il potere eccessivo dei manager e si cerca di rendere più stabile l’azionariato attraverso l’intervento di investitori stabili, in grado di consentire una migliore concentrazione della proprietà. In quest’ottica si è avuta una diminuzione degli investitori privati e la nascita delle “relationship investing”, società finanziarie che ottengono un ruolo diretto nella gestione delle imprese attraverso l’acquisto di elevate quote azionarie di un’impresa. Sempre nell’ottica di concentrare la proprietà si è pensato di trasformare i managers in azionisti coinvolgendoli più direttamente nelle sorti aziendali, stabilendo, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione delle grandi società, oltre a riunirsi più spesso, deve essere gestito in maniera da relazionarsi direttamente ai proprietari, in presenza di solo uno o al massimo due managers [4].
La corsa neoliberista internazionale alle privatizzazioni
Il fenomeno delle privatizzazioni che ha caratterizzato questi ultimi venti anni si è manifestato nei vari Paesi europei con diversa modalità e intensità. E’ pertanto interessante analizzare più da vicino le differenti modalità con le quali questo processo si è attuato. Va ricordato, in primo luogo che sono diverse le tecniche con le quali è possibile attuare l’operazione di privatizzazione. Tra i sistemi più applicati dai vari paesi, in paricolare europei, si colloca senza dubbio l’offerta pubblica di vendita. In Inghilterra, in Francia e in Germania questo metodo è stato molto usato per le grandi privatizzazioni; anche a livello internazionale si è avuta larga applicazione dell’OPV (basti ricordare che tra il 1984 e il 1992 il 45% delle aziende privatizzate ed il 75% del valore complessivo delle operazioni è stato attuato attraverso questa tecnica). Inoltre è importante considerare che paesi quali l’Austria, l’Olanda, il Giappone, la Francia, la Gran Bretagna, la Malesia, la Thailandia e il Portogallo hanno raggiunto valori di dismissione attraverso le OPV pari quasi al 100%. Nei Paesi dell’Est europeo è stata invece usata molto di più la procedura dell’asta pubblica; poichè tale metodo è infatti molto più consono alle privatizzazioni di aziende di medie e piccole dimensioni; in questi Paesi si è utilizzata anche la privatizzazione tramite “buoni cartolari” che, dopo essere stati convertiti in azioni, sono stati distribuiti al pubblico a prezzi vantaggiosi, realizzando una sorte di azionariato popolare. Nei paesi caratterizzati da una situazione di estrema gravità finanziaria e che necessitano di metodi di dismissione molto rapidi e semplici è, invece, molto usata la trattativa privata. Questa procedura è stata adottata da molti paesi dell’America Latina, quali il Messico, la Bolivia, l’Argentina, il Cile, il Brasile e il Costarica. L’employees buy out (ossia la cessione delle azioni ai dipendenti e ai manager dell’azienda stessa) è stata utilizzata molto spesso in Francia, in Cile, in Venezuela, in Inghilterra, in Argentina, in Costa d’Avorio, negli Stati Uniti, in Portogallo, in Nigeria, in Pakistan. Anche la concessione di attività in appalto ai privati, pur essendo utilizzata a livello locale, ha trovato qualche applicazione in Giappone, in Canada, negli Stati Uniti e in Inghilterra. Per avere un quadro esemplificativo del peso delle varie operazioni di privatizzazione è interessante mostrare quale sia stato l’importo dei ricavi (Graf. 9) ottenuti dalla privatizzazioni negli anni 1982-1991 in alcuni paesi dell’America Latina.
Va immediatamente evidenziato che allo stato attuale qualsiasi processo di privatizzazione ha realizzato senza dubbio effetti negativi quantitativi e qualitativi sull’occupazione. Va ricordato, infatti, che molto spesso le nazionalizzazioni sono avvenute proprio per consentire di mantenere il posto di lavoro in imprese che attraversavano momenti anche di seria crisi e che rischiavano di fallire ed uscire da un mercato selvaggio e non regolamentato. Si è trattato spesso di affermare il principio keynesiano di uno Stato occupatore e garante dei conflitti, di un mercato regolamentato e tendente alla piena occupazione. Va inoltre tenuto conto che anche nei casi in cui, una privatizzazione ha successo, (nel senso che si vengono a creare delle condizioni economiche generali di stabilità che potrebbero quindi consentire l’assorbimento di alcune fasce di disoccupazione), ciò si ripercuote comunque sulla riduzione dei costi diretti ed indiretti del lavoro. Non va, ad esempio, dimenticato che nel migliore dei casi è fortemente aumentata la mobilità, la flessibilità del lavoro e del salario, incidendo negativamente sui ritmi, sulla condensazione e sui turni di lavoro. A ciò si deve aggiungere che quasi sempre i processi di privatizzazione hanno provocato diminuzione di garanzie e compressione dei diritti sindacali, fino a giungere, in particolare in paesi a più bassi livelli di sviluppo economico e democratico, alla mancanza completa di qualsiasi forma di garanzia reddituale, sindacale e a pienezza di diritti per i lavoratori, favorendo forme di precariato, sottoccupazione, lavoro nero e grigio e di supersfruttamento complessivo. Anche l’opinione molto diffusa tra i sostenitori delle privatizzazioni che queste consentano una riduzione del debito pubblico ed estero è fortemente illusoria; infatti non va dimenticato che ”i vantaggi di un programma di privatizzazione di imprese pubbliche possono derivare solo dal fatto che esso riduce l’entità dei surplus primari futuri, necessari per ripagare nel tempo il debito netto e non il debito totale. Se la privatizzazione lascia inalterato il debito netto, altrettanto avverrà per i surplus di bilancio che si renderanno necessari in futuro per ripagare gli interessi sul debito...in caso di privatizzazione, la posizione patrimoniale netta del settore pubblico non cambia nel presente (alla diminuzione dello stock di debito si associa una diminuzione dell’attivo) e il beneficio economico è limitato all’esercizio in cui si realizzano le eventuali plusvalenze connesse all’alienazione delle attività [5]”. Il rischio, anzi meglio ciò che la realtà internazionale ci dimostra, di vendere le migliori aziende pubbliche, i gioielli di famiglia, provoca l’effetto di ridurre il patrimonio statale senza averne effettivi benefici a lungo termine. Ed ancora: l’efficienza, la competitività e la migliore redditività che la dismissione di un’azienda pubblica dovrebbe comportare sono anch’esse illusorie e non comprovate dai fatti, soprattutto perché è molto difficile stabilire una pertinenza tra la proprietà di un’azienda e la sua efficienza ed inoltre perchè gli indicatori tipici di produttività, efficienza ed efficace aziendale non sono quasi mai “trasportabili” seguendo semplici criteri quantitativi dal privato al pubblico e viceversa. Non esistono mai regole precise, fisse, dogmi economici; l’economia, in particolare quella aziendale, va studiata nei processi interagenti fra realtà interne ed esterne, leggendo i legami reali, non quelli determinati da forzature prettamente politico-partitiche-affariste, interpretando cioè le dinamiche aziendali e le ricadute sociali che si sviluppano tra macrosistema aziendale e macrosistema socio-ambientale. Alcuni esempi: la società francese Rhone Poulenc si trovava prima del 1982 (anno in cui è stata nazionalizzata) in una situazione economica molto difficile e di crisi di prospettive strategiche; negli anni in cui è stata di proprietà dello Stato (fino al 1991) è riuscita a capovolgere la propria posizione, moltiplicando il fatturato e gli utili ed arrivando ai vertici mondiali del settore in funzione di tutti i più importanti indicatori economici e finanziatori-patrimoniali. Le società inglese Brooke Marine, la Swan Hunter e la Vospers sono passate a maggioranza significativa di capitale private e dopo delle crisi molto serie sono fallite; anche la British Steel dopo un momentaneo miglioramento è stata duramente colpita da una dura crisi finanziario-economica. [6] In sostanza, anche in questo caso vale la regola che l’efficienza delle imprese pubbliche è strettamente collegata alle scelte di politica-economica, allo stretto legame fra strategie macroeconomiche e conseguenti linee operative microaziendali, pubbliche e private. In conclusione anche attraverso le modalità attuative dei processi di privatizzazione ci si accorge di come il neoliberismo internazionale si stia rimodellando, in termini soprattutto finanziari, per comprimere le scelte e le impostazioni di tipo pubblico-collettivo che avevano caratterizzato le cosiddette economie miste. Infatti si assiste ormai ad un graduale riavvicinamento dei due modelli opposti delle Public Companies e delle imprese consociative, in quanto mentre negli Stati Uniti ci si avvia verso un azionariato più stabile, in Giappone diminuisce l’incidenza degli incroci azionari e si tende ad allargare la partecipazione e la dipendenza delle imprese direttamente dal mercato finanziario. Considerato che nel modello renano si realizza una superiorità economica e sociale sarebbe logico aspettarsi che questo sistema d’impresa diventi prevalente a scapito del modello anglosassone, ciò non è affatto vero; nella realtà infatti quest’ultimo tende a travolgere oltre ai modelli di impresa di quei paesi che si trovavano ad adottare una via di mezzo tra l’uno e l’altro anche gli stessi paesi nei quali si è originato il modello renano-nipponico [7].
[1] Su tali argomenti si vedano anche vari articoli nel N. 0 di “Proteo” [2] Cfr. R.Martufi, L.Vasapollo, “Sviluppo capitalistico...”, op. cit. [3] Cfr. R.Martufi, L.Vasapollo, “Sviluppo capitalistico...”, op. cit. [4] Cfr. R.Martufi, L.Vasapollo, “Sviluppo capitalistico...”, op. cit. [5] Cfr. Niada M. “Le privatizzazioni degli altri”, il SOLE 24ORE Libri, Milano 1993, p. 28. [6] Cfr. Niada M. “Le privatizzazioni....”, op. cit. [7] Cfr. R.Martufi, L.Vasapollo, “Sviluppo capitalistico...”, op. cit.
|
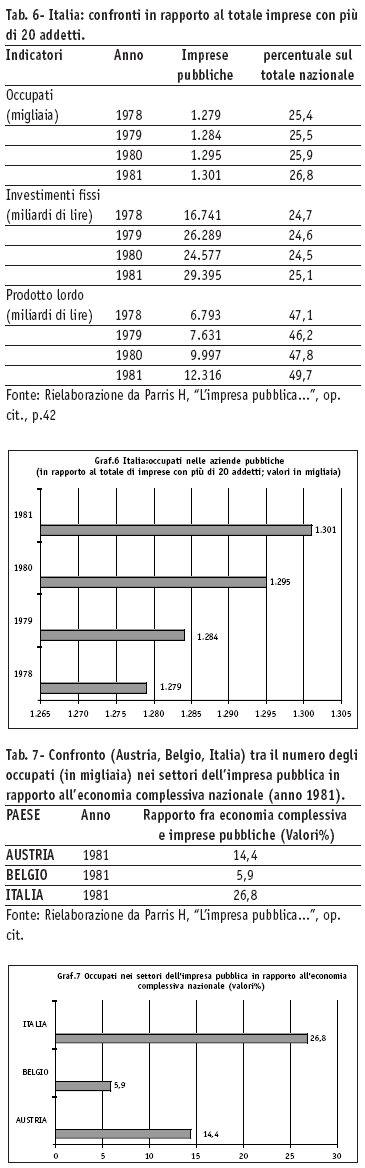
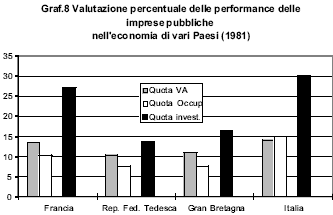
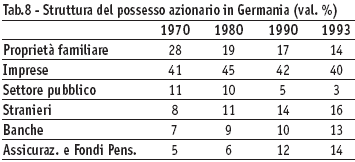 Il
connotato principale che caratterizza il capitalismo tedesco è rappresentato
dal ruolo fondamentale svolto dalla “Banca Universale”.
Il
connotato principale che caratterizza il capitalismo tedesco è rappresentato
dal ruolo fondamentale svolto dalla “Banca Universale”.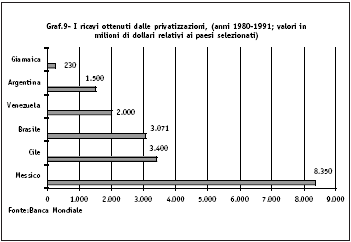 Prima
di esporre i diversi approcci al processo di privatizzazione così come si è
attuato in ambito internazionale, è opportuno fare alcune riflessioni di carattere
generale connessi o volutamente addotti per giustificare la cessione di imprese
pubbliche da parte dello Stato, anche se a volte presentavano buoni livelli
di efficienza economica.
Prima
di esporre i diversi approcci al processo di privatizzazione così come si è
attuato in ambito internazionale, è opportuno fare alcune riflessioni di carattere
generale connessi o volutamente addotti per giustificare la cessione di imprese
pubbliche da parte dello Stato, anche se a volte presentavano buoni livelli
di efficienza economica.