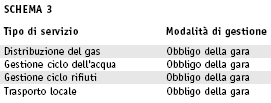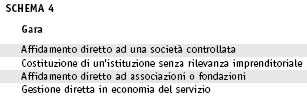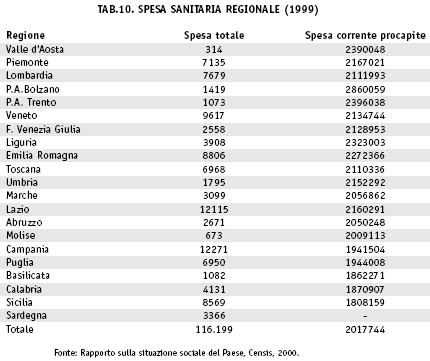![]()
Rubrica
L’analisi-inchiesta
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Maria Rosaria Del Ciello Collaboratrice e ricercatrice rivista “Proteo”
Le privatizzazioni dei servizi nella Pubblica Amministrazione e negli enti locali
Tutti gli articoli della rubrica: analisi-inchiesta(in tutti i numeri di Proteo)
|
Con il nuovo "Ordinamento federale" la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni (che sono enti autonomi con propri statuti) e dallo Stato. L’art. 119 della Costituzione viene così riscritto: "i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri". Gli enti locali sono anche chiamati a compartecipare "al gettito di tributi erariali" riferibili al loro territorio. Lo Stato "istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante". In più, sempre secondo la recente riforma federalista, lo Stato dovrà provvedere a rimuovere gli squilibri economici e sociali attraverso risorse aggiuntive che verranno destinate a favore di determinati enti locali. Due sono gli inconvenienti possibili, secondo il Bonelli, che scaturiscono da una privatizzazione dei servizi di pubblica utilità: 1) che il monopolio pubblico si trasformi in monopolio privato, con possibili sovrapprofitti monopolistici e senza stimoli competitivi al miglioramento dell’efficienza della qualità dei servizi; 2) che i servizi pubblici, gestiti in un’ottica esclusivamente privatistica, non considerino gli interessi collettivi e non assicurino la continuità e qualità dei servizi, la loro diffusione sull’intero territorio nazionale, la libertà di accesso e la parità di condizioni per gli utilizzatori. "Il fenomeno più evidente che in passato ha fortemente caratterizzato il dibattito sui servizi pubblici locali è rappresentato dalle dimensioni e dalla dinamica dei disavanzi prodotti dalle aziende municipalizzate. Spesso si tende a comparare costi e risultati economici conseguiti da imprese pubbliche e private per concludere, nella maggioranza dei casi, che queste ultime garantiscano esiti migliori. Da ciò non di rado discende una propensione ad una estesa privatizzazione. Un tale approccio non tiene conto del fatto che i risultati economici delle aziende pubbliche locali non sono che l’effetto finale di un intreccio di problemi i quali a loro volta sono venuti sedimentandosi nel tempo e traggono origine dalla natura stesse di tali aziende" [1]. Il processo di privatizzazione nel settore dei servizi pubblici locali non avviene poi in maniera indiscriminata e non interessa ogni area e ogni servizio. L’attività dei privati si concentra in realtà esclusivamente sui segmenti di mercato che offrono maggiori margini di convenienza e remunerabilità. La motivazione di fondo che ha condotto alla municipalizzazione "non ha fatto riferimento alle proprietà naturali dei e dei servizi (proprietà che sono alla base della definizione neoclassica di monopolio naturale) bensì ad un altro aspetto, storicamente decisivo: la necessità cioè di assicurare la più estesa fruizione di quei beni e servizi che, nelle condizioni storiche date, sono giudicati essenziali a garantire uno standard minimo delle condizioni di vita dei cittadini" [2].
3. I servizi privatizzatiA partire dal secondo dopoguerra, la composizione dei servizi pubblici si è andata articolando in: • servizi strategici (elettricità, telefonia, comunicazioni, ecc.), soprattutto tramite il meccanismo delle aziende a partecipazione statale (IRI, ENI, ENEL, EFIM, ecc.), che oggi vanno assumendo la forma di Public Utilities Company; • servizi decentrati al livello comunale (trasporti, nettezza urbana, ecc.), oggi gestiti direttamente o dati in appalto ad aziende private o municipalizzate; • servizi forniti direttamente dalle pubbliche amministrazioni (servizio postale, previdenza sociale, pubblica istruzione, servizio sanitario nazionale, ecc.). In questo tipo di attività l’equilibrio tra i costi sostenuti e i prezzi attribuiti è difficilmente riconducibile alle logiche di mercato, perché diversi sono gli obiettivi che con questi servizi si intendono realizzare e ciò dovrebbe valere anche nel caso di una riduzione della presenza dello Stato e della P.A. nell’erogazione dei servizi. Ovviamente, più l’Ente erogatore è vicino allo Stato, più forte è l’influenza della componente sociale. Il più delle volte, il pagamento delle prestazioni pubbliche è assicurato in parte dallo Stato ed in parte dall’utilizzatore, anche se la tendenza di questi ultimi anni è quella di garantire il sostegno dello Stato esclusivamente agli aventi diritto (i cittadini particolarmente svantaggiati), liberalizzando l’erogazione dei servizi per tutti coloro i quali sono e saranno chiamati a pagare i servizi stessi [3]. La prima tappa italiana del processo di privatizzazione può essere fatta risalire al decreto legge n.333 del 1992 con il quale venne deciso dal governo Amato la trasformazione degli enti pubblici economici ENEL, ENI, IRI, INA in spa. Nel 1995 vendono messe a punto le carte dei servizi e varata l’Autorità per l’energia elettrica e il gas a cui sono trasferite le competenze in materia di prezzi [4]. La riforma dei servizi pubblici locali doveva essere il passaggio immediatamente successivo alla legge sulle autonomie locali del 1990: questa riforma era ed è destinata a mettere fine, in un modo o nell’altro, alla storia delle aziende municipalizzate La storia della municipalizzazione dei servizi pubblici locali percorre, in definitiva, tutto il Novecento. Può essere lunga l’elencazione degli aspetti di debolezza e di contraddizione dei processi di trasformazione dell’amministrazione pubblica che si vive nel presente periodo storico. Grandi processi di trasformazione sono in corso, processi che sono ampiamente determinati dal consolidamento e dall’estensione dell’ordinamento comunitario e del suo principio fondante della concorrenza come elemento costitutivo del mercato unico europeo. Negli anni Novanta l’espansione del principio al mondo delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici è rilevante. Si pensi alla direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, che impone alle Pubbliche amministrazioni l’obbligatorietà della gara per l’affidamento dei servizi di distribuzione del gas, di gestione del ciclo dell’acqua e di quello dei rifiuti, nonché del trasporto locale. La gara diventa, insomma, obbligatoria per tutti i servizi a rete con caratteristiche produttive tipicamente industriali [5], perché considerata quale volano della concorrenza e dell’iniziativa imprenditoriale, quanto più il modello prescelto è fondato sulle offerte economicamente più convenienti e non soltanto sui prezzi. È un notevole capovolgimento: presuppone amministrazioni agguerrite che mettano bene a punto gli obiettivi da raggiungere e ben preparino quindi l’arena competitiva. Ciò significa avere una cultura delle gare e della competizione che non è facile ad acquisire [6]. La riforma degli enti locali prevede che la gara sia aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e di sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo delle reti e dei progetti di innovazione tecnologica e gestionale: tutte queste variabili sono, come è stato giustamente notato [7] né facilmente quantificabili e di complessa e problematica ponderazione.
Per altri tipi di servizi diversi da quelli su elencati si ha la possibilità di scelta tra:
Possiamo così elencare i servizi pubblici locali: - Sanità - Previdenza - Trasporti delle persone e delle merci - Energia elettrica, gas - Risorse idriche - Rifiuti solidi e urbani - Sistema finanziario - Ricerca e cultura
a) Previdenza e sanità
In questo settore possiamo brevemente accennare ai casi degli asili nido comunali (gestiti dal Ministero della Sanità) e alle farmacie comunali. Asili nido. Nascono come luogo di custodia per i bambini delle lavoratrici e negli anni ’30 cominciano a sorgere i primi asili ad opera dell’OMNI (Opera Maternità e Infanzia). L’art. 11 del Regolamento dei Nidi OMNI recita: "L’asilo nido è un servizio della comunità per i figli dei lavoratori o per bambini di famiglie gravemente impedite di attendere alla loro cura". Nel 1960 l’UDI (Unione Donne Italiane) presentò una proposta di legge per il passaggio delle competenze dall’OMNI alle amministrazioni locali; nel 1965 vi fu una proposta di legge di iniziativa popolare per un servizio nazionale di asili nido. Nel 1971 fu approvata la legge 1044 che istituiva gli asili-nido comunali con il concorso dello Stato, approvazione resa possibile anche grazie alle lotte di quegli anni e alle profonde trasformazioni economiche, sociali e urbanistiche che avevano visto una forte immigrazione, il sorgere dei quartieri dormitori, la scomparsa del verde e la trasformazione della famiglia allargata in famiglia nucleare. Successivamente il servizio subì una positiva evoluzione, una lenta ma progressiva espansione ed una connotazione educativa oltre che assistenziale. Tuttavia i 3800 nidi che la legge 1044 prevedeva entro il 1975 non furono mai aperti; attualmente gli asili nido in Italia sono poco più di 2000 e coprono meno del 6% del numero dei bambini da zero a tre anni. Nel novembre 1998 il governo organizzò a Firenze la prima Conferenza Nazionale sull’Infanzia durante la quale il Ministro della Solidarietà Sociale annunciò l’intenzione di cambiare la legge sugli asili nido perché "li frequenta solo il 6% dei bambini, sono concentrati nel Centro Nord, hanno lunghe liste d’attesa, tariffe troppo alte, orari insufficienti. Con la riforma gli asili-nido passeranno dal Ministero della Sanità a quello dell’Istruzione trasformandosi da un servizio su domanda a sistema educativo per tutti". Tutto ciò sembra essere stato contraddetto dagli stessi progetti di legge successivamente presentati che affidano la gestione dei nidi ai privati (finanziati con denaro pubblico), non fanno stime della domanda, non programmano obiettivi di espansione, non prevedono il passaggio dal Ministero della Sanità a quello dell’Istruzione. È sbagliato pensare di espandere il Nido tramite il privato che in questi anni ha investito pochissimo nella gestione degli asili nido, nonostante la gran richiesta, perché per trarne profitto occorre far pagare rette molto alte che la maggior parte dei genitori non possono sostenere [8].
Il servizio farmaceutico comunale
Le farmacie pubbliche, dette generalmente farmacie comunali, sorsero agli inizi del secolo scorso per aiutare i poveri del Comune quando i costi dei medicinali erano per loro insopportabili. La loro nascita fu quindi motivata da un unico scopo: migliorare la qualità della vita a quei cittadini che alla miseria assommavano anche la malattia. Successivamente le farmacie comunali si assunsero anche il compito di una distribuzione capillare del servizio nel territorio portando le farmacie nelle frazioni, dato che i privati preferivano, per motivi di ordine economico, aprirle nelle sole vie centrali e commerciali delle città. Negli anni recenti però si è assistito alla rincorsa dei Comuni a trovare risorse finanziarie per rimpinguare le disastrate casse comunali e in questa logica si è pensato di vendere le farmacie comunali. Ciò è senza dubbio un grosso errore economico, in quanto oggi una farmacia comunale riesce a dare un coefficiente di redditività superiore al 5% ed inoltre essendo una struttura imprenditoriale da sempre abituata al regime della concorrenza, in alcuni comuni rappresenta l’unica esperienza di gestione aziendale. Ci sono poi ovviamente motivi di ordine sociale che spingono per evitare la vendita di questo prezioso servizio pubblico. Le farmacie comunali sono infatti un orecchio privilegiato sui bisogni della cittadinanza in campo sanitario e si differenziano da quelle private per le molteplici attività svolte in campo sociale, tra cui: campagne d’informazione condotte da farmacisti (ad esempio su AIDS, fumo, educazione sessuale, etc.); - distribuzione, in alcuni comuni, di siringhe e/o profilattici, attraverso distributori automatici; - misurazione gratuita della pressione arteriosa ai pensionati; - distribuzione gratuita di opuscoli sanitari su vari argomenti; - raccolta di farmaci scaduti.
b) Trasporto pubblico:
Il D. LEG. 422/97 intitolato “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n° 59” disciplina: • trasferimento di compiti e funzioni per tutti i trasporti pubblici operanti a livello regionale o infraregionale (art. 4); • definizione dei trasporti pubblici di interesse nazionale esclusi dal conferimento (art. 3) e riserva di competenza statale su trasporti locali (servizi transfrontalieri, sicurezza, ambiente); • delega a regioni delle funzioni programmatorie e trasferimento a enti locali da parte delle regioni con legge entro sei mesi sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalla 59/97 (artt. 7-13); • programmazione regionale coordinata in sede di conferenza stato-regioni; accordi di programma regione-ministero per investimenti. [1] Antonio Di Majo (a cura), "Le politiche di privatizzazione in Italia. 3° Rapporto CER/IRS sull’industria e la politica industriale italiana", Il Mulino, 1989. [2] AREA, "Entrate tariffarie e trasferimenti nel finanziamento dei servizi pubblici in disavanzo", 1986, Firenze, Cispel. [3] CNEL (IV° Commissione per le politiche dei fattori orizzontali), "Il sistema paese come fattore di competitività: i servizi pubblici, le politiche di coesione, la cittadinanza europea", Roma, 13 aprile 1999. [4] Appunti sulla liberalizzazione del mercato elettrico, 1999, in: www.rifondazione.it/energia. [5] Giuseppe Labarile, "Un occhio al mercato e uno alla riforma", Guida agli Enti Locali, n. 44, 2000. [6] Sergio Ristuccia, La trasformazione dei servizi pubblici locali, in: www.servizilocali.com/it. [7] Giuseppe Labarile, "Un occhio al mercato e..., op. cit. [8] Coordinamento sostenitore della proposta di legge di iniziativa popolare "L’asilo nido: un diritto delle bambine e dei bambini", Cercasi nido disperatamente, novembre 2000, in: www.ecn.org/reds/nidibollettino.html.
|