1. Introduzione
Nel corso degli anni ottanta i processi di privatizzazione hanno caratterizzato la politica economica in tutta l’Europa occidentale, come risposta alle politiche che avevano predominato nel lungo periodo successivo alla seconda guerra mondiale e che avevano sottolineato l’intervento pubblico nell’economia.
Così dopo i primi esperimenti effettuati dal Regno Unito e da qualche altro paese (es.: la Francia) la privatizzazione di vecchi servizi e di organizzazioni del settore pubblico è divenuta via via una caratteristica distintiva della politica dell’Unione Europea durante tutti gli anni novanta.
Quando si parla di settore pubblico ci si riferisce alle Amministrazioni pubbliche ossia al complesso delle Amministrazioni Centrali, degli enti previdenziali e delle amministrazioni locali: in sostanza si tratta di amministrazioni che producono beni e servizi non destinati alla vendita. Più precisamente con il termine Pubblica Amministrazione si intende l’operatore che produce servizi collettivi i quali, non formando oggetto di compravendita, non hanno un prezzo di mercato, attuando inoltre la redistribuzione del reddito e della ricchezza con operazioni di trasferimento o di erogazioni unilaterali in denaro o in natura effettuate a beneficio degli altri operatori e settori [1].
Il conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche comprende le principali voci di spesa e di entrata delle amministrazioni pubbliche secondo il criterio della natura economica; a queste voci va poi aggiunto il Risparmio pubblico (dato dalla differenza tra Entrate correnti e Uscite correnti), l’Indebitamento netto (Entrate totali meno Uscite totali) e l’Avanzo Primario.
Le tabelle 1, 2, 3 e 4 mostrano chiaramente come le spese delle Amministrazioni Pubbliche comincino a decrescere (dopo una crescita pressocchè costante a partire dal 1960) a partire dal 1992. Viene da chiedersi il perché di questa inversione di rotta nella gestione dell’economia nazionale e al proposito possono essere individuati due motivi alla base della riduzione degli interventi statali nell’economia:
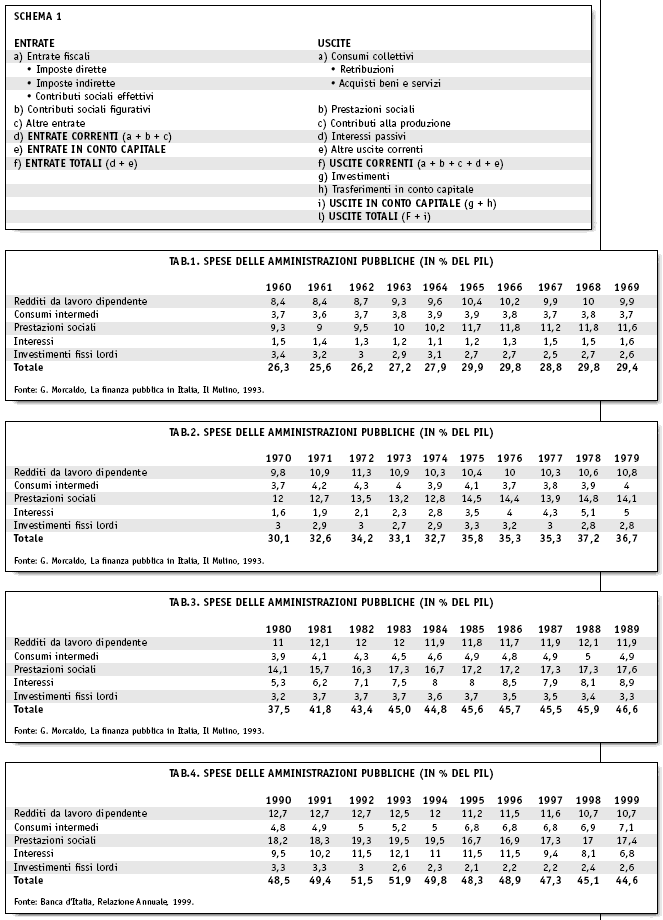
1. Innanzitutto le direttive di "liberalizzazione selvaggia" adottate dall’Unione Europea in materia di telecomunicazioni, ferrovie, trasporto aereo, servizi postali, energia, tutte misure volte all’apertura dei mercati nazionali alla concorrenza.
2. In secondo luogo la realizzazione dell’Unione economica e monetaria dell’Europa che in virtù del principio di convergenza dettato dal trattato di Maastricht ha spinto i governi a vendere beni statali e interessi nelle compagnie industriali [2].
I processi di trasformazione in corso quindi sono ampiamente determinati dall’affermazione dell’ordinamento comunitario e del suo principio fondante della concorrenza come elemento costitutivo del mercato unico europeo esprimendo così "meglio di ogni altro intervento la necessità dei vari modelli di capitalismo finanziario di mettere in discussione sul piano mondiale le conquiste del movimento operaio" [3].-----
Le ideologie liberiste che ispirano questi processi mirano a:
- Migliorare l’efficienza dei settori interessati e quindi diminuirne i prezzi;
- Risanare le finanze pubbliche, spesso oberate dai costi elevati di questi servizi.
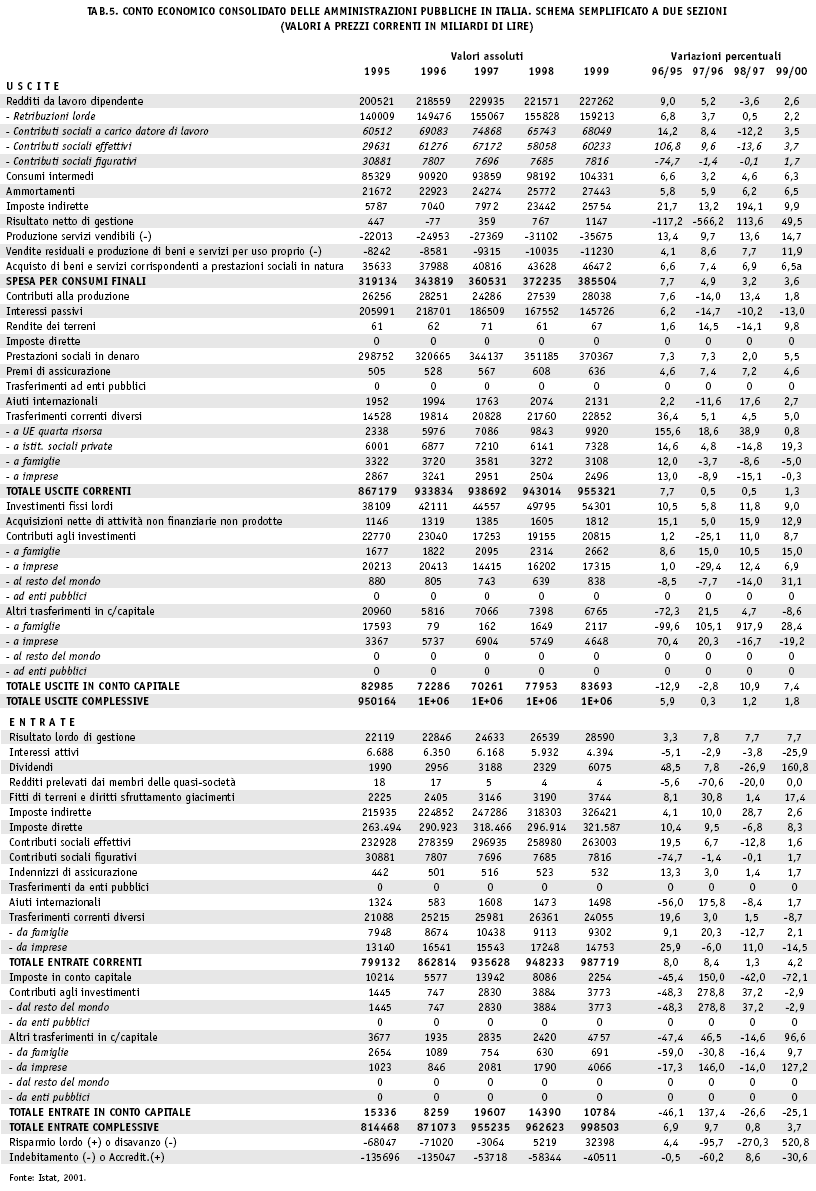
In maniera meno esplicita e più subdola le stesse ideologie hanno come obiettivo anche:
- La creazione di opportunità per realizzare ingenti profitti dalle operazioni di acquisizione e vendita delle aziende;
- L’indebolimento del potere e delle condizioni contrattuali dei lavoratori di questi settori;
- L’indebolimento progressivo dello Stato sociale che tra i tanti obiettivi ha anche quello di prevedere delle tariffe adeguate agli strati più disagiati della collettività.
Questo fenomeno di profonda ristrutturazione che stanno subendo tutti i servizi pubblici (attraverso la privatizzazione di attività considerate tradizionalmente attività della Pubblica Amministrazione) e che interessa ora anche i servizi caratteristici degli enti locali è un fenomeno che riguarda tutti i Paesi del mondo a causa del fatto che molti di questi servizi, specialmente quelli erogati direttamente dalle amministrazioni pubbliche, sono spesso percepiti come inefficienti (comportano uno spreco di risorse in quanto l’offerta non avviene al minimo costo) e inefficaci (poiché l’offerta raggiunge l’obiettivo prefissato in modo imperfetto e imparziale) dalla maggior parte dei cittadini. Per questo motivo ci si è chiesto se le attività economiche svolte tradizionalmente dallo Stato non possano essere svolte con un minor utilizzo di risorse, senza dover necessariamente sottrarre al settore pubblico il compito di erogare e/o promuovere determinate attività per aumentarne la funzionalità.
Gli scenari futuri che si prospettano alla Pubblica Amministrazione sono quindi determinati da una serie di importanti trasformazioni quali:
• Finanziarizzazione della proprietà
• Privatizzazione delle gestioni dei servizi
• Esternalizzazione di alcune attività
• Cambiamento delle forme di lavoro, ovvero tendenza alla mobilità dei lavoratori e a forme di flessibilità salariale.
Può essere interessante vedere in dettaglio il conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche in Italia e le sue variazioni dal 1995 al 1999.
Come si evince dalla tabella 5 dal 1995 al 1999 c’è una forte diminuzione nella variazione delle uscite rispetto all’anno precedente quando si passa dal 1996 al 1999: per quanto riguarda le spese totali la variazione scende dal 5,9 del 96/95 al 1,8 del 99/98. Anche questo può essere spiegato come la naturale conseguenza delle politiche attuate e indirizzate ad un indiscriminato contenimento della spesa totale delle Amministrazioni pubbliche, tendenza che ben si adatta agli scenari attuali e internazionali di taglio alle spese pubbliche in tutti i paesi, visto che anche negli paesi dell’UE le posizioni di bilancio delle Amministrazioni Pubbliche presentano tutte un trend in costante diminuzione nel corso degli anni ’90 (vedi tab. 8).
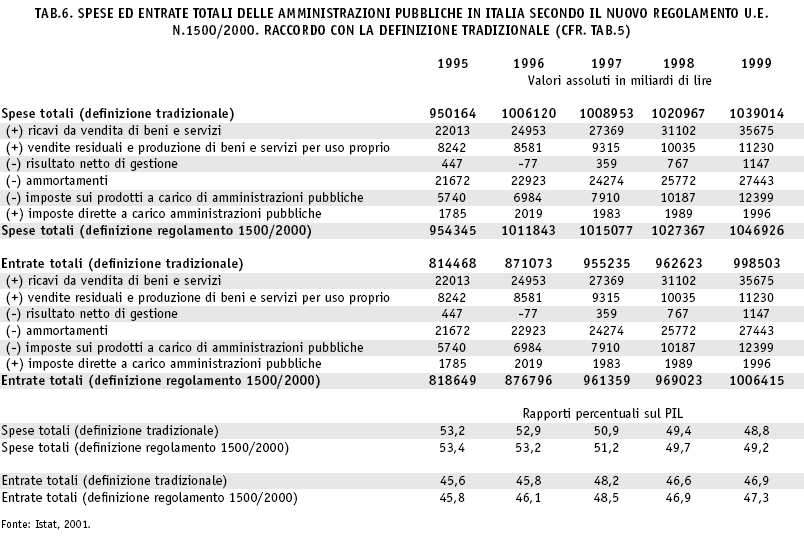
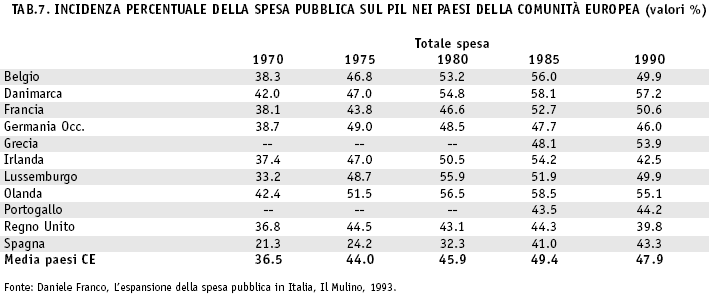
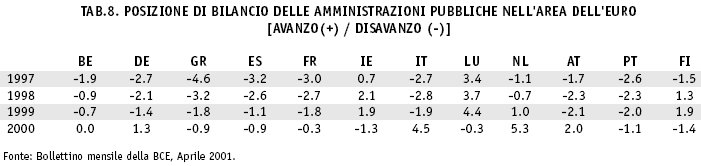
-----
Si pongono al riguardo alcuni quesiti di ordine politico-economico
quali: a. Quale potrà essere il ruolo dello Stato e del sistema politico
in un’economia di mercato? b. Il soddisfacimento di interessi collettivi deve tener conto
ed evitare una possibile degenerazione burocratica? Questa impostazione che vede nella privatizzazione e nella
scelta del sistema concorrenziale l’unica soluzione ai problemi di servizi pubblici
a volte inefficienti, produce solo comportamenti finalizzati a raggiungere livelli
sempre maggiori di competizione senza tener conto che esistono forme di fallimento
del mercato in cui ha ragione d’essere l’intervento dell’azione statale: una
di queste è proprio rappresentata dall’esistenza dei beni pubblici. Tutto ciò non fa altro che ripercuotersi sul mondo del lavoro
con la conseguente tendenza a forme di precariato e di temporaneità dell’occupazione
che a loro volta generano forme nuove di sfruttamento del lavoratore.
In senso lato per privatizzazione si intende il passaggio dei
diritti di proprietà esercitati su di un’impresa dalle mani dello Stato alle
mani di privati che ne assumono la gestione. Si tratta, in genere, di particolari
attività proprie dello Stato di benessere (sanità, previdenza, scuola, etc.).
Ne deriva anche una privatizzazione del pubblico impiego che comporta che i
rapporti di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni passino dal diritto pubblico
al diritto civile. Nel caso dei servizi pubblici il termine ha acquistato una
particolare enfasi dal momento che essa si riferisce ad attività tradizionalmente
rientranti nei compiti dell’ente pubblico locale sulla base di una consolidata
tradizione anche politica. La legge n° 142/90 introdusse importanti novità legislative
tra le quali quelle relative alla gestione dei servizi pubblici locali. Tale
legge infatti delineò, anche se non in maniera completa, un sistema di gestione
dei servizi pubblici che, accanto alle tradizionali forme della gestione diretta
e di quella in concessione a terzi, prevedeva la possibilità di affidamento
anche a società miste pubblico - privato. Successivi interventi legislativi hanno stabilito la possibilità
che le società miste potessero essere anche a maggioranza privata fino a prevedere
la trasformazione delle aziende municipalizzate in aziende speciali e poi in
vere e proprie società di capitali. Il recente disegno di legge sulla riforma dei servizi pubblici
locali sembra volersi dare alcuni obiettivi dichiarati: l) il miglioramento dell’offerta di servizi pubblici locali
e la precostituzione delle condizioni che assicurino servizi efficienti, una
quantità e una qualità adeguate alla domanda, a costi il più possibile contenuti,
garantendo l’universalità e la continuità della prestazione; servizi
insomma che meglio assolvano la funzione sociale e di supporto
allo sviluppo che deve essere loro propria; 2) la creazione di un mercato concorrenziale
fra gli operatori dei servizi pubblici locali; 3) il rafforzamento strutturale del sistema dei servizi pubblici
locali attraverso il raggiungimento di dimensioni ottimali di impresa e il coinvolgimento
di capitali privati per la realizzazione degli investimenti infrastrutturali
di cui il settore ha necessità. Sembra difficile, però, poter conciliare i fattori ora sottolineati:
l’universalità e la continuità della prestazione, e la conseguente funzione
sociale della prestazione, male si accorda con una visione concorrenziale del
mercato. I principi fissati nel provvedimento sono infatti: - l’affidamento del servizio esclusivamente in base a gara
pubblica cui possono partecipare solo società di capitali, senza
vincoli territoriali, con limiti predefiniti di durata degli affidamenti stabiliti
in modo da risultare non inferiori al periodo necessario alla realizzazione
di un coerente piano di investimento e non superiore al periodo di completamento
dell’ammortamento; - la separazione contabile interna alle società in caso di
più servizi gestiti nello stesso territorio; - la trasformazione in società di capitale delle
aziende pubbliche. In realtà l’aumento di efficienza e produttività è solo illusorio,
in quanto risulta molto difficile stabilire un nesso tra proprietà dell’azienda
e sua efficienza: gli indicatori tipici dell’efficienza e della produttività
aziendale non sono mai trasportabili dal privato al pubblico e viceversa sulla
base di semplici criteri quantitativi [4]. In particolare le trasformazioni investono gli enti locali
puntando ad un nuovo modello di Stato che comporta necessariamente lo smantellamento
dello Stato sociale: tale processo si fonda essenzialmente sulle privatizzazioni
ed è fortemente collegato a quel processo di decentramento che va sotto il nome
di "Federalismo". Il processo vede la redistribuzione dei poteri istituzionali
con l’individuazione di regioni e Comuni quali soggetti di riferimento (con
importanti qualificazioni delle Province per funzioni di programmazione in alcuni
settori specifici). Quali sono in Italia i servizi pubblici locali? Ci si può riferire
ai soli servizi per i quali esiste per legge un diritto di gestione esclusiva
da parte degli Enti locali (ad esempio la gestione dei rifiuti e dei servizi
cimiteriali) oppure si possono considerare i casi di intervento degli Enti locali
nella produzione di servizi. Qui il campo si allarga molto comprendendo servizi
a rete, socio-assistenziali, educativi, culturali, farmaceutici e via dicendo. Le competenze di regioni, provincie e comuni possono essere
riassunte nella seguente tabella: Gli obiettivi dello Stato nel settore dei pubblici servizi,
che sono servizi di pubblica utilità, resi alla collettività spesso in regime
di monopolio, sono: - la tutela degli interessi collettivi, intesi come qualità
e continuità dei servizi, libertà di accesso e parità di trattamento per gli
utilizzatori, diffusione del servizio sull’intero territorio nazionale; - il perseguimento di "obiettivi nazionali di politica
economica e industriale" ai sensi della legge 474 del 1994 [5]. Sempre secondo la legge 474 i settori portatori di questi interessi
collettivi e nazionali sono quelli della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni,
delle fonti di energia e degli altri pubblici servizi. Il recente Testo Unico degli Enti locali [6] stabilisce che gli enti locali,
ossia "i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane,
le comunità isolane e le unioni di comuni", provvedono alla gestione dei
servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte
a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
comunità locali. Questi servizi, definiti appunto "servizi pubblici locali"
possono essere gestiti: - in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche
del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un’azienda; - in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche,
economiche e di opportunità sociale; - a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più
servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; - a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali
senza rilevanza imprenditoriale; - a mezzo di s.p.a. o s.r.l. a prevalente capitale pubblico
locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora
sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio
la partecipazione di più soggetti pubblici o privati; - a mezzo di s.p.a. senza il vincolo della proprietà pubblica
maggioritaria. ----- Con il nuovo "Ordinamento federale" la Repubblica
è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni
(che sono enti autonomi con propri statuti) e dallo Stato. L’art. 119 della
Costituzione viene così riscritto: "i Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate
propri". Gli enti locali sono anche chiamati a compartecipare "al
gettito di tributi erariali" riferibili al loro territorio. Lo Stato "istituisce
un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacità fiscale per abitante". In più, sempre secondo la recente riforma
federalista, lo Stato dovrà provvedere a rimuovere gli squilibri economici e
sociali attraverso risorse aggiuntive che verranno destinate a favore di determinati
enti locali. Due sono gli inconvenienti possibili, secondo il Bonelli, che
scaturiscono da una privatizzazione dei servizi di pubblica utilità: 1) che il monopolio pubblico si trasformi in monopolio privato,
con possibili sovrapprofitti monopolistici e senza stimoli competitivi al miglioramento
dell’efficienza della qualità dei servizi; 2) che i servizi pubblici, gestiti in un’ottica esclusivamente
privatistica, non considerino gli interessi collettivi e non assicurino la continuità
e qualità dei servizi, la loro diffusione sull’intero territorio nazionale,
la libertà di accesso e la parità di condizioni per gli utilizzatori. "Il fenomeno più evidente che in passato ha fortemente
caratterizzato il dibattito sui servizi pubblici locali è rappresentato dalle
dimensioni e dalla dinamica dei disavanzi prodotti dalle aziende municipalizzate.
Spesso si tende a comparare costi e risultati economici conseguiti da imprese
pubbliche e private per concludere, nella maggioranza dei casi, che queste ultime
garantiscano esiti migliori. Da ciò non di rado discende una propensione ad
una estesa privatizzazione. Un tale approccio non tiene conto del fatto che
i risultati economici delle aziende pubbliche locali non sono che l’effetto
finale di un intreccio di problemi i quali a loro volta sono venuti sedimentandosi
nel tempo e traggono origine dalla natura stesse di tali aziende" [7]. Il processo di privatizzazione nel settore dei servizi pubblici
locali non avviene poi in maniera indiscriminata e non interessa ogni area e
ogni servizio. L’attività dei privati si concentra in realtà esclusivamente
sui segmenti di mercato che offrono maggiori margini di convenienza e remunerabilità.
La motivazione di fondo che ha condotto alla municipalizzazione "non ha
fatto riferimento alle proprietà naturali dei e dei servizi (proprietà che sono
alla base della definizione neoclassica di monopolio naturale) bensì ad un altro
aspetto, storicamente decisivo: la necessità cioè di assicurare la più estesa
fruizione di quei beni e servizi che, nelle condizioni storiche date, sono giudicati
essenziali a garantire uno standard minimo delle condizioni di vita dei cittadini" [8].
A partire dal secondo dopoguerra, la composizione dei servizi
pubblici si è andata articolando in: • servizi strategici (elettricità, telefonia, comunicazioni,
ecc.), soprattutto tramite il meccanismo delle aziende a partecipazione statale
(IRI, ENI, ENEL, EFIM, ecc.), che oggi vanno assumendo la forma di Public Utilities
Company; • servizi decentrati al livello comunale (trasporti, nettezza
urbana, ecc.), oggi gestiti direttamente o dati in appalto ad aziende private
o municipalizzate; • servizi forniti direttamente dalle pubbliche amministrazioni
(servizio postale, previdenza sociale, pubblica istruzione, servizio sanitario
nazionale, ecc.). In questo tipo di attività l’equilibrio tra i costi sostenuti
e i prezzi attribuiti è difficilmente riconducibile alle logiche di mercato,
perché diversi sono gli obiettivi che con questi servizi si intendono realizzare
e ciò dovrebbe valere anche nel caso di una riduzione della presenza dello Stato
e della P.A. nell’erogazione dei servizi. Ovviamente, più l’Ente erogatore è
vicino allo Stato, più forte è l’influenza della componente sociale. Il più
delle volte, il pagamento delle prestazioni pubbliche è assicurato in parte
dallo Stato ed in parte dall’utilizzatore, anche se la tendenza di questi ultimi
anni è quella di garantire il sostegno dello Stato esclusivamente agli aventi
diritto (i cittadini particolarmente svantaggiati), liberalizzando l’erogazione
dei servizi per tutti coloro i quali sono e saranno chiamati a pagare i servizi
stessi [9]. La prima tappa italiana del processo di privatizzazione può
essere fatta risalire al decreto legge n.333 del 1992 con il quale venne deciso
dal governo Amato la trasformazione degli enti pubblici economici ENEL, ENI,
IRI, INA in spa. Nel 1995 vendono messe a punto le carte dei servizi e varata
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas a cui sono trasferite le competenze
in materia di prezzi [10]. La riforma dei servizi pubblici locali doveva essere il passaggio
immediatamente successivo alla legge sulle autonomie locali del 1990: questa
riforma era ed è destinata a mettere fine, in un modo o nell’altro, alla storia
delle aziende municipalizzate La storia della municipalizzazione dei servizi
pubblici locali percorre, in definitiva, tutto il Novecento. Può essere lunga l’elencazione degli aspetti di debolezza e
di contraddizione dei processi di trasformazione dell’amministrazione pubblica
che si vive nel presente periodo storico. Grandi processi di trasformazione
sono in corso, processi che sono ampiamente determinati dal consolidamento e
dall’estensione dell’ordinamento comunitario e del suo principio fondante della
concorrenza come elemento costitutivo del mercato unico europeo. Negli anni
Novanta l’espansione del principio al mondo delle pubbliche amministrazioni
e dei servizi pubblici è rilevante. Si pensi alla direttiva 92/50/CEE in materia
di appalti pubblici di servizi, che impone alle Pubbliche amministrazioni l’obbligatorietà
della gara per l’affidamento dei servizi di distribuzione del gas, di gestione
del ciclo dell’acqua e di quello dei rifiuti, nonché del trasporto locale. La
gara diventa, insomma, obbligatoria per tutti i servizi a rete con caratteristiche
produttive tipicamente industriali [11], perché considerata
quale volano della concorrenza e dell’iniziativa imprenditoriale, quanto più
il modello prescelto è fondato sulle offerte economicamente più convenienti
e non soltanto sui prezzi. È un notevole capovolgimento: presuppone amministrazioni agguerrite
che mettano bene a punto gli obiettivi da raggiungere e ben preparino quindi
l’arena competitiva. Ciò significa avere una cultura delle gare e della competizione
che non è facile ad acquisire [12]. La riforma degli enti locali
prevede che la gara sia aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche
e di prestazione del servizio, del livello di qualità e di sicurezza, dei piani
di investimento per lo sviluppo delle reti e dei progetti di innovazione tecnologica
e gestionale: tutte queste variabili sono, come è stato giustamente notato [13] né facilmente quantificabili
e di complessa e problematica ponderazione. Per altri tipi di servizi diversi da quelli su elencati si
ha la possibilità di scelta tra: Possiamo così elencare i servizi pubblici locali: - Sanità - Previdenza - Trasporti delle persone e delle merci - Energia elettrica, gas - Risorse idriche - Rifiuti solidi e urbani - Sistema finanziario - Ricerca e cultura
a) Previdenza e sanità
In questo settore possiamo brevemente accennare ai casi degli
asili nido comunali (gestiti dal Ministero della Sanità) e alle farmacie comunali. Asili nido. Nascono come luogo di custodia per
i bambini delle lavoratrici e negli anni ’30 cominciano a sorgere i primi asili
ad opera dell’OMNI (Opera Maternità e Infanzia). L’art. 11 del Regolamento dei
Nidi OMNI recita: "L’asilo nido è un servizio della comunità per i figli
dei lavoratori o per bambini di famiglie gravemente impedite di attendere alla
loro cura". Nel 1960 l’UDI (Unione Donne Italiane) presentò una proposta
di legge per il passaggio delle competenze dall’OMNI alle amministrazioni locali;
nel 1965 vi fu una proposta di legge di iniziativa popolare per un servizio
nazionale di asili nido. Nel 1971 fu approvata la legge 1044 che istituiva gli
asili-nido comunali con il concorso dello Stato, approvazione resa possibile
anche grazie alle lotte di quegli anni e alle profonde trasformazioni economiche,
sociali e urbanistiche che avevano visto una forte immigrazione, il sorgere
dei quartieri dormitori, la scomparsa del verde e la trasformazione della famiglia
allargata in famiglia nucleare. Successivamente il servizio subì una positiva
evoluzione, una lenta ma progressiva espansione ed una connotazione educativa
oltre che assistenziale. Tuttavia i 3800 nidi che la legge 1044 prevedeva entro il 1975
non furono mai aperti; attualmente gli asili nido in Italia sono poco più di
2000 e coprono meno del 6% del numero dei bambini da zero a tre anni. Nel novembre 1998 il governo organizzò a Firenze la prima Conferenza
Nazionale sull’Infanzia durante la quale il Ministro della Solidarietà Sociale
annunciò l’intenzione di cambiare la legge sugli asili nido perché "li
frequenta solo il 6% dei bambini, sono concentrati nel Centro Nord, hanno lunghe
liste d’attesa, tariffe troppo alte, orari insufficienti. Con la riforma gli
asili-nido passeranno dal Ministero della Sanità a quello dell’Istruzione trasformandosi
da un servizio su domanda a sistema educativo per tutti". Tutto ciò sembra
essere stato contraddetto dagli stessi progetti di legge successivamente presentati
che affidano la gestione dei nidi ai privati (finanziati con denaro pubblico),
non fanno stime della domanda, non programmano obiettivi di espansione, non
prevedono il passaggio dal Ministero della Sanità a quello dell’Istruzione.
È sbagliato pensare di espandere il Nido tramite il privato che in questi anni
ha investito pochissimo nella gestione degli asili nido, nonostante la gran
richiesta, perché per trarne profitto occorre far pagare rette molto alte che
la maggior parte dei genitori non possono sostenere [14].
Il servizio farmaceutico comunale
Le farmacie pubbliche, dette generalmente farmacie comunali,
sorsero agli inizi del secolo scorso per aiutare i poveri del Comune quando
i costi dei medicinali erano per loro insopportabili. La loro nascita fu quindi
motivata da un unico scopo: migliorare la qualità della vita a quei cittadini
che alla miseria assommavano anche la malattia. Successivamente le farmacie
comunali si assunsero anche il compito di una distribuzione capillare del servizio
nel territorio portando le farmacie nelle frazioni, dato che i privati preferivano,
per motivi di ordine economico, aprirle nelle sole vie centrali e commerciali
delle città. Negli anni recenti però si è assistito alla rincorsa dei Comuni
a trovare risorse finanziarie per rimpinguare le disastrate casse comunali e
in questa logica si è pensato di vendere le farmacie comunali. Ciò è senza dubbio
un grosso errore economico, in quanto oggi una farmacia comunale riesce a dare
un coefficiente di redditività superiore al 5% ed inoltre essendo una struttura
imprenditoriale da sempre abituata al regime della concorrenza, in alcuni comuni
rappresenta l’unica esperienza di gestione aziendale. Ci sono poi ovviamente motivi di ordine sociale che spingono
per evitare la vendita di questo prezioso servizio pubblico. Le farmacie comunali sono infatti un orecchio privilegiato
sui bisogni della cittadinanza in campo sanitario e si differenziano da quelle
private per le molteplici attività svolte in campo sociale, tra cui: campagne d’informazione condotte da farmacisti (ad esempio su AIDS, fumo,
educazione sessuale, etc.); - distribuzione, in alcuni comuni, di siringhe e/o profilattici,
attraverso distributori automatici; - misurazione gratuita della pressione arteriosa ai pensionati; - distribuzione gratuita di opuscoli sanitari su vari argomenti; - raccolta di farmaci scaduti.
b) Trasporto pubblico:
Il D. LEG. 422/97 intitolato “Conferimento alle Regioni ed
agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale
a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n° 59” disciplina: • trasferimento di compiti e funzioni per tutti i trasporti
pubblici operanti a livello regionale o infraregionale (art. 4); • definizione dei trasporti pubblici di interesse nazionale
esclusi dal conferimento (art. 3) e riserva di competenza statale su trasporti
locali (servizi transfrontalieri, sicurezza, ambiente); • delega a regioni delle funzioni programmatorie e trasferimento
a enti locali da parte delle regioni con legge entro sei mesi sulla base dei
principi e dei criteri stabiliti dalla 59/97 (artt. 7-13); • programmazione regionale coordinata in sede di conferenza
stato-regioni; accordi di programma regione-ministero per investimenti.----- Fino al 1995 i trasporti pubblici locali erano disciplinati
dalla legge 151 del 1981. Con la legge 549 del 1995 sulle "misure di razionalizzazione
della finanza pubblica" la prospettiva cambiò radicalmente in quanto: - vengono trasferite le competenze alle regioni; - vengono forniti alle regioni stesse gli strumenti finanziari
per assolvere tali funzioni. In termini di gestione si trasferiscono alle amministrazioni
regionali e locali il personale, i beni strumentali e le risorse necessarie
all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale [15].
c) Settore idrico
Anche in questo settore è prevalsa la logica neoliberista che
vede nella gestione privata la cura migliore per sanare le inefficienze del
sistema. La "legge Galli" si propose infatti di dare
a tutta la materia un nuovo assetto in grado di assicurare da un lato il servizio
idrico integrato secondo dimensioni ottimali e dall’altro di consentire l’afflusso
di capitali privati soprattutto in fatto di gestione più che di nuove realizzazioni. Diversi punti meritano la nostra attenzione: • Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte
dal sottosuolo, sono pubbliche; • L’uso dell’acqua per il consumo umano è prioritario rispetto
agli altri usi del medesimo corpo idrico; • Le direttive generali sono di competenza dello Stato (programmazione
della razionale utilizzazione delle risorse, criteri per la gestione del servizio
idrico integrato, misure per il risparmio idrico, modalità per il riutilizzo
delle acque reflue, criteri in materia di trattamento delle acque reflue, ecc.); • La competenza delle Regioni riguarda la delimitazione degli
ambiti territoriali ottimali, il superamento della frammentazione delle gestioni
e il controllo degli scarichi inquinanti; • La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico,
determinata tenendo conto, fra l’altro, della qualità della risorsa e del servizio
fornito; Nella sostanza questa legge mirava a risolvere tre punti fondamentali
della crisi dell’attuale sistema idrico: 1. La frammentazione delle gestioni: non sempre i piccoli
enti possono garantire una corretta gestione del servizio, per cui occorre passare
a dimensioni più ampie delle attuali. 2. La frammentazione del ciclo: il trattamento, la
distribuzione e la depurazione dovranno essere controllati da una unica struttura
che si occuperà della gestione del ciclo integrale. 3. Lo scompenso tra le tariffe ed il costo del servizio:
il bilancio dovrà essere chiuso in pareggio. Questa legge tuttavia non è sufficiente da sola per avere un
valido servizio nel settore; non dimentichiamo che la corretta attuazione della
183 sulla difesa del suolo, che la legge Galli richiama e ingloba, prevede che
le autorità di bacino definiscano e aggiornino periodicamente il bilancio idrico
diretto ad assicurare l’equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili
o attivabili nell’area di riferimento e i fabbisogni per i diversi usi. L’abolizione dell’attuale frammentazione del servizio però
non significa necessariamente passare ad una gestione imprenditoriale del "servizio
idrico integrato", come invece vorrebbe la legge [16].
d) Rifiuti solidi e urbani
Nel 1999 Legambiente e FISE Assoambiente hanno realizzato una
ricerca [17],
la prima del genere nel nostro Paese, con l’obiettivo di fornire un’immagine
attendibile sulla gestione dei rifiuti industriali in Italia. L’indagine ha
analizzato le dichiarazioni registrate con il MUD (Modello Unico di Dichiarazione)
nel 1997 (dati relativi al 1996) e le dichiarazioni fornite direttamente dalle
regioni e dalle province. Sono queste infatti i soggetti preposti al rilascio
delle autorizzazioni all’esercizio degli impianti di smaltimento e trattamento
dei rifiuti. Cosa è emerso in sintesi da questa ricerca? La produzione di rifiuti registrata con il MUD nel 1996 è stata
di circa 22,5 milioni di tonnellate; le regioni maggiormente produttrici di
rifiuti sono risultate Lombardia, Veneto e Piemonte; il divario tra Nord e Centro-Sud
è sottolineato poi dal confronto con il PIL (a prezzi di mercato 1995), come
può essere facilmente dedotto dalle tabelle riportate. ----- I rapporti prodotti dalla Commissione Bicamerale di inchiesta
sui traffici illeciti di rifiuti, così come il lavoro svolto dall’Osservatorio
ambiente e legalità in collaborazione con le forze dell’ordine riportano una
tendenza a far viaggiare i rifiuti dal Nord verso Sud e questo è un punto di
riflessione sulla gestione dei rifiuti nel nostro paese. Sempre a questo proposito
va poi sottolineato che le autorizzazioni per il conferimento in discarica o
in inceneritore vengono rilasciate alle imprese dalle regioni o dalle province
sulla base di una richiesta riferita a quantitativi e tipologie di rifiuto da
trattare e non in base ad una adeguata valutazione dell’effettivo fabbisogno
del bacino. La ricerca di Legambiente, inoltre, fa rilevare che dal confronto
dei dati relativi alle comunicazioni dell’effettiva produzione e dell’effettivo
smaltimento rilevate tramite i MUD in ogni regione con le autorizzazioni rilasciate
si conferma il dato già segnalato della non rispondenza fra il fabbisogno di
smaltimento, la capacità autorizzata e la disponibilità impiantistica. Risultano
infatti regioni quali la Lombardia, il Piemonte, la Toscana, la Puglia e la
Sicilia che a fronte di una capacità autorizzata allo smaltimento esportano
i rifiuti prodotti verso altre regioni. Ci sembra importante fermarsi a riflettere
sui risultati ottenuti da Legambiente perché forse più degli altri settori,
quello dei rifiuti è facilmente preda di speculazioni: l’illusione che una gestione
privatizzata del settore possa sanare le lacune fa presagire il pericolo che
la logica del profitto prevalga sugli aspetti socio-sanitari che invece devono
essere prevalenti nella gestione di tale settore. Va da sé che tali ultime considerazioni vanno fatte anche nel
caso degli altri servizi pubblici.
e) Settore energetico (elettricità e gas)
Una caratteristica peculiare della distribuzione del gas è
la presenza tra i gestori di molti imprenditori privati accanto alle aziende
pubbliche. Il Governo ha avviato la liberalizzazione del gas con la separazione
societaria tra trasporto e distribuzione, e la possibilità di ingresso per distributori
e clienti di piccole dimensioni (entro i 200 mila metri cubi annui). Vale la pena citare alcuni dati che chiariscono la struttura
del settore. In quasi quattromila Comuni, pari a circa il 60% delle utenze,
il servizio è fornito da operatori privati di cui solo 6 di grandi dimensioni
tra cui Italgas che rappresenta circa il 30% del mercato. La forte presenza
di operatori privati nel settore gas richiederebbe la necessità di norme che
tengano conto delle particolari condizioni che verrebbero a crearsi nei casi
di interruzione delle concessioni in essere considerato che queste superano
di gran lunga l’eventuale periodo di proroga di cinque anni. Un altro aspetto critico è rappresentato dal passaggio dal
vecchio gestore privato proprietario delle reti al nuovo a seguito di affidamento
del servizio mediante gara pubblica. In tal caso si reputerebbe opportuno introdurre un sistema
che garantisca l’indennizzo al gestore uscente degli impianti. Il riferimento al valore contabile degli impianti contenuto
nel testo in discussione è inadeguato in quanto corrisponde in genere ad una
sottostima del valore economico del bene. Preferibile appare il principio della valutazione a valore
industriale degli impianti. La realtà delle aziende pubbliche e dei servizi pubblici locali
(acqua, gas, rifiuti, elettricità, trasporti) si presenta ricca ed articolata
ed infatti le aziende pubbliche locali si distinguono tra loro per numerosi
aspetti. Ci sono i monopoli tecnici, come nel caso dei servizi a rete (gas,
elettricità); esistono servizi (come i trasporti) caratterizzati da un elevato
livello di concorrenzialità da parte di servizi succedanei (le auto private
individuali); servizi che operano sostanzialmente in condizioni di mercato (come
le farmacie comunali) e servizi in cui è evidente la presenza di esternalità
(igiene ambientale) [18]. In tutti i casi, comunque, si sente una grande esigenza
di controllo del territorio, di interventi qualificati, di estensione di servizi
fondamentali, in altre parole di una grande capacità di programmazione. Paradossalmente, invece, si assiste ad una vera e propria "svendita"
del patrimonio professionale e gestionale costruito dal pubblico in questi anni. Occorre invece rilanciare la necessità un ruolo d’intervento
al "pubblico" in questi settori importanti e delicati, di puntare
al governo del territorio coinvolgendo lavoratori ed utenti, rilanciando l’occupazione
su questo terreno "di qualità". Bisogna difendere il lavoro, garantire
l’occupazione; definire seri piani industriali per le aziende del settore; mantenere
il controllo pubblico delle aziende del settore [19]. Nel caso della privatizzazione dei servizi pubblici locali
il monopolio passerebbe dal pubblico al privato in quanto l’affidamento del
servizio tramite gara, assegna al vincitore la gestione "monopolistica"
da un minimo di 9 anni (per i trasporti) ad un massimo di 20 anni (ciclo delle
acque). Inoltre le tariffe, saranno determinate dalle imprese gestori,
in relazione al rientro degli investimenti. Si innesca il meccanismo della competitività,
obbligando le imprese pubbliche a ridurre i costi di gestione, agendo sul costo
del lavoro, mettendo a rischio l’occupazione e i livelli salariali, nonché il
quadro di tutela dei diritti del secondo livello contrattuale. Sarebbe invece preferibile modificare il testo del d.d.l. 7042
reintroducendo l’autonomia di scelta da parte degli enti locali in relazione
alle forme di gestione, mantenendo in tal senso il testo originario dell’art.
22 della legge 142/90; così come sarebbe auspicabile che tra le facoltà dell’ente
locale vi sia anche la procedura di affidamento diretto dei propri servizi a
propri enti strumentali o a società a prevalente capitale pubblico. I soggetti interessati alla riforma e cioè l’Anci (Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani), l’Unione delle Provincie Italiane, l’Uncem (Unione
Nazionale delle Comunità Montane), la Cispel (Confederazione Italiana dei Servizi
Pubblici Locali), la Confindustria e l’Eni, tutti sia pur con diverse sfumature,
hanno condiviso la scelta legislativa di selezionare l’offerta di servizi pubblici
locali a rilevanza industriale (erogazione di energia non elettrica, erogazione
del gas, gestione del ciclo dell’acqua, gestione dei rifiuti solidi urbani e
servizi di trasporto collettivo) attraverso lo svolgimento di gare pubbliche. Soltanto Anci e Cispel in merito alla modalità di affidamento
del servizio hanno difeso, in nome della discrezionalità amministrativa, il
principio della scelta fra affidamento diretto e gara.
Oltre che per l’ammontare e la tipologia delle prestazioni
la Pubblica Amministrazione presenta un notevole interesse economico anche per
il volume di occupazione assorbito e, quindi, per l’influenza che esercita nel
mercato del lavoro. Le politiche di privatizzazione e liberalizzazione dei servizi
della Pubblica Amministrazione, attuate nel corso degli anni 90, hanno profondamente
inciso anche e soprattutto sull’occupazione che si presenta oggi profondamente
modificata e deteriorata, con un tasso di disoccupazione ancora a due cifre
e tra i più alti in Europa; una crescita del lavoro nero e in generale del lavoro
povero, precario e privo di tutele; un tasso di occupazione della popolazione
in età lavorative tra le più basse tra tutti i paesi industrialmente avanzati,
che penalizza soprattutto le donne (il cui tasso di partecipazione al mercato
del lavoro in Italia supera di poco il 34%), i giovani e le popolazioni meridionali. Attualmente nell’area dell’OCSE i disoccupati raggiungono i
36 milioni di unità, pari all’8% delle forze di lavoro, e il fenomeno presenta
sicuramente un aspetto di persistenza. Va detto che, a partire dagli anni ottanta la forza contrattuale
dei sindacati e dei lavoratori è scemata. “All’eccesso del rapporto salario/produttività
rispetto a una norma di pieno impiego è seguita una redistribuzione del reddito
a favore del profitto” [20].
E questo ha reso possibile il sopravvento dell’economia capitalista sull’economia
“sociale”: il mercato è stato così reinterpretato solo in termini di saggio
di profitto, il quale postula a sua volta efficienza nel processo produttivo
senza tener conto degli aspetti socio-redistributivi che invece sono determinanti
se si vuole tener conto anche dell’altro aspetto della medaglia, ovvero l’equità. Questo sopravvento del profitto sul salario, a tutto danno,
ovviamente, della classe lavoratrice e, ancor più, della classe dei disoccupati,
trova terreno fertile nella caduta di generosità dei sistemi di protezione sociale
(fenomeno oggi sempre più diffuso in tutte le aree geografiche). Inoltre “sebbene
il peso del terziario sia cresciuto ovunque, l’integrazione internazionale più
stretta, l’emergere di nuovi ruoli, le politiche antitrust e di deregolazione
hanno probabilmente intensificato la concorrenza nei mercati del prodotto” [21] e tale percezione si è estesa
ai rapporti di lavoro. “Alla cautela delle famiglie nella spesa per consumi
non sono estranei i timori di riduzione delle garanzie nel rapporto di lavoro
e nel sistema di protezione sociale; la flessibilità dell’occupazione accresce
a propria volta l’incertezza delle prospettive”.----- Spesso si attribuisce alla non-flessibilità la colpa di una
disoccupazione, proponendo come facili risoluzioni risposte quali la flessibilità,
e di conseguenza la privatizzazione e la liberalizzazione dei rapporti di lavoro,
o il riferimento ad assetti del mercato del lavoro (americano o inglese) considerati
ideali, da esportare innestandoli in ambienti economici, giuridici, culturali,
profondamente diversi senza pensare che le particolarità dei mercati del lavoro
andrebbero considerate come aspetti fondamentali di realtà economiche e sociali
ben specifiche. La privatizzazione dei servizi pubblici locali discende poi
da quel principio di federalismo e decentralismo che ha riflessi enormi anche
sulle relazioni industriali. Ed infatti l’affidamento alle Regioni della materia
di tutela e sicurezza del lavoro può aprire la strada anche ad un federalismo
contrattuale secondo cui ogni Regione potrebbe creare un proprio statuto dei
lavoratori. La contrattazione nazionale perderebbe così significato e forza
a tutto vantaggio di una contrattazione territoriale che potrebbe sfociare,
con il passare del tempo, in una contrattazione ad personam con la perdita totale
di qualsiasi tipo di garanzia per i lavoratori, soprattutto i più deboli: donne,
giovani, persone in cerca di prima occupazione. Per questo Anci e Cispel hanno richiesto che nei processi di
privatizzazione vengano previste opportune garanzie per il personale dipendente
delle aziende che dovranno lasciare gli affidamenti: la proposta è quella dell’applicazione
del disposto dell’articolo 2112 del Codice Civile il quale prevede la salvaguardia
del rapporto di lavoro in caso di trasferimento di azienda. Tra i diversi aspetti del processo di privatizzazione due sembrano
particolarmente importanti: 1) l’estensione al sistema pubblico dell’accordo sul costo
del lavoro del 23 luglio 1993 che ha posto il vincolo della moderazione salariale
ancorando gli incrementi retributivi nel corso dei rinnovi contrattuali al tetto
di inflazione programmata. La necessità del contenimento della spesa è stata
la causa principale delle critiche rivolte al decreto legislativo 29/1993 e
di riflesso ai CCNL circa la rigidità nell’utilizzo delle risorse anche nella
sede decentrata; 2) il tentativo di armonizzare le regole che disciplinano il
rapporto di lavoro pubblico a quelle del settore privato [22]. L’adattamento delle nostre economie alle continue evoluzioni
del mercato spinge sempre più verso forme più o meno estese di privatizzazione
che a loro volta danno impulso a nuove forme contrattuali: tra queste vanno
sottolineate le forme di contratti temporanei, uno degli aspetti senz’altro
più evidenti nel mercato del lavoro europeo degli anni novanta. Da più parti
viene esaltato il contributo dei contratti temporanei alla crescita dell’occupazione:
in realtà per analizzare in maniera esauriente tale contributo “occorre capire
in che misura la performance insoddisfacente della crescita dei posti di lavoro
coperti da contratti permanenti sia una conseguenza indiretta della crescita
dei contratti temporanei. In effetti, sembra che in alcuni paesi, tra cui Germania,
Francia e Italia, i contratti temporanei abbiano sostituito posti di lavoro
coperti da contratti permanenti. Sebbene questa sostituzione rappresenti un
modo per rendere il mercato del lavoro più flessibile, gli effetti di lungo
periodo di questo fenomeno possono essere molto negativi. Con il passare del
tempo infatti, un’eccessiva quota di posti di lavoro coperti da contratti temporanei
(soprattutto tra i giovani) riduce gli incentivi dei lavoratori ad apprendere
professionalità specifiche del posto di lavoro” [23]. I dati dell’Istat suggeriscono che l’occupazione temporanea
è un fenomeno molto più radicato al Sud dove rappresenta il 14% dell’occupazione
dipendente, rispetto al Nord e Centro, dove non supera il 9%. Sempre dai dati
dell’Istat risulta che nel 2000 oltre il 60% dei nuovi posti di lavoro creati
in Italia sono posti di lavoro a tempo determinato: ma quanti di questi contratti
a termine si trasformano successivamente in rapporti di lavoro stabili? Nel
Mezzogiorno per le persone il cui primo impiego è stato a tempo determinato
dopo 3 anni appena il 5% gode di un’occupazione permanente, contro il 22% nel
Centro e il 30% nel Nord. Gli esiti occupazionali a 5 anni di distanza dall’ingresso
sono ancora più differenziati: l’entrata nel mercato stabile coinvolge quasi
il 50% dei giovani occupati al Nord, il 37% al Centro e solo il 15% al Sud. La progressiva diffusione di queste forme lavorative (contratti
a tempo parziale e svariate tipologie contrattuali a tempo determinato) è avvenuta
ai danni dell’occupazione standard. Il “nuovo mercato del lavoro” si presenta
molto articolato, con forti processi di segmentazione e stratificazione sociale.
Alla tradizionale contrapposizione tra chi ha un lavoro e chi non ce l’ha si
sommano quelle tra chi ha un lavoro continuativo e chi no, tra chi ha un lavoro
tutelato e chi no [24]. ----- "In base alla riflessione marxiana gli unici tipi di società
che veramente non conoscono una distinzione fra privato e pubblico sono le società
semplici (cd. Primitive) e le società che Marx chiama "modo di produzione
asiatico. Tutti gli altri tipi di società conoscono, in qualche modo, una sfera
privata (del particolare) e una sfera pubblica) (...). Nella formazione sociale
capitalista, infine, la comunità (considerata da Marx essenzialmente come forma
di proprietà degli individui che lavorano in modo associato) viene radicalmente
distrutta, ed emerge l’anarchia del mercato, che conosce soltanto il singolo
borghese, il proprietario capitalista isolato, che produce ed agisce privatisticamente
dietro l’impulso del movente del profitto. Siamo qui all’atomizzazione della
società in attori puramente individuali, che agiscono secondo un calcolo esclusivamente
utilitaristico tendente alla massimizzazione del benessere privato" [25]. Il problema dei servizi pubblici è la proprietà pubblica delle
aziende che erogano il servizio ed il connesso diritto ad esercitare il servizio
in regime di monopolio. La soluzione proposta è quindi quella di privatizzare
le aziende pubbliche e introdurre la concorrenza, sicuri che in tal modo si
avranno servizi pubblici efficienti, ad un prezzo più basso, maggiormente aderenti
alle esigenze del "cittadi-no/cliente" e di alta qualità. Questa impostazione
produce comportamenti finalizzati a raggiungere livelli sempre maggiori di competizione,
individuando un sistema in cui il mercato sembra essere l’istituzione più aderente. Le ideologie di stampo neoliberista vedono nella natura decentralizzata
delle decisioni economiche di un settore privato e nell’ambiente competitivo
in cui vengono prese l’humus necessario per l’affermazione di una efficiente
allocazione delle risorse. Da questo punto di vista l’intervento statale può
essere giustificato solo da qualche forma di fallimento del mercato.
L’intervento del governo è richiesto quando i benefici del processo decisionale
collettivo pesano più della perdita del processo decisionale decentralizzato
individuale ed è spesso giustificato da: a) protezione dell’industria e di gruppi vulnerabili; b) mercato del credito sottosviluppato; c) esternalità positive legate all’educazione, alla salute,
alle infrastrutture; d) ruolo redistributivo del settore pubblico [26]. La logica dell’intervento statale deve avere radici nell’assunto
che in alcune aree il mercato funzioni poco o male, o che la società si proponga
altri obiettivi oltre l’efficienza economica, come per esempio la distribuzione
della ricchezza. Tra le cause possibili di fallimento del mercato c’è quella
dell’esistenza di beni pubblici [27]. Possiamo quindi stabilire
tre requisiti necessari ai fini di in un intervento statale nell’economia: 1. La maggior parte dei mercati non sono pienamente concorrenziali,
per cui non si raggiunge un risultato efficiente; 2. L’efficienza che è la principale caratteristica dei mercati
concorrenziali, è solo una delle componenti del benessere sociale; 3. Il funzionamento del mercato può essere considerato non
auspicabile poiché ricompensa un tipo di comportamento ritenuto socialmente
indesiderabile. Il mercato favorisce la competitività e l’etica della sopravvivenza
del più forte a spese dell’iniziativa cooperativa e dei valori competitivi. Quindi la partecipazione dello Stato alla riallocazione delle
risorse è giustificabile perché in alcune situazioni (quella dei beni e servizi
pubblici è da sottolineare) sono necessarie contemporaneamente: - Equità, in quanto viene incoraggiata una distribuzione più
equa di beni e servizi tra i membri della società; - Efficienza, poiché si promuove l’efficienza in situazioni
di fallimento del mercato. Il prodotto tipico dell’amministrazione pubblica cioè quei
beni e servizi che hanno effetti su tutta la collettività è formato da beni
pubblici; rendere disponibili tali beni è uno dei principali scopi dell’intervento
pubblico e, nello specifico, dell’identificazione di meccanismi atti ad ottimizzare
le scelte collettive [28]. "Creare le condizioni per una concorrenza efficace non
è compito facile e la privatizzazione e la deregulation indiscriminate rappresentano
scorciatoie tutt’altro che raccomandabili. È possibile allargare gli spazi per
l’operare di imprese private, ma anche nulla garantisce che il mercato lasciato
a se stesso dia luogo a soluzioni economicamente ed allocativamente efficienti
per gran parte dei servizi pubblici" [29]. "In tutti i paesi del capitalismo occidentale contemporaneo
abbiamo di fronte non semplicemente una maggior complessità sociale ma anche
novità radicali come ad esempio processi di privatizzazione per quanto riguarda
i consumi di cittadinanza. Sinteticamente matura con grande accelerazione nella
condizione del lavoro e nella condizione sociale una nuova "questione sociale"
in tutti i paesi dell’occidente capitalistico e la necessità di una nuova politica
sociale che vada al di là dell’antica dicotomia Stato/Mercato: politica che
assuma come fondamento il diritto all’inserimento, come obiettivo permanente
l’integrazione, come dimensione la persona e la territorialità, come cultura
un’idea di cittadinanza non puramente lavoristica, come modalità l’economia
sociale e cooperativa, come perno il ruolo del pubblico come stratega, come
consumo il passaggio dai consumi privati di massa ai consumi sociali, ai cosiddetti
beni relazionali" [30]. "Secondo un documento del FMI", ci fa notare il Giannone,
"il perseguimento di una politica dell’equità favorisce direttamente o
indirettamente lo sviluppo economico. Ed infatti una maggior spesa per la salute
o per l’istruzione più che con la concessione di sussidi o l’applicazione di
imposte progressive, rafforza nel lungo andare lo sviluppo economico che a sua
volta contribuisce ad alleviare la povertà. Infine, non vi è dubbio che interventi
governativi intesi a diminuire la diseguaglianza della distribuzione dei redditi
rafforzano la coesione sociale e diminuiscono i rischi di conflitti sociali.
È anche vero però che questa politica ha bisogno di un largo sostegno, senza
escludere, inoltre, che alcuni interventi governativi come, ad esempio, la privatizzazione,
accrescano nel breve termine la disoccupazione o peggiorino la distribuzione
delle risorse" [31]. Quando si punta il dito contro i processi di privatizzazione
non si vuole certo negare la validità di alcune affermazioni, come ad esempio
quella che vuole il trend di cambiamento dei prossimi anni centrarsi sullo sviluppo
anche della qualità delle infrastrutture, sviluppo che costituisce senz’altro
un elemento chiave per la sopravvivenza del sistema economico [32].
Così come è vero che l’inefficienza delle infrastrutture causata da mancato
sviluppo e da inadeguata manutenzione costituisce un grave deficit per un Paese
e riflette anche una scarsità di investimenti di capitale, di solito in prevalenza
pubblico; la Pubblica Amministrazione chiamata istituzionalmente ad assicurare
servizi per lo sviluppo della società ha un peso fondamentale nella determinazione
dei costi di transazione, intesi questi ultimi come costi del processo di negoziazione
per procurarsi le risorse (umane, finanziarie, tecnologiche, temporali e spaziali)
ritenute indispensabili per realizzare gli obiettivi scelti [33]. Viene però spontaneo chiedersi
se la qualità e l’efficienza passino solo e necessariamente attraverso un approccio
"privato" delle gestioni o se, invece, accanto ad esse non debba considerarsi
appunto un terzo fattore: quella politica dell’equità a cui accennava Giannone.
Una lettura del DPEF 2000-2004 non fa poi altro che aumentare i dubbi e le riflessioni
quando afferma che "il Governo ipotizza che una parte significativa dei
nuovi investimenti in infrastrutture di interesse pubblico nel 2002, 2003 e
2004 possa essere finanziata direttamente da capitale privato" e continua
"migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi è possibile liberalizzando
e privatizzando i mercati nei settori aereo, marittimo, ferroviario e autostradali".
Questa tendenza a livello centrale non fa altro che propagarsi alle strutture
decentrate di gestione locale che abbagliate dall’ottica di una concorrenza
che tutto può e tutto rimedia, perde di vista quell’elemento fondamentale dell’equità,
a danno di un welfare che dovrebbe realizzare un reale sistema di protezione
sociale che si fa carico dei vari disagi sociali, anche e soprattutto a partire
dai servizi basilari della collettività. Vero è che la concorrenza è un processo
di "distruzione creativa" caratterizzato dal ruolo di nuovi imprenditori
e nuovi imprese, ma tale attività innovativa si associa a costi crescenti degli
investimenti in ricerca e sviluppo e ad un’elevata rischiosità dei progetti,
portando al predominio delle imprese più grandi e all’innalzamento di barriere
all’entrata [34].
Una politica per l’efficienza dei servizi pubblici non è poi senza costi: l’efficienza
allocativa infatti richiede infatti una struttura tariffaria uniforme e non
rispettosa dei costi marginali effettivi. Eventuali fini redistributivi andrebbero
in tal caso perseguiti con altre forme intervento che aumenterebbero i costi
totali [35]. Per questo si può affermare che i processi di privatizzazione
hanno costituito lo strumento più efficace di distruzione dei servizi sociali
e ciò è avvenuto purtroppo anche con il consenso di gran parte dell’opinione
pubblica che, bollando come incapaci, parassiti e nulla facenti i lavoratori
ha accolto con favore la concessione al privato della gestione diretta dei servizi
pubblici. ----- 1. AA.VV., "Un supporto decisionale per le aziende
del trasporto pubblico locale", Quaderni ISRIL, 1/1996. 2. AA.VV., "La riforma della P.A.: un percorso
accidentato, ricco di prospettive ma avaro di risultati", Quaderni ISRIL,
2-3/1998. 3. Agostini Luigi, "Welfare locale - Assessorato
sociale - Sindacato", Impresa Sociale, 46/1999. 4. Alvaro Giuseppe, Contabilità nazionale e statistica economica, Cacucci
editore, 1999. 5. “Appunti sulla liberalizzazione del mercato elettrico”,
1999, in: www.rifondazione.it/energia. 6. AREA, "Entrate tariffarie e trasferimenti nel
finanziamento dei servizi pubblici in disavanzo", Firenze, Cispel, 1986. 7. Banca d’Italia, Relazione Annuale, 1999 8. Billia Gianni, "Un sistema lento condiziona
la competitività", L’Impresa, 4/1998. 9. Bonelli Franco, "La privatizzazione delle imprese
pubbliche", Giuffrè editore, 1996. 10. Cassese Sabino, Franchini Claudio (a cura di),
“L’amministrazione pubblica italiana. Un profilo”, Il Mulino, 1994. 11. Ciocca Pierluigi (a cura di), “Disoccupazione di
fine secolo. Studi e proposte per l’Europa”, Torino, Bollati Boringhieri, 1997. 12. CNEL (IV° Commissione per le politiche dei fattori
orizzontali), "Il sistema paese come fattore di competitività: i servizi
pubblici, le politiche di coesione, la cittadinanza europea" Roma, 13 aprile
1999. 13. Coordinamento Sostenitore della proposta
di legge di iniziativa popolare "L’asilo nido: un diritto delle bambine
e dei bambini", Cercasi nido disperatamente, novembre 2000, in:
www.ecn.org/reds/nidibollettino.html 14. D’Albergo Ernesto, Vaselli Paolo, “Un’amministrazione
imprenditoriale? Il cambiamento nel sistema pubblico fra apprendimento e ipocrisia”,
Edizioni Seam, 1997. 15. Di Majo Antonio (a cura), "Le politiche di
privatizzazione in Italia. 3° Rapporto CER/IRS sull’industria e la politica
industriale italiana", Il Mulino, 1989. 16. Donati Pierpaolo, “Pubblico e privato. Fine di
un’alternativa?”, Nuova universale Cappelli, 1978. 17. Fazio Antonio (intervento di), "Concorrenza,
sviluppo e sistema bancario", Bollettino Economico della Banca d’Italia,
n. 35, 2000. 18. Fotia Mauro, “Profit State e crisi delle democrazie
contemporanee”, Quaderni Cestes n. 4. 19. Franco Daniele, “L’espansione della spesa pubblica
in Italia”, Il Mulino, 1993. 20. Gelmini Marco, “Le trasformazioni nel settore energia”,
in: www.rifondazione.it/energia/ 21. Giannone Antonino, "La convergenza delle economie
delle regioni italiane", Studi e Note di Economia, 2/2000. 22. Huther J., Roberts S., Shah A., Public expenditure
reform under adjustement lending. Lessons from World bank experiences, WORLD
BANK discussion paper n. 382, 1997. 23. HyC-HYDROCONTROL (Centro di Ricerca e Formazione
per il Controllo dei Sistemi Idrici), "Disposizioni in materia di risorse
idriche, Legge n. 36 del 5 gennaio 1994", Cagliari . 24. Istat, “Rapporto sull’Italia. Edizione 2000”, Il
Mulino, 2000. 25. Istat, La rilevazione rapida dei bilanci comunali
- Anno 1999 - Note rapide (20 aprile 2001) 26. Istat, Statistiche ambientali, 2000 27. Labarile Giuseppe, "Un occhio al mercato e
uno alla riforma", Guida agli Enti Locali, n. 44, 2000. 28. Legambiente/FISE-Assoambiente, "Indagine sulla
produzione e lo smaltimento dei rifiuti industriali", marzo 1999, in: http://www.e-gazette.it/ 29. Luci ed ombre dei contratti temporanei, in http://www.frdg.org 30. Morcaldo G., La finanza pubblica in Italia, Il
Mulino, 1993 31. "Privatizzazioni e relazioni industriali", in:
http://www.geocities.com/Athens/2753/materiali/privrelind.htm. 32. Proteo, diversi numeri, articoli su P.A., privatizzazioni
e federalismo di R. Martufi, A. Salerni, L. Vasapollo. 33. Ristuccia Sergio, “La trasformazione dei servizi
pubblici locali”, in: www.servizilocali.com/it. 34. Stokey Edith, Zeckhauser Richard, “Introduzione
all’analisi delle decisioni pubbliche”, FORMEZ, 1988. 35. Testo Unico sugli Enti Locali, Decreto Legislativo
n. 267/2000.2. Enti locali e privatizzazioni
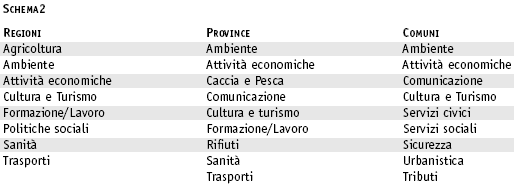
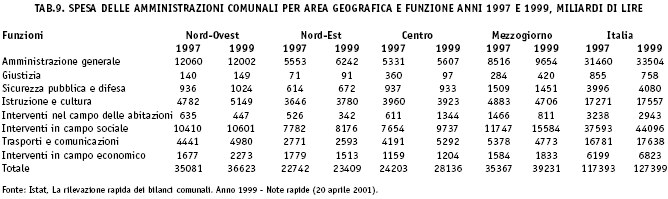
3. I servizi privatizzati
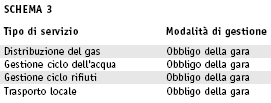
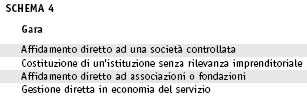
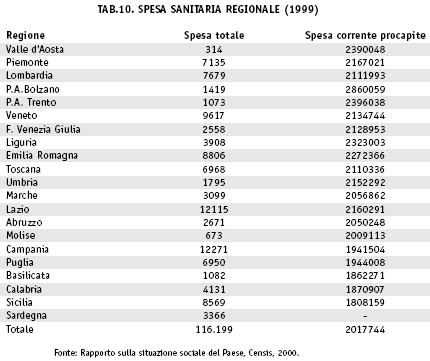
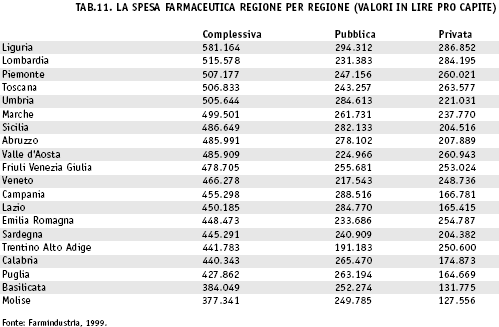
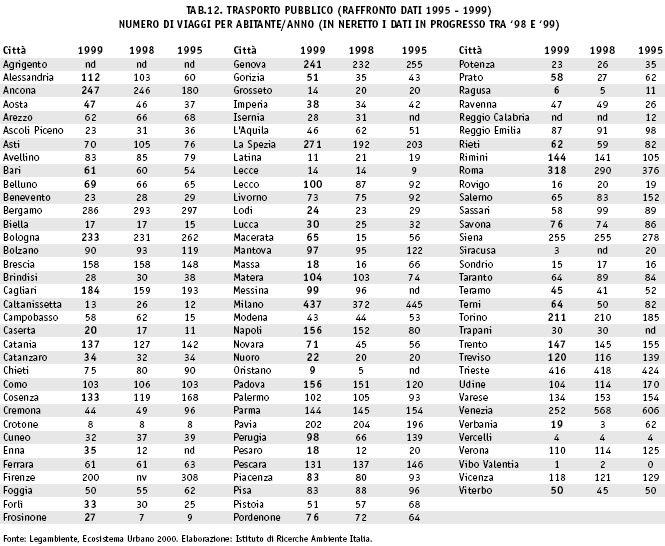
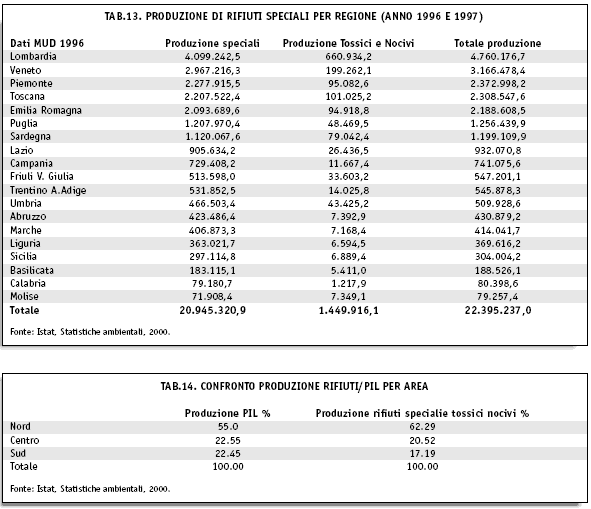
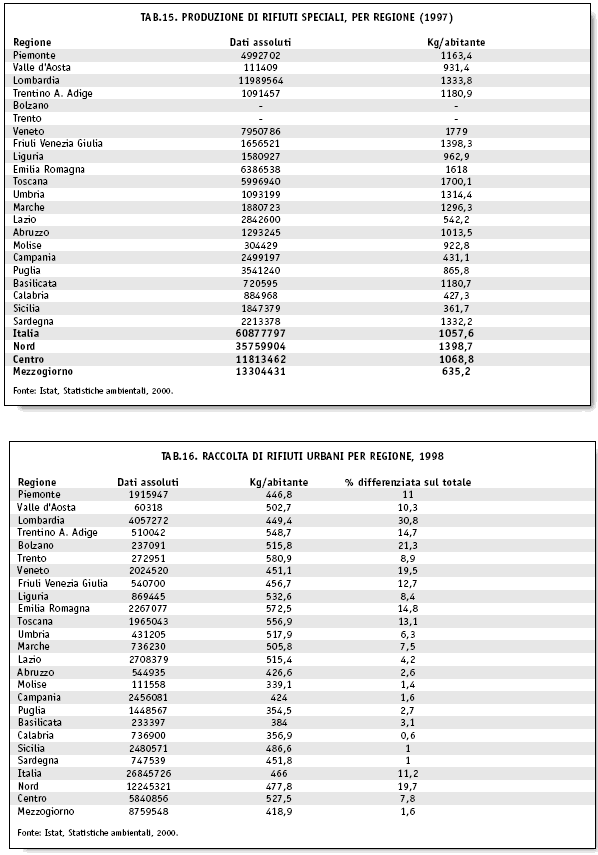
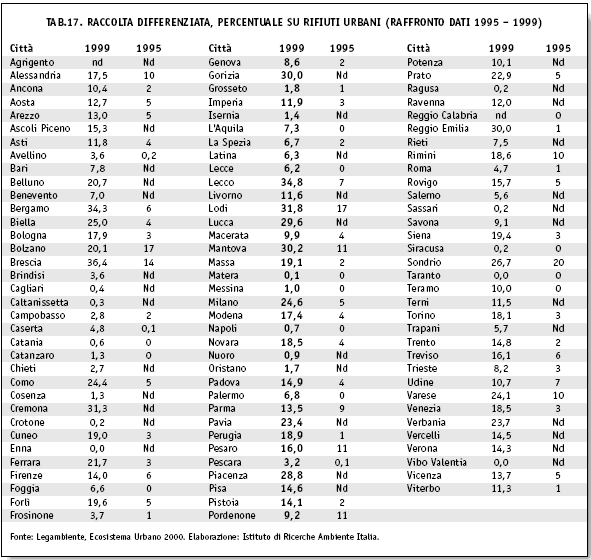
4. Riflessi sul mondo del lavoro
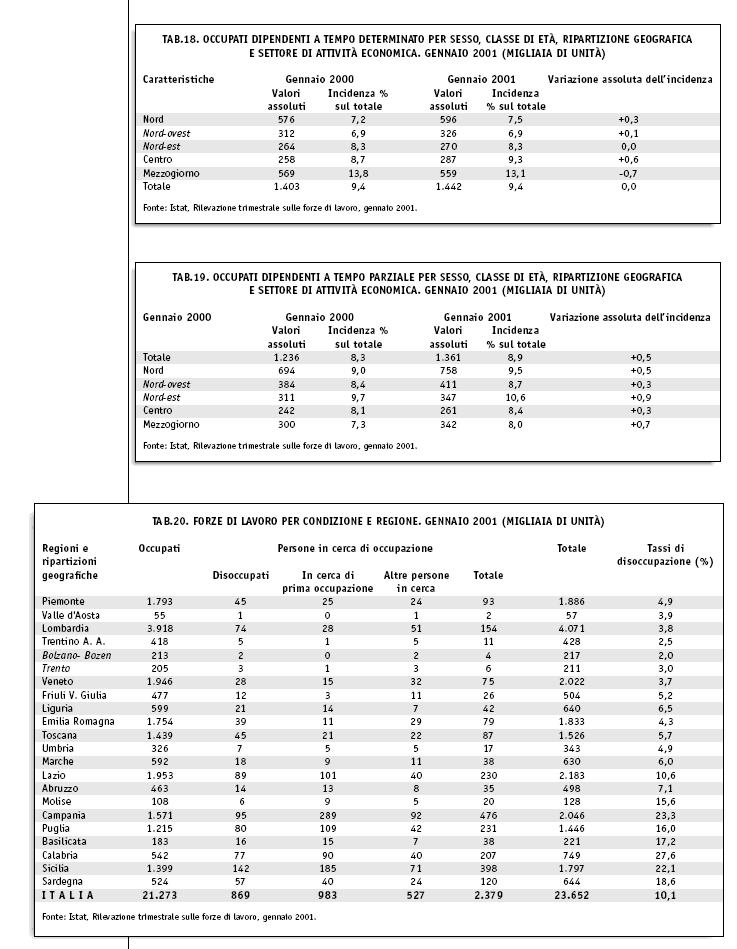
5. Conclusioni
Bibliografia
[1] Giuseppe Alvaro, Contabilità nazionale e statistica economica, Cacucci editore, 1999.
[2] "Privatizzazioni e relazioni industriali", in: http://www.geocities.com/Athens/2753/materiali/privrelind.htm.
Si vedano, anche per il seguito di questo lavoro, vari numeri di PROTEO con gli articoli sulla P.A., privatizzazioni e federalismo, in particolare di R. Martufi, A. Salerni e L. Vasapollo.
[3] Mauro Fotia, “Profit State e crisi delle democrazie contemporanee”, Quaderni Cestes n. 4.
[4] Mauro Fotia, “Profit State e crisi... op. cit.
[5] Franco Bonelli, "La privatizzazione delle imprese pubbliche", Giuffrè editore, 1996.
[6] “Testo unico sugli enti locali”, Decreto legislativo n.267/2000.
[7] Antonio Di Majo (a cura), "Le politiche di privatizzazione in Italia. 3° Rapporto CER/IRS sull’industria e la politica industriale italiana", Il Mulino, 1989.
[8] AREA, "Entrate tariffarie e trasferimenti nel finanziamento dei servizi pubblici in disavanzo", 1986, Firenze, Cispel.
[9] CNEL (IV° Commissione per le politiche dei fattori orizzontali), "Il sistema paese come fattore di competitività: i servizi pubblici, le politiche di coesione, la cittadinanza europea", Roma, 13 aprile 1999.
[10] Appunti sulla liberalizzazione del mercato elettrico, 1999, in: www.rifondazione.it/energia.
[11] Giuseppe Labarile, "Un occhio al mercato e uno alla riforma", Guida agli Enti Locali, n. 44, 2000.
[12] Sergio Ristuccia, La trasformazione dei servizi pubblici locali, in: www.servizilocali.com/it.
[13] Giuseppe Labarile, "Un occhio al mercato e..., op. cit.
[14] Coordinamento sostenitore della proposta di legge di iniziativa popolare "L’asilo nido: un diritto delle bambine e dei bambini", Cercasi nido disperatamente, novembre 2000, in: www.ecn.org/reds/nidibollettino.html.
[15] AA.VV., "Un supporto decisionale per le aziende del trasporto pubblico locale", Quaderni ISRIL, 1/1996.
[16] HyC-HYDROCONTROL (Centro di Ricerca e Formazione per il Controllo dei Sistemi Idrici), "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE, Legge n. 36 del 5 gennaio 1994", Cagliari.
[17] Legambiente/FISE-Assoambiente, "Indagine sulla produzione e lo smaltimento dei rifiuti industriali", marzo 1999, in: www.e-gazette.it.
[18] Antonio Di Majo (a cura), "Le politiche di privatizzazione in Italia. 3° Rapporto CER/IRS sull’industria e la politica industriale italiana", Il Mulino, 1989.
[19] Marco Gelmini, Le trasformazioni nel settore energia, in: www.rifondazione.it/energia.
[20] Ciocca Pierluigi (a cura di), “Disoccupazione di fine secolo. Studi e proposte per l’Europa”, Torino, Bollati Boringhieri, 1997.
[21] Ciocca Pierluigi (a cura di), “Disoccupazione di fine secolo. Studi e proposte per l’Europa”, Torino, Bollati Boringhieri, 1997.
[22] AA.VV., "La riforma della P.A.: un percorso accidentato, ricco di prospettive ma avaro di risultati", Quaderni ISRIL, 2-3/1998.
[23] Luci ed ombre dei contratti temporanei, in http://www.frdg.org.
[24] Istat, “Rapporto sull’Italia. Edizione 2000”, Il Mulino, 2000.
[25] Donati Pierpaolo, Pubblico e privato. Fine di un’alternativa?, Nuova universale Cappelli, 1978.
[26] Huther J., Roberts S., Shah A., Public expenditure reform under adjustement lending. Lessons from World bank experiences, WORLD BANK discussion paper n. 382, 1997.
[27] Stokey Edith, Zeckhauser Richard, Introduzione all’analisi delle decisioni pubbliche, FORMEZ, 1988.
[28] Stokey Edith, Zeckhauser Richard, Introduzione all’analisi delle decisioni pubbliche, FORMEZ, 1988.
[29] Antonio Di Majo (a cura), "Le politiche di privatizzazione in Italia. 3° Rapporto CER/IRS sull’industria e la politica industriale italiana", Il Mulino, 1989.
[30] Agostini Luigi, "Welfare locale - Assessorato sociale - Sindacato", Impresa Sociale, 46/1999.
[31] Giannone Antonino, "La convergenza delle economie delle regioni italiane", Studi e Note di Economia, 2/2000.
[32] Billia Gianni, "Un sistema lento condiziona la competitività", L’Impresa, 4/1998.
[33] Billia Gianni, "Un sistema lento condiziona..., op. cit.
[34] "Concorrenza, sviluppo e sistema bancario", intervento di Antonio Fazio, Bollettino Economico della Banca d’Italia, n. 35, 2000.
[35] Antonio Di Majo (a cura), "Le politiche di privatizzazione in Italia. 3° Rapporto CER/IRS sull’industria e la politica industriale italiana", Il Mulino, 1989.