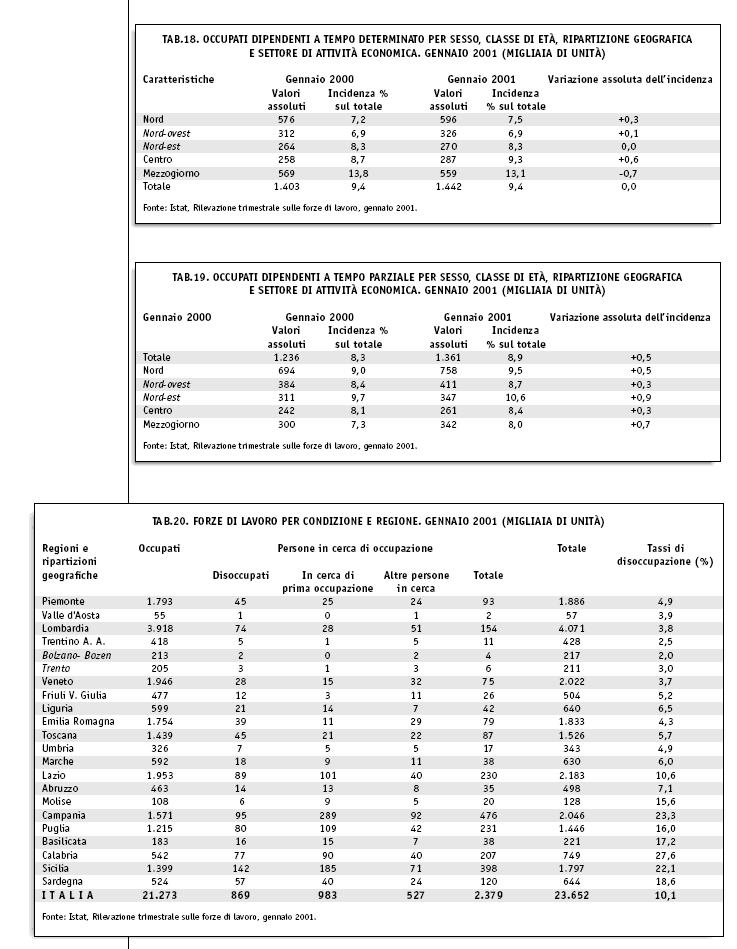![]()
Rubrica
L’analisi-inchiesta
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Maria Rosaria Del Ciello Collaboratrice e ricercatrice rivista “Proteo”
Le privatizzazioni dei servizi nella Pubblica Amministrazione e negli enti locali
Tutti gli articoli della rubrica: analisi-inchiesta(in tutti i numeri di Proteo)
|
Spesso si attribuisce alla non-flessibilità la colpa di una disoccupazione, proponendo come facili risoluzioni risposte quali la flessibilità, e di conseguenza la privatizzazione e la liberalizzazione dei rapporti di lavoro, o il riferimento ad assetti del mercato del lavoro (americano o inglese) considerati ideali, da esportare innestandoli in ambienti economici, giuridici, culturali, profondamente diversi senza pensare che le particolarità dei mercati del lavoro andrebbero considerate come aspetti fondamentali di realtà economiche e sociali ben specifiche. La privatizzazione dei servizi pubblici locali discende poi da quel principio di federalismo e decentralismo che ha riflessi enormi anche sulle relazioni industriali. Ed infatti l’affidamento alle Regioni della materia di tutela e sicurezza del lavoro può aprire la strada anche ad un federalismo contrattuale secondo cui ogni Regione potrebbe creare un proprio statuto dei lavoratori. La contrattazione nazionale perderebbe così significato e forza a tutto vantaggio di una contrattazione territoriale che potrebbe sfociare, con il passare del tempo, in una contrattazione ad personam con la perdita totale di qualsiasi tipo di garanzia per i lavoratori, soprattutto i più deboli: donne, giovani, persone in cerca di prima occupazione. Per questo Anci e Cispel hanno richiesto che nei processi di privatizzazione vengano previste opportune garanzie per il personale dipendente delle aziende che dovranno lasciare gli affidamenti: la proposta è quella dell’applicazione del disposto dell’articolo 2112 del Codice Civile il quale prevede la salvaguardia del rapporto di lavoro in caso di trasferimento di azienda. Tra i diversi aspetti del processo di privatizzazione due sembrano particolarmente importanti: 1) l’estensione al sistema pubblico dell’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 che ha posto il vincolo della moderazione salariale ancorando gli incrementi retributivi nel corso dei rinnovi contrattuali al tetto di inflazione programmata. La necessità del contenimento della spesa è stata la causa principale delle critiche rivolte al decreto legislativo 29/1993 e di riflesso ai CCNL circa la rigidità nell’utilizzo delle risorse anche nella sede decentrata; 2) il tentativo di armonizzare le regole che disciplinano il rapporto di lavoro pubblico a quelle del settore privato [1]. L’adattamento delle nostre economie alle continue evoluzioni del mercato spinge sempre più verso forme più o meno estese di privatizzazione che a loro volta danno impulso a nuove forme contrattuali: tra queste vanno sottolineate le forme di contratti temporanei, uno degli aspetti senz’altro più evidenti nel mercato del lavoro europeo degli anni novanta. Da più parti viene esaltato il contributo dei contratti temporanei alla crescita dell’occupazione: in realtà per analizzare in maniera esauriente tale contributo “occorre capire in che misura la performance insoddisfacente della crescita dei posti di lavoro coperti da contratti permanenti sia una conseguenza indiretta della crescita dei contratti temporanei. In effetti, sembra che in alcuni paesi, tra cui Germania, Francia e Italia, i contratti temporanei abbiano sostituito posti di lavoro coperti da contratti permanenti. Sebbene questa sostituzione rappresenti un modo per rendere il mercato del lavoro più flessibile, gli effetti di lungo periodo di questo fenomeno possono essere molto negativi. Con il passare del tempo infatti, un’eccessiva quota di posti di lavoro coperti da contratti temporanei (soprattutto tra i giovani) riduce gli incentivi dei lavoratori ad apprendere professionalità specifiche del posto di lavoro” [2]. I dati dell’Istat suggeriscono che l’occupazione temporanea è un fenomeno molto più radicato al Sud dove rappresenta il 14% dell’occupazione dipendente, rispetto al Nord e Centro, dove non supera il 9%. Sempre dai dati dell’Istat risulta che nel 2000 oltre il 60% dei nuovi posti di lavoro creati in Italia sono posti di lavoro a tempo determinato: ma quanti di questi contratti a termine si trasformano successivamente in rapporti di lavoro stabili? Nel Mezzogiorno per le persone il cui primo impiego è stato a tempo determinato dopo 3 anni appena il 5% gode di un’occupazione permanente, contro il 22% nel Centro e il 30% nel Nord. Gli esiti occupazionali a 5 anni di distanza dall’ingresso sono ancora più differenziati: l’entrata nel mercato stabile coinvolge quasi il 50% dei giovani occupati al Nord, il 37% al Centro e solo il 15% al Sud. La progressiva diffusione di queste forme lavorative (contratti a tempo parziale e svariate tipologie contrattuali a tempo determinato) è avvenuta ai danni dell’occupazione standard. Il “nuovo mercato del lavoro” si presenta molto articolato, con forti processi di segmentazione e stratificazione sociale. Alla tradizionale contrapposizione tra chi ha un lavoro e chi non ce l’ha si sommano quelle tra chi ha un lavoro continuativo e chi no, tra chi ha un lavoro tutelato e chi no [3].
[1] AA.VV., "La riforma della P.A.: un percorso accidentato, ricco di prospettive ma avaro di risultati", Quaderni ISRIL, 2-3/1998. [2] Luci ed ombre dei contratti temporanei, in http://www.frdg.org. [3] Istat, “Rapporto sull’Italia. Edizione 2000”, Il Mulino, 2000.
|