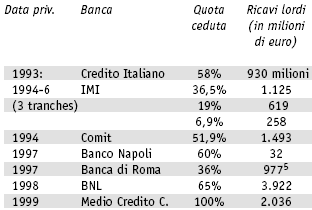![]()
Rubrica
L’analisi-inchiesta
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Leonardo Valle Ricercatore Socio-Economico indipendente
Legge finanziaria e privatizzazione dei servizi pubblici locali Club privé. A cosa sono servite le privatizzazioni delle banche italiane Sulla questione sociale delle privatizzazioni La privatizzazione finanziaria Il privato... è politico! Le privatizzazioni contro il movimento dei lavoratori
Tutti gli articoli della rubrica: analisi-inchiesta(in tutti i numeri di Proteo)
|
In Italia, provare a tracciare un bilancio critico delle privatizzazioni è un po’ come provare a mettere in dubbio l’autenticità della Sacra Sindone. In effetti, se ci volgiamo indietro a guardare i magici anni Novanta, possiamo osservare che su pochi temi si è registrato un consenso più totale che sulla necessità economica, politica e financo morale delle privatizzazioni. Nella Trinità della religione liberistica il feticcio delle “Privatizzazioni” occupa senz’altro un ruolo più importante delle “Liberalizzazioni”, un ruolo comparabile soltanto a quello della “Flessibilità”. Criticarlo è tabù. Ma i tabù, come è noto, nascondono sempre qualcosa di poco chiaro...
1. Il “che cosa” e il “chi” delle privatizzazioni
Cosa è stato privatizzato. Cominciamo con qualche dato. L’inizio vero e proprio delle privatizzazioni italiane si può fare risalire al 1992. Da allora, in circa 10 anni, sono state privatizzate aziende statali per un valore di oltre 220.000 miliardi di lire. Di fatto, è stato liquidato l’IRI, e sono state vendute grandi società pubbliche quali Telecom, ENEL, ENI (quest’ultime 2 solo in parte), e praticamente tutte le banche precedentemente controllate dallo Stato. Su queste ultime concentreremo la nostra analisi. Per avere un’idea della dimensione del fenomeno basterà dire che, se nel 1991, le banche pubbliche rappresentavano il 73% del totale delle banche italiane, oggi allo Stato restano soltanto piccole quote di minoranza in banche di importanza marginale. Chi ha privatizzato. Qui cominciano le prime sorprese. In effetti, sappiamo che in Italia (come del resto in altri Paesi europei, a cominciare dalla Francia) il consenso parlamentare alle privatizzazioni è stato schiacciante: con la sola eccezione, peraltro neppure troppo convinta e lineare, di PRC e PdCI; per il resto le privatizzazioni - e l’ortodossia liberalistica sottostante - hanno raccolto il consenso entusiastico di tutti i gruppi parlamentari. Questo però non significa che le privatizzazioni le abbia fatte il Parlamento. E qui qualcuno potrebbe pensare che la materia sia stata espropriata al Parlamento, magari a suon di decreti legge, dal Governo. Ma non è vero nemmeno questo: le privatizzazioni non le hanno fatte neppure i governi che si sono succeduti dall’inizio degli anni Novanta in poi. O meglio: Governo e Parlamento hanno deciso di privatizzare, ma il come e il quando lo ha deciso qualcun altro. Chi? Il Ministro del Tesoro? Neppure lui. Tutto questo è stato deciso da un “tecnico”: il Direttore Generale del Tesoro, il prof. Mario Draghi. È stata la struttura da lui diretta in prima persona a pilotare la maggior parte delle privatizzazioni italiane, lasciando ai ministri il meno oneroso compito di apporre la loro firma sui singoli decreti di privatizzazione. In anni ormai lontani si straparlava, a sinistra, di “autonomia del politico”. Si può tranquillamente affermare che la Direzione Generale del Tesoro diretta da Draghi (“sotto” non meno di 6 diversi ministri) sia stata un caso emblematico di “autonomia dal politico”. Tale struttura “tecnica” ha in realtà costituito, per tutti gli anni Novanta, uno dei pochi veri poteri forti di questo Paese. Un potere di fatto privo di ogni legittimazione democratica e di un vero controllo sul merito e sul metodo delle scelte assunte. E per giunta arrogante. Basti pensare alla risposta data da Draghi a chi, durante un convegno, gli chiedeva timidamente se non sarebbe stato il caso, prima di privatizzare, di aspettare un quadro legislativo che consentisse le liberalizzazioni (magari per evitare di avere monopoli privati e non più pubblici, come poi è di fatto accaduto...): “qual era la capacità di produrre leggi che aveva quello Stato, nel ’92-’93? Avremmo aspettato all’infinito! [1]”.
2. “Saldi di fine stagione” per comprare il biglietto per l’Europa (e non solo)E veniamo ai motivi delle privatizzazioni. Il primo motivo, com’è noto, era rappresentato dalla necessità per lo Stato di “fare cassa”, per poter abbattere il debito pubblico ed entrare nel club della moneta unica europea. Si tratta di un motivo oggettivo e reale - beninteso, una volta accettate le premesse, ossia che si dovesse partecipare alla moneta unica e che i parametri dovessere essere quelli fissati a Maastricht [2]. Va però sottolineato come tale motivo sia stato in realtà utilizzato, strumentalmente, come una leva per ridimensionare drasticamente il ruolo dello Stato nell’economia. In un recente articolo sulle privatizzazioni, scritto da uno dei componenti della tecnostruttura di Draghi, la cosa è ammessa con estrema franchezza: “Si è sfruttata l’occasione offerta dalla necessità ed urgenza di rispettare gli stringenti vincoli esterni, imposti dalla partecipazione all’Unione Monetaria Europea, per avviare iniziative volte alla ridefinizione del ruolo dello Stato ed alla riforma, in senso maggiormente concorrenziale, dei mercati [3]. Cosa sarebbe successo senza la pressione di questi vincoli comunitari è difficile a dirsi. Si può, tuttavia, affermare che sarebbe venuto meno uno degli stimoli più incisivi a procedere con decisione nel processo di risanamento della finanza pubblica e di riqualificazione del rapporto tra Stato e mercato” [4]. E veniamo alle cifre incassate. Ad oggi, il Tesoro ha effettuato direttamente operazioni di privatizzazione per un controvalore di circa 66,6 miliardi di euro. A questa cifra vanno però aggiunte le privatizzazioni gestite dall’IRI (sempre sotto il coordinamento del Tesoro), per un controvalore di circa 56,4 miliardi di euro, le dismissioni realizzate dall’ENI (5,4 miliardi di euro) e la liquidazione dell’EFIM (440 milioni di euro). Si tratta di cifre molto consistenti, da cui è facile intuire il valore e l’importanza degli assets venduti. Sono anche cifre adeguate? In altri termini, il Tesoro ha venduto le società pubbliche al loro giusto prezzo oppure no? Per quanto strano possa sembrare, questo tema non è stato praticamente mai affrontato seriamente. Eppure il metodo ci sarebbe: basterebbe prendere il prezzo di vendita delle società e confrontarlo con le attuali quotazioni di borsa delle stesse società. La cosa è complicata dal fatto che pressoché tutte le banche sono state coinvolte da processi di concentrazione e fusione con altre banche dopo la privatizzazione, ma si può comunque arrivare a valutazioni attendibili. Vediamo quindi, innanzitutto, i valori incassati all’atto della privatizzazione.
E ora qualche cenno ai valori di borsa attuali. Oggi Unicredito Italiano capitalizza 26.593 milioni di euro, IMI-Sampaolo 16.941 milioni, Intesa-BCI (che comprende Comit) 20.760 milioni, Banca di Roma 4.087 milioni, BNL 4. 922 milioni [5]. Un caso a parte, che ha dell’incredibile, è poi rappresentato dal Banco Napoli: quel 60% che lo Stato vendette alla BNL per 32 milioni di euro (dopo ripulito il Banconapoli delle perdite e dei crediti inesigibili con 6.200 milioni di euro di danaro pubblico), è stato rivenduto dalla BNL, a distanza di pochi anni, per 1.000 milioni di euro. Alla luce di queste cifre appaiono decisamente curiose le dichiarazioni dell’allora Ministro del Tesoro Ciampi: “il Tesoro vuole valorizzare prima di vendere: è un suo dovere nei confronti del cittadino che, dopo le risorse profuse per finanziare le perdite delle imprese pubbliche negli anni passati non tollererebbe ‘regali’ al momento della loro vendita” [6]. Ma non è tutto: va infatti considerato che le cifre riportate nella tabella con i prezzi di vendita sono lorde. Da esse vanno infatti sottratti i costi delle operazioni di privatizzazione, che includono: le commissioni per i collocatori in borsa (banche che compongono il sindacato di collocamento e altri consulenti), così come le spese di registration e listing sui mercati azionari (spese per adempimenti CONSOB, SEC e altri adempimenti normativi). Questi costi sono andati scendendo nel corso degli anni, ma si collocano comunque tra il 2% e il 3% sull’ammontare totale del ricavato [i]. Una fetta consistente di questo denaro (circa l’1% sull’ammontare totale) è andato alle maggiori investment banks anglosassoni (JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse First Boston, Merrill Lynch, ecc.), per la loro attività di consulenza. Il tutto senza ovviamente rischiare in proprio neanche un dollaro. E, meno ovviamente, senza dover neppure sostenere una gara pubblica per l’affidamento dell’incarico. Ci sembra che guadagnare 2.200 miliardi di lire a queste condizioni sia una cosa decisamente simpatica. Come stupirsi, quindi, del fatto che il prof. Mario Draghi, lasciato l’incarico di Direttore Generale del Tesoro, abbia trovato rapidamente collocazione come direttore generale e vice presidente di Goldman Sachs International? E che il “vicedirettore generale del Tesoro con delega alle privatizzazioni”, il professor Vittorio Grilli, sia stato ancor più rapidamente assunto dal Credit Suisse? Al di là di questi aspetti - diciamo così - di dettaglio, ci sembra che i dati di confronto tra i valori di vendita e gli attuali valori borsistici delle società vendute lascino poco spazio ad interpretazioni: le privatizzazioni italiane nel loro complesso (non soltanto quelle bancarie) sono state dei veri e propri “saldi di fine stagione”. La “stagione” che finiva era quella della cosiddetta “economia mista”, dell’intervento dello Stato nell’economia. Quella che iniziava, almeno stando ai suoi apologeti, quella del moderno “capitalismo dei mercati finanziari”, e - cosa ancora più allettante - della “democrazia economica dei piccoli investitori”. Vediamo di cosa si tratta. [1] Qui “Stato” sta, ovviamente, per “Parlamento” (che è detto “potere legislativo” appunto perché fa le leggi, anche se il prof. Draghi non lo sa). Questo simpatico esempio di disprezzo dell’istituzione parlamentare è stato pubblicato, senza mai ricevere una smentita, dal Corriere della Sera il 30 marzo 2001. [2] Come è noto, sull’opportunità di alcuni dei parametri, ad es. la soglia di inflazione al 3%, sussistono fondati dubbi. In ogni caso, in linea generale, va sottolineato il carattere di scelta politica dell’assunzione di questi parametri e non di altri. È importante insistere su questo perché di fatto tali criteri sono generalmente considerati, dalla pubblicistica corrente, come le “tavole della legge” di Mosè o addirittura come “leggi naturali”. Non è così: non esiste una politica monetaria oggettivamente necessaria, così come non esiste una politica monetaria neutrale rispetto alle classi. [3] Come si vedrà più avanti, è assai dubbio che questo secondo obiettivo sia stato conseguito. Del resto, anche in questa sede è citato come riempitivo d’obbligo: infatti nella frase successiva questo obiettivo sparisce e rimane quello, prioritario, di ridimensionare il ruolo dello Stato. [4] D. Scannapieco, “Le privatizzazioni in Italia: una riflessione a dieci anni dal rapporto presentato al Ministro del Tesoro Guido Carli”, in Guido Carli e le privatizzazioni dieci anni dopo, a cura di F. A. Grassini, Roma, Luiss Edizioni, 2001, p. 156, corsivi miei. [5] Nota: la quota ceduta dal Tesoro è pari al 3% del capitale ord, per 286 mld. Il valore finale si riferisce alla somma derivante da vendita diretta di azioni e dalla successiva conversione di obbligazioni emesse dall’IRI; includendo solo il ricavo della vendita diretta di azioni tale valore scenderebbe a poco meno di 670 mld. Fonte: Banche e Assicurazioni, Convegno nazionale FISAC CGIL, aprile 2001. [6] Il calcolo è fatto sul totale di gruppi bancari, nei quali comunque la ex-banca privatizzata di norma è la componente più di peso. La sproporzione tra le cifre di partenza e quelle di arrivo è comunque clamorosa, ad eccezione dei casi di Banca di Roma e BNL (per Medio Credito il confronto non è possibile perché non è una società quotata). [i] Il Sole 24 Ore, 7 agosto 1998.
|