In Italia, provare a tracciare un bilancio critico delle privatizzazioni è un po’ come provare a mettere in dubbio l’autenticità della Sacra Sindone. In effetti, se ci volgiamo indietro a guardare i magici anni Novanta, possiamo osservare che su pochi temi si è registrato un consenso più totale che sulla necessità economica, politica e financo morale delle privatizzazioni. Nella Trinità della religione liberistica il feticcio delle “Privatizzazioni” occupa senz’altro un ruolo più importante delle “Liberalizzazioni”, un ruolo comparabile soltanto a quello della “Flessibilità”. Criticarlo è tabù. Ma i tabù, come è noto, nascondono sempre qualcosa di poco chiaro...
1. Il “che cosa” e il “chi” delle privatizzazioni
Cosa è stato privatizzato. Cominciamo con qualche dato. L’inizio vero e proprio delle privatizzazioni italiane si può fare risalire al 1992. Da allora, in circa 10 anni, sono state privatizzate aziende statali per un valore di oltre 220.000 miliardi di lire. Di fatto, è stato liquidato l’IRI, e sono state vendute grandi società pubbliche quali Telecom, ENEL, ENI (quest’ultime 2 solo in parte), e praticamente tutte le banche precedentemente controllate dallo Stato. Su queste ultime concentreremo la nostra analisi. Per avere un’idea della dimensione del fenomeno basterà dire che, se nel 1991, le banche pubbliche rappresentavano il 73% del totale delle banche italiane, oggi allo Stato restano soltanto piccole quote di minoranza in banche di importanza marginale.
Chi ha privatizzato. Qui cominciano le prime sorprese. In effetti, sappiamo che in Italia (come del resto in altri Paesi europei, a cominciare dalla Francia) il consenso parlamentare alle privatizzazioni è stato schiacciante: con la sola eccezione, peraltro neppure troppo convinta e lineare, di PRC e PdCI; per il resto le privatizzazioni - e l’ortodossia liberalistica sottostante - hanno raccolto il consenso entusiastico di tutti i gruppi parlamentari. Questo però non significa che le privatizzazioni le abbia fatte il Parlamento. E qui qualcuno potrebbe pensare che la materia sia stata espropriata al Parlamento, magari a suon di decreti legge, dal Governo. Ma non è vero nemmeno questo: le privatizzazioni non le hanno fatte neppure i governi che si sono succeduti dall’inizio degli anni Novanta in poi.
O meglio: Governo e Parlamento hanno deciso di privatizzare, ma il come e il quando lo ha deciso qualcun altro. Chi? Il Ministro del Tesoro? Neppure lui. Tutto questo è stato deciso da un “tecnico”: il Direttore Generale del Tesoro, il prof. Mario Draghi. È stata la struttura da lui diretta in prima persona a pilotare la maggior parte delle privatizzazioni italiane, lasciando ai ministri il meno oneroso compito di apporre la loro firma sui singoli decreti di privatizzazione. In anni ormai lontani si straparlava, a sinistra, di “autonomia del politico”. Si può tranquillamente affermare che la Direzione Generale del Tesoro diretta da Draghi (“sotto” non meno di 6 diversi ministri) sia stata un caso emblematico di “autonomia dal politico”. Tale struttura “tecnica” ha in realtà costituito, per tutti gli anni Novanta, uno dei pochi veri poteri forti di questo Paese. Un potere di fatto privo di ogni legittimazione democratica e di un vero controllo sul merito e sul metodo delle scelte assunte. E per giunta arrogante. Basti pensare alla risposta data da Draghi a chi, durante un convegno, gli chiedeva timidamente se non sarebbe stato il caso, prima di privatizzare, di aspettare un quadro legislativo che consentisse le liberalizzazioni (magari per evitare di avere monopoli privati e non più pubblici, come poi è di fatto accaduto...): “qual era la capacità di produrre leggi che aveva quello Stato, nel ’92-’93? Avremmo aspettato all’infinito! [1]”.
2. “Saldi di fine stagione” per comprare il biglietto per l’Europa (e non solo)
E veniamo ai motivi delle privatizzazioni. Il primo motivo, com’è noto, era rappresentato dalla necessità per lo Stato di “fare cassa”, per poter abbattere il debito pubblico ed entrare nel club della moneta unica europea. Si tratta di un motivo oggettivo e reale - beninteso, una volta accettate le premesse, ossia che si dovesse partecipare alla moneta unica e che i parametri dovessere essere quelli fissati a Maastricht [2]. Va però sottolineato come tale motivo sia stato in realtà utilizzato, strumentalmente, come una leva per ridimensionare drasticamente il ruolo dello Stato nell’economia. In un recente articolo sulle privatizzazioni, scritto da uno dei componenti della tecnostruttura di Draghi, la cosa è ammessa con estrema franchezza: “Si è sfruttata l’occasione offerta dalla necessità ed urgenza di rispettare gli stringenti vincoli esterni, imposti dalla partecipazione all’Unione Monetaria Europea, per avviare iniziative volte alla ridefinizione del ruolo dello Stato ed alla riforma, in senso maggiormente concorrenziale, dei mercati [3]. Cosa sarebbe successo senza la pressione di questi vincoli comunitari è difficile a dirsi. Si può, tuttavia, affermare che sarebbe venuto meno uno degli stimoli più incisivi a procedere con decisione nel processo di risanamento della finanza pubblica e di riqualificazione del rapporto tra Stato e mercato” [4].
E veniamo alle cifre incassate. Ad oggi, il Tesoro ha effettuato direttamente operazioni di privatizzazione per un controvalore di circa 66,6 miliardi di euro. A questa cifra vanno però aggiunte le privatizzazioni gestite dall’IRI (sempre sotto il coordinamento del Tesoro), per un controvalore di circa 56,4 miliardi di euro, le dismissioni realizzate dall’ENI (5,4 miliardi di euro) e la liquidazione dell’EFIM (440 milioni di euro). Si tratta di cifre molto consistenti, da cui è facile intuire il valore e l’importanza degli assets venduti. Sono anche cifre adeguate? In altri termini, il Tesoro ha venduto le società pubbliche al loro giusto prezzo oppure no? Per quanto strano possa sembrare, questo tema non è stato praticamente mai affrontato seriamente. Eppure il metodo ci sarebbe: basterebbe prendere il prezzo di vendita delle società e confrontarlo con le attuali quotazioni di borsa delle stesse società. La cosa è complicata dal fatto che pressoché tutte le banche sono state coinvolte da processi di concentrazione e fusione con altre banche dopo la privatizzazione, ma si può comunque arrivare a valutazioni attendibili. Vediamo quindi, innanzitutto, i valori incassati all’atto della privatizzazione.
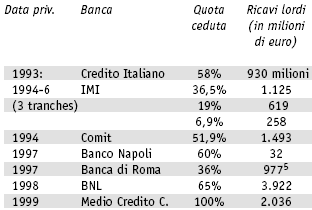
E ora qualche cenno ai valori di borsa attuali. Oggi Unicredito Italiano capitalizza 26.593 milioni di euro, IMI-Sampaolo 16.941 milioni, Intesa-BCI (che comprende Comit) 20.760 milioni, Banca di Roma 4.087 milioni, BNL 4. 922 milioni [5]. Un caso a parte, che ha dell’incredibile, è poi rappresentato dal Banco Napoli: quel 60% che lo Stato vendette alla BNL per 32 milioni di euro (dopo ripulito il Banconapoli delle perdite e dei crediti inesigibili con 6.200 milioni di euro di danaro pubblico), è stato rivenduto dalla BNL, a distanza di pochi anni, per 1.000 milioni di euro. Alla luce di queste cifre appaiono decisamente curiose le dichiarazioni dell’allora Ministro del Tesoro Ciampi: “il Tesoro vuole valorizzare prima di vendere: è un suo dovere nei confronti del cittadino che, dopo le risorse profuse per finanziare le perdite delle imprese pubbliche negli anni passati non tollererebbe ‘regali’ al momento della loro vendita” [6].
Ma non è tutto: va infatti considerato che le cifre riportate nella tabella con i prezzi di vendita sono lorde. Da esse vanno infatti sottratti i costi delle operazioni di privatizzazione, che includono: le commissioni per i collocatori in borsa (banche che compongono il sindacato di collocamento e altri consulenti), così come le spese di registration e listing sui mercati azionari (spese per adempimenti CONSOB, SEC e altri adempimenti normativi). Questi costi sono andati scendendo nel corso degli anni, ma si collocano comunque tra il 2% e il 3% sull’ammontare totale del ricavato [i].
Una fetta consistente di questo denaro (circa l’1% sull’ammontare totale) è andato alle maggiori investment banks anglosassoni (JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse First Boston, Merrill Lynch, ecc.), per la loro attività di consulenza. Il tutto senza ovviamente rischiare in proprio neanche un dollaro. E, meno ovviamente, senza dover neppure sostenere una gara pubblica per l’affidamento dell’incarico. Ci sembra che guadagnare 2.200 miliardi di lire a queste condizioni sia una cosa decisamente simpatica. Come stupirsi, quindi, del fatto che il prof. Mario Draghi, lasciato l’incarico di Direttore Generale del Tesoro, abbia trovato rapidamente collocazione come direttore generale e vice presidente di Goldman Sachs International? E che il “vicedirettore generale del Tesoro con delega alle privatizzazioni”, il professor Vittorio Grilli, sia stato ancor più rapidamente assunto dal Credit Suisse?
Al di là di questi aspetti - diciamo così - di dettaglio, ci sembra che i dati di confronto tra i valori di vendita e gli attuali valori borsistici delle società vendute lascino poco spazio ad interpretazioni: le privatizzazioni italiane nel loro complesso (non soltanto quelle bancarie) sono state dei veri e propri “saldi di fine stagione”. La “stagione” che finiva era quella della cosiddetta “economia mista”, dell’intervento dello Stato nell’economia. Quella che iniziava, almeno stando ai suoi apologeti, quella del moderno “capitalismo dei mercati finanziari”, e - cosa ancora più allettante - della “democrazia economica dei piccoli investitori”. Vediamo di cosa si tratta.
-----
3. Una nuova “democrazia economica”?
Tra i luoghi comuni che in questi anni ci sono stati più ossessivamente ripetuti vi è in effetti quello secondo cui il diffondersi dell’investimento azionario a livello di massa - ottenuto per l’appunto grazie alle privatizzazioni - avrebbe consentito una migliore affermazione anche in Italia delle public companies (imprese ad azionariato molto frammentato, rette da managers attenti solo alla valorizzazione delle società). Questo processo avrebbe condotto (addirittura) ad una nuova e moderna forma di “democrazia economica”: la democrazia dei piccoli investitori.
In una delle sue formulazioni più suggestive, questa favoletta recita pressapoco così: oggi siamo di fronte ad un vero e proprio passaggio di fase del capitalismo. Dal capitalismo delle partecipazioni incrociate, tipico di Francia, Germania e Italia, in cui molte imprese sono controllate da pochi potenti gruppi di controllo tra loro interconnessi (che possiedono le imprese con forti pacchetti azionari: il modello Mediobanca, per capirsi), stiamo passando al capitalismo delle public companies e degli investitori istituzionali, caratterizzato dalla dispersione della proprietà e dall’azionariato diffuso.
Come in tutte le favole, anche in questa c’è del vero: è vero, ad esempio, che i tradizionali gruppi di controllo hanno fatto il loro tempo; ed è vero, a tanto maggior ragione, che il capitalismo familiare (anche laddove la famiglia si chiami “Agnelli”, come ormai dovrebbe essere chiaro...) ha fatto il suo tempo. Purtroppo, però, la parte della favola che non regge è proprio il “lieto fine”. Infatti:
a) Non è vero che nel modello della public company la proprietà sia meno concentrata.
Il fatto che la proprietà sia sempre meno identificabile con una specifica persona fisica (il grande capitalista monetario alla Rothschild o alla Morgan, il grande capitalista industriale alla Ford, ecc.) non significa affatto che i titoli capitalistici di proprietà non esistano più, e non significa neppure che essi non siano saldamente concentrati. Al contrario: la tendenza alla concentrazione del controllo è forse ancora più forte nel cosiddetto “modello anglosassone della public company” di quanto avvenga nel cosiddetto “modello continentale”. Prendiamo la Gran Bretagna, dove il sistema della public company prevale: è stato rilevato che nel mercato azionario inglese “la proprietà è solo apparentemente diffusa”, e che “in realtà pochi grandi conglomerati finanziari e assicurativi, raccogliendo le attività (e quindi i voti) dell’80% dei fondi pensione e di gran parte dei fondi minori e dei fondi esteri, di fatto hanno la possibilità di esprimere, attraverso veri e propri ‘oligopoli del controllo’, una ‘voce’ influente sull’intero sistema delle compagnie quotate inglesi”.
In definitiva, “anche nella patria del capitalismo popolare un gruppo ristretto di grandi istituzioni finanziarie controlla, con un impegno finanziario relativamente modesto [a causa del frazionamento dell’azionariato, che consente di controllare una società anche con pacchetti azionari relativamente piccoli, NdR], una larga parte del sistema della proprietà delle imprese quotate”. In base a questo, non può stupire che i primi 50 manager dei fondi di investimento (soprattutto le società di assicurazione) controllino di fatto - direttamente o attraverso le deleghe di voto - oltre l’85% del mercato azionario inglese [7]. Non solo: il sistema delle partecipazioni incrociate tra questi grandi investitori è tale da fare impallidire le più spericolate ingegnerie azionarie messe in piedi dalla buonanima di Cuccia. Conclusione: gli assetti proprietari non sono meno, ma più concentrati che in passato. Sono però, sicuramente, molto meno “trasparenti” e “identificabili” [8]. I centri decisionali “si allontanano e si disperdono”, sono sempre meno immediatamente individuabili, ma esistono eccome. Questo è quello che succede dove è diffuso il modello della public company. E in Italia?
b) In Italia negli ultimi anni è cresciuta la concentrazione attraverso le “scatole cinesi”.
Ecco cosa ha detto in proposito, nel recente Incontro annuale con il mercato finanziario (8 aprile 2002), nientemeno che Luigi Spaventa, il Presidente della CONSOB (l’organo di vigilanza delle società quotate in borsa). In Italia la proprietà è già di per sé molto concentrata: “nel 60 per cento delle società quotate in borsa un socio ha la maggioranza assoluta; nella media ponderata, la quota del primo azionista è risalita oltre il 42 per cento; il flottante [ossia la quantità di titoli di una società che sono effettivamente scambiati in borsa e non stabilmente posseduti da un socio] è diminuito” [9].
Ma l’aspetto più degno di nota è un altro: spesso si ha la concentrazione del controllo senza che ci sia la concentrazione della proprietà. In altre parole: ci sono gruppi (industriali o, più spesso, finanziari) che controllano le società quotate pur senza possederne neppure lontanamente la maggioranza delle azioni. Ascoltiamo ancora Spaventa: “il rapporto fra diritti di controllo e diritti ai dividendi [10], dopo essersi ridotto nel passato decennio, è tornato ad aumentare: nella media dei primi dieci gruppi quotati il capitale controllato è pari a quasi due volte e mezza il capitale posseduto”. Come è possibile questo miracolo? Con un trucchetto che lo stesso Spaventa ci spiega: “l’esercizio del controllo con un impegno più modesto nella proprietà viene sovente ottenuto ricorrendo a lunghe e complicate strutture piramidali” [11]. È il sistema che viene anche detto “delle scatole cinesi”: la mia holding possiede il 51% di una società, che a sua volta possiede il 51% di un’altra società, che possiede il 40% di un’altra ancora, che possiede il 30% di un’ultima società (quella che realmente mi interessa). In questo modo, con un impegno finanziario relativamente modesto, posso possedere società di grandi proporzioni. Non è fantascienza: è in questo modo, ad esempio, che Tronchetti Provera ha ottenuto il controllo di Olivetti (e quindi di Telecom e TIM), pur avendo comprato, attraverso una controllata di una controllata ecc., soltanto il 29% delle azioni della società.
In questo contesto, quale ruolo giocano i risparmiatori, i piccoli investitori che dovrebbero costituire il pilastro vitale della nuova democrazia economica? Il ruolo di mettere i soldi nella società e di rendere possibile agli azionisti maggiori di controllarla senza doverla possedere. Ancora Spaventa: “nel caso di azionariato frazionato il modestissimo tasso di partecipazione [alle assemblee] delle minoranze consente al primo azionista l’esercizio del controllo anche con una quota di capitale lontana dalla maggioranza assoluta” [12]. Ecco fatto.
Quanto sopra è perfettamente applicabile proprio alle privatizzazioni bancarie ed ai loro risultati. Non lo diciamo noi, lo ha detto un altro esponente della CONSOB in un saggio dedicato alle privatizzazioni bancarie: “all’indomani della privatizzazione, nonostante [?] le intenzioni del Governo, si sono create situazioni di controllo di fatto esercitato da gruppi ristretti di azionisti, legati da accordi impliciti e non formalizzati o esplicitati in patti di sindacato”. In particolare, per quanto riguarda la Comit e il Credito Italiano, “nel corso delle assemblee delle due banche tenutesi subito la privatizzazione sono stati nominati, su proposta del management uscente, Consigli d’Amministrazione composti da rappresentanti dei principali azionisti, escludendo i rappresentanti degli azionisti di minoranza” [13].
c) E la public company che fine ha fatto?
In Italia, semplicemente, le public companies non ci sono. E del resto, a dire la verità, ci sono anche ben poche società quotate in borsa: non arrivano a 300, e nel 2001 le nuove quotazioni sono state 13. Spaventa parla di “anomala esiguità del numero delle società quotate in Italia” [14]. Qual è il motivo di questa anomalia? È semplice: i privati non ne vogliono sapere di quotare le loro società in Borsa. Perciò, quando leggiamo che le privatizzazioni delle grandi società pubbliche attraverso la loro quotazione in Borsa, “avvicinando i risparmiatori all’investimento azionario, ha aperto la strada della quotazione in Borsa ad imprese private meno note e di dimensioni minori” [15], leggiamo una cosa che, se è vera, lo è in così pochi casi da essere praticamente... falsa.
Del resto, lo stesso incremento degli scambi e della capitalizzazione di Borsa di questi ultimi anni è dovuto in gran parte, direttamente e semplicemente, ai collocamenti connessi alle privatizzazioni [16]. Il Ragioniere generale dello Stato, Monorchio, ha recentemente ricordato che “i tre quarti della capitalizzazione di Borsa sono costituiti da società che sono state di proprietà dello Stato”.
Visto sotto questo profilo, il tanto decantato “decollo del mercato borsistico italiano” ha tutto l’aspetto di un trucco. E del resto, quando si parla di queste cose, si dimentica di dire che l’investimento borsistico è stato, anche per molti piccoli risparmiatori, un passo quasi obbligato. Infatti in questi ultimi anni uno dei tradizionali beni di investimento dei risparmiatori italiani, ossia i BOT, ha perso praticamente ogni attrattiva; inoltre nei primi anni Novanta il (primo) Governo Amato ha imposto una tassa del 27% sugli interessi dei conti correnti, a fronte di una tassa di appena il 12,5% sui guadagni da investimenti borsistici. Altro che “spontaneità del mercato” e “libertà del consumatore/risparmiatore”! In questo modo ingenti quantità di risparmio privato in fuga dal debito pubblico sono state forzosamente immesse nei mercati di Borsa. Qui il risparmio “liberato” dal debito pubblico ha incontrato le azioni delle società ex-pubbliche, anch’esse “messe in libertà”.
Si rendevano così disponibili importanti capitali (sotto forma liquida e sotto forma di società) in grado di essere inseriti in un processo di concentrazione su scala tendenzialmente europea. Questo, e non fantasiose forme di “democrazia economica” da piccoli speculatori di Borsa, è il punto di approdo delle privatizzazioni italiane. Anche e soprattutto delle privatizzazioni bancarie.
-----
4. La concentrazione bancaria
La concentrazione del settore bancario è un fenomeno di portata mondiale. Per avere un’idea dell’entità del fenomeno basteranno pochi dati: dal 1990 al 2000 sono state effettuate nel mondo 7.500 fusioni e acquisizioni tra banche, del valore di 1.600 miliardi di dollari; questo processo ha avuto una notevole accelerazione all’interno del periodo considerato, ed in particolare negli ultimi 3 anni (in Europa i 2/3 delle operazioni sono avvenuti negli ultimi 3 anni); soprattutto negli ultimi 2 anni, sono cresciute in misura considerevole le joint-venture e le alleanze strategiche tra banche di Paesi diversi (ossia forme “soft” di fusione) [17].
Per quanto riguarda l’Italia, basterà ricordare che dal 1987 al 2000 il numero delle banche è sceso da 1.200 a 864; e, soprattutto, che si sono formati 5 gruppi che da soli hanno il controllo di quasi il 50% del mercato del credito: Unicredito, Banca Intesa-BCI, San Paolo-IMI, Banca di Roma, Montepaschi. Esattamente lo stesso, in base alle dichiarazioni del FMI, succede in Europa, dove “il sistema finanziario è in mano ad un numero ristretto di grandi banche: nella maggior parte dei casi i 5 maggiori istituti gestiscono più del 50% degli assets totali”.
Questo processo di concentrazione in atto nel settore finanziario è, ad un tempo, effetto e causa della tendenza alla concentrazione e centralizzazione dei capitali che ha luogo a livello mondiale.
È effetto di questa tendenza nel senso che, al pari di ogni altro settore, anche quello dei servizi finanziari deve fare i conti con la necessità di combattere la caduta del tasso di profitto. Utilizzo di economie di scala e di economie di scopo, riduzione dei costi di produzione, aumento della massa di capitale monetario necessaria per sostenere processi di ristrutturazione aziendale, operazioni di acquisizione ecc. [18]; e - last but not least - aumento del “potere di mercato” (ossia, tentativo di ottenere rendite monopolistiche incorporando i concorrenti): tutte queste motivazioni, che vengono di volta in volta addotte per spiegare le fusioni e acquisizioni nel settore finanziario, sono in fondo riconducibili al più generale tentativo di combattere la caduta del tasso di profitto.
Va notato che l’“aumento del potere di mercato” - locuzione eufemistica a cui si fa ricorso per evitare di pronunciare una brutta parola come “monopolio” - è un movente di queste operazioni assai più concretamente verificabile dei “guadagni di efficienza” tanto spesso sbandierati. In effetti, questo è quanto emerge da una ricerca svolta nel 2001 dalle banche centrali del G-10 sul processo di “consolidamento” (ossia di concentrazione monopolistica) [19].
Questo discorso vale anche per gli effetti delle privatizzazioni bancarie italiane? Assolutamente sì. Lo dimostra la più recente ricerca sul tema delle performance delle banche italiane pre- e post-privatizzazione, che fra l’altro confronta le banche privatizzate con quelle che (soprattutto a livello locale) sono rimaste sotto il controllo pubblico. I risultati sono sorprendenti - soprattutto per chi si è sentito ripetere per anni che uno degli obiettivi principali delle privatizzazioni era quello di “migliorare l’efficienza delle imprese privatizzate”.
Primo: “I dati sui tassi di crescita dell’attivo [ossia dei fondi intermediati dalle banche] rivelano come in media le banche rimaste sotto il controllo delle fondazioni siano cresciute in misura più elevata rispetto alle banche in cui le fondazioni hanno ceduto il controllo”.
Secondo: Nelle banche grandi la produttività non è affatto cresciuta in maniera spettacolare dopo le privatizzazioni. Per quanto riguarda le medio-piccole, poi, “le banche in cui le fondazioni hanno ceduto il controllo hanno evidenziato performance peggiori”.
Terzo: “Il grado di patrimonializzazione complessivo delle banche italiane non ha subito modificazioni sostanziali in conseguenza della privatizzazione”.
Quarto: Gli indicatori di redditività danno (a quanto dice lo stesso autore) risultati “sorprendenti”. Nel senso che non danno alcuna indicazione chiara per le banche grandi, e dicono con chiarezza che le banche piccole non privatizzate vanno meglio di quelle privatizzate. Per quanto riguarda le banche straniere, poi, si ha addirittura “un netto peggioramento della redditività negli anni successivi alla privatizzazione”.
Dopo aver messo in luce tutti questi aspetti, l’autore della ricerca conclude sostenendo che “è difficile dire se le privatizzazioni bancarie abbiano ‘funzionato’” [20]. E pensare che a noi sembrava così semplice trarre una conclusione...
5. Cui prodest?
A chi giova tutto questo? Per rispondere a questa domanda bisogna partire dal fatto che il processo di concentrazione nel settore bancario-finanziario-assicurativo ha una sua importante specificità: esso è al tempo stesso attore della concentrazione in altri settori. Fu Marx ad osservare che “il sistema del credito” (ma questo vale ovviamente più in generale per le odierne attività finanziarie) diviene ben presto “un’arma nuova e terribile nella lotta della concorrenza trasformandosi infine in un immane meccanismo sociale per la centralizzazione dei capitali”.
Vediamo come funziona quest’arma nella situazione attuale. La concentrazione del settore finanziario a livello nazionale è pressoché completata. Il prossimo passo sarà rappresentato da concentrazioni transnazionali, soprattutto a livello europeo. Ci sono, è vero, tentativi di ritardare questa integrazione: in questo sforzo, ad esempio, si concentra praticamente tutta l’opera del governatore Fazio, quando non è occupato a leggere (in pubblico) San Tommaso, o a fare (in privato) favori a banchieri amici, e dispettucci a quelli che gli sono meno simpatici. Ma si tratta di una posizione di retroguardia, votata alla sconfitta, che avrà come unico risultato quello di rendere più dolorose per le nostre banche (leggi: per i loro lavoratori) le inevitabili fusioni transnazionali che avranno luogo di qui a 5 anni.
Le concentrazioni nel settore finanziario europeo, a loro volta, comporteranno una restrizione del credito alle piccole e medie imprese. Questo è già avvenuto negli Stati Uniti nei primi anni Novanta, a seguito della crisi delle casse di risparmio e della successiva ondata di concentrazioni [21]. Questa circostanza è esplicitamente ammessa nella citata ricerca del G-10, sia pure con la cautela e gli eufemismi del caso [22]. Le soluzioni suggerite per questo problema sono risibili: ad es., “facilitare l’accesso delle piccole imprese alla Borsa”. Oppure di una genericità sconcertante: come quando si propone di “sviluppare canali di finanziamento alternativi a quelli bancari tradizionali” [i]. Ora, a meno che non si intenda fare riferimento all’usura (alternativa al credito tradizionale già molto praticata...), quest’ultimo suggerimento può sensatamente riferirsi soltanto al mercato delle obbligazioni. Che però purtroppo sono molto più costose dei prestiti bancari tradizionali. Per avere un’idea della differenza, basti pensare al fatto che in media, a livello europeo, i prestiti delle banche alle imprese sono superiori del 2% ai buoni del tesoro. In America (dove il mercato obbligazionario è molto più sviluppato) la differenza arriva sino al 10% [23]. Quindi: restrizione del credito e spinta al processo di centralizzazione dei capitali.
Questo ci dà la prima (e più importante) risposta alla domanda: “cui prodest?”. Questo processo giova al grande capitale monopolistico. Siamo sinceramente dispiaciuti di dover usare questo frasario antiquato, ma se le cose stanno così non possiamo farci niente.
A chi altro giova?
Il processo di privatizzazione delle banche italiane - l’abbiamo visto - ha giovato senz’altro alle grandi investment banks anglosassoni, grazie alle lucrose commissioni che hanno potuto incamerare.
Ha giovato ad un pugno di boiardi di Stato che, di piroetta in piroetta, son riusciti a passare indenni dalla guida delle ex-banche pubbliche alla guida delle stesse banche privatizzate. E ora, da “boiardi” che erano, si sono trasformati in “managers”. [24]
Ha giovato infine anche ad alcuni ex-capitalisti industriali (leggi FIAT), per i quali le privatizzazioni delle banche hanno rappresentato un’occasione d’oro per consolidare le loro posizioni nel business assicurativo-bancario, acquisire partecipazioni nelle banche privatizzate, preparandosi così ad uscire senza danni (per loro) dal loro business tradizionale.
E ora vediamo a chi questo processo non giova.
Non giova ai bancari (che, a dispetto della loro fama, sono sempre più “esuberanti”, e quindi vengono falcidiati in massa ad ogni “giro” di fusione tra banche).
Non giova alla concorrenza - e la cosa dovrebbe essere di banale comprensione, con 5 banche che da sole controllano il 50% del mercato. E questo, per scendere più nel concreto, significa che:
• non giova ai risparmiatori, che non hanno affatto visto migliorare le condizioni praticate dalle banche (ad es. sui concorrenti); [25]
• non giova neppure alle tanto mitizzate piccole e medie imprese, che si vedranno progressivamente restringere il credito.
6. E ora?
Il 6 maggio scorso l’inserto economico del Corriere della sera titolava: “Privatizzazioni finite?”. È un titolo che, alla luce di quanto abbiamo visto, induce alla speranza. Speranza vana, perché il gioco procede: ora tocca alle aziende municipalizzate locali, alle poste, alla RAI, forse alle ferrovie... La svendita e la privatizzazione del patrimonio dello Stato non si ferma. Può sembrare un po’ forte, come giudizio. Però la realtà l’ha già superato: il governo Berlusconi ha appena inventato la “Patrimonio dello Stato S.p.A.”.
|
SCHEDA
“Draghi sceglie super - poltrona alla Goldman”. Così
recitava il 29 gennaio scorso un titolo del Sole 24 ore. L’Inizio dell’articolo
corrispondente era addirittura lirico: “da servitore dello Stato ai massimi
livelli alla Goldman Sachs, una delle stelle dell’empireo dell’investment
banking mondiale”. Più avanti , il giornalista sottolineava il significato
della “scelta di un’esperienza piena nel mondo del business per un uomo
che, dall’altra parte della barricata, aveva gestito il maggiore processo
europeo di privatizzazione dopo quello britannico”. Ora che la Goldman
Sachs abbia bisogno di forze fresche è fuori dubbio. Pensate che i suoi
analisti, ancora il 9 ottobre dell’anno scorso, dicevano che le azioni
Enron erano “il meglio del meglio”: dopo nemmeno due mesi, la Enron dichiarava
fallimento. Del pari, sarebbe azzardato considerare una sciagura il fatto
che il Prof. Draghi passi più tempo a Londra che a Roma. Insomma, per
una volta ci sentiamo di condividere l’entusiasmo del giornale della Confindustria.
Ecco, comunque, l’elenco dei pochi contratti di con sulenza ottenuti da Goldman Sachs per le privatizzazioni italiane: |
[1] Qui “Stato” sta, ovviamente, per “Parlamento” (che è detto “potere legislativo” appunto perché fa le leggi, anche se il prof. Draghi non lo sa). Questo simpatico esempio di disprezzo dell’istituzione parlamentare è stato pubblicato, senza mai ricevere una smentita, dal Corriere della Sera il 30 marzo 2001.
[2] Come è noto, sull’opportunità di alcuni dei parametri, ad es. la soglia di inflazione al 3%, sussistono fondati dubbi. In ogni caso, in linea generale, va sottolineato il carattere di scelta politica dell’assunzione di questi parametri e non di altri. È importante insistere su questo perché di fatto tali criteri sono generalmente considerati, dalla pubblicistica corrente, come le “tavole della legge” di Mosè o addirittura come “leggi naturali”. Non è così: non esiste una politica monetaria oggettivamente necessaria, così come non esiste una politica monetaria neutrale rispetto alle classi.
[3] Come si vedrà più avanti, è assai dubbio che questo secondo obiettivo sia stato conseguito. Del resto, anche in questa sede è citato come riempitivo d’obbligo: infatti nella frase successiva questo obiettivo sparisce e rimane quello, prioritario, di ridimensionare il ruolo dello Stato.
[4] D. Scannapieco, “Le privatizzazioni in Italia: una riflessione a dieci anni dal rapporto presentato al Ministro del Tesoro Guido Carli”, in Guido Carli e le privatizzazioni dieci anni dopo, a cura di F. A. Grassini, Roma, Luiss Edizioni, 2001, p. 156, corsivi miei.
[5] Nota: la quota ceduta dal Tesoro è pari al 3% del capitale ord, per 286 mld. Il valore finale si riferisce alla somma derivante da vendita diretta di azioni e dalla successiva conversione di obbligazioni emesse dall’IRI; includendo solo il ricavo della vendita diretta di azioni tale valore scenderebbe a poco meno di 670 mld. Fonte: Banche e Assicurazioni, Convegno nazionale FISAC CGIL, aprile 2001.
[6] Il calcolo è fatto sul totale di gruppi bancari, nei quali comunque la ex-banca privatizzata di norma è la componente più di peso. La sproporzione tra le cifre di partenza e quelle di arrivo è comunque clamorosa, ad eccezione dei casi di Banca di Roma e BNL (per Medio Credito il confronto non è possibile perché non è una società quotata).
[i] Il Sole 24 Ore, 7 agosto 1998.
[7] Vedi D. Scannapieco, cit., pp. 186-7.
[8] Vedi G.M. Gros-Pietro, E. Reviglio, A. Torrisi, Assetti proprietari e mercati finanziari europei, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 112-4.
[9] Al tema della “spersonalizzazione del potere” nelle imprese (visto però soprattutto sotto il profilo dell’allontanamento dei centri decisionali a causa delle fusioni tra imprese) è stato dedicato l’inserto economia di Le Monde del 24/4/2001.
[10] CONSOB, Incontro annuale con il mercato finanziario, Discorso del presidente Luigi Spaventa, Milano, 8 aprile 2002, p. 10. Spaventa sembra considerare criticamente questi fenomeni. Evidentemente non è così: infatti il 6 maggio la CONSOB ha consentito alla Edison di continuare ad essere quotata, limitando il flottante minimo al 5% delle azioni della società. In questo modo ai proprietari di Edison viene risparmiato l’esborso di soldi che deriverebbe dall’obbligo di lanciare un’OPA residuale sul flottante stesso. Tra i padroni di Edison c’è la FIAT.
[11] “Diritti ai dividendi” equivale a “proprietà delle azioni”: infatti percepisce un dividendo soltanto chi effettivamente possieda le azioni che danno diritto ai dividendi stessi.
[12] Ivi, p. 11. Per la crescita delle società controllate di diritto e di fatto vedi le tavole riportate nei Dati e Analisi che corredano la relazione del Presidente CONSOB, p. 133.
[13] Ivi, p. 12.
[14] G. Siciliano, “Le privatizzazioni bancarie in Italia. Qualche evidenza sulle performance pre- e post- privatizzazione”, in Guido Carli e le privatizzazioni dieci anni dopo, cit., p. 193.
[15] CONSOB, Incontro annuale con il mercato finanziario, cit., p. 17.
[16] D. Scannapieco, “Le privatizzazioni in Italia...”, cit., p. 168.
[17] La stessa CONSOB, commentando il fatto che nel 2001 il controvalore delle offerte di vendita di società in borsa è diminuito, ammette candidamente che “tale dato è essenzialmente dovuto alla notevole diminuzione delle offerte legate alla privatizzazione di imprese pubbliche” (Dati e analisi, cit. p. 31).
[18] Dati citati da R.W. Ferguson jr., “Understanding Financial Consolidation” (pp. 2-3) e da D. Clementi, “Recent developments in financial markets: some implications for financial stability” (p. 1), nei loro interventi alla International Banking and Financial Systems Conference, Roma, 9 marzo 2001.
[19] Per avere un’idea delle grandezze in gioco basterà ricordare che per il salvataggio di Lucent Technologies, nello febbraio 2001, sono stati necessari 7 miliardi di dollari. Questa cifra è stata raccolta in brevissimo tempo da tre sole banche. E l’operazione è stata citata dal Financial Times come “un’impressionante dimostrazione del potere esercitato dai nuovi giganti che dominano la scena finanziaria di New York” (FT del 17/4/2001). Del resto, la stessa acquisizione di Telecom da parte di Colaninno & C. aveva richiesto finanziamenti per 61 miliardi di euro.
[20] Ne Il processo di consolidamento nel settore finanziario. Summary Report (gennaio 2001) si legge che “gli studi empirici suggeriscono che le fusioni possono fornire l’opportunità di incrementare i ricavi attraverso aumenti di efficienza o un rafforzamento del potere di mercato” (p. 21). Poi però R.W. Ferguson jr., nell’esporre in sintesi i risultati della ricerca, afferma (eufemisticamente) che “the overall evidence in favor of efficiency gains is weak”: “Understanding Financial Consolidation”, cit., p. 10. Nella stessa sede il governatore della Banque de France, J.-C. Trichet ha motivato le fusioni del settore con “la ricerca di un potere di mercato e/o di economie di scala”; poi ha aggiunto: “noi dobbiamo essere coscienti di certi pericoli derivanti da questa rincorsa della dimensione (course à la taille), la cui logica ultima [sic!] sarebbe quella di dar vita ad un oligopolio” (“L’évolution récente du système financier international et ses répercussions sur l’efficacité et la stabilité des intermédiaires et des marchés”, pp. 6 e 12, corsivi nostri).
[21] G. Siciliano, “Le privatizzazioni bancarie in Italia”, cit., pp. 205, 208, 210, 212, 218.
[22] Vedi A. N. Berger, G.F. Udell, Universal Banking and the Future of Small Business Lending, 1995; A.N. Berger, A.K. Kashyap, J. Scalise, The Transformation of the U.S. Banking Industry: what a Long Strange Trip It’s Been, 1996. Nella stessa direzione (razionamento del credito alle PMI) vanno di fatto le proposte formulate dal Comitato di Basilea per una riforma dei requisiti di capitale a copertura dei crediti (v. New Basel Capital Accord su www.bis.org). Di recente la Germania ha ottenuto lo slittamento dell’entrata in vigore dell’accordo al 2006. Ma, anche in questo caso, non si fa che prolungare l’agonia...
[i] Il processo di consolidamento..., cit., pp. 11, 42-3.
[23] Vedi rispettivamente, ivi, p. 44 e p. 15.
[24] V. J. Sproule, The Death of Europe’s Old-Style Banking, in Wall Street Journal Europe, 8/1/2001.
[25] E in più, spesso e volentieri, sono stati anche malconsigliati nell’investire i risparmi: la gran parte del debito argentino, è stata girata dalle banche ai loro clienti.
