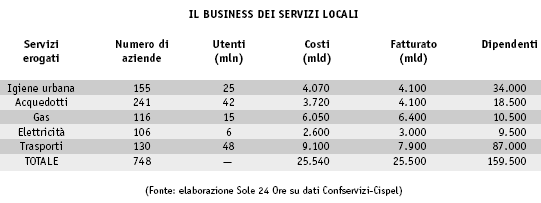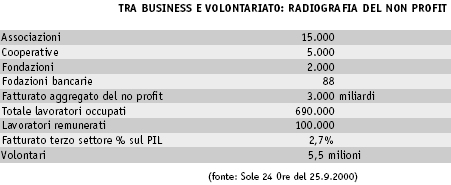![]()
Rubrica
L’analisi-inchiesta
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Sergio Cararo Ricercatore socio-economico di CESTES-PROTEO
“The Federal Business Revolution”. Parte prima: i percorsi attuativi della “grande” riforma della Pubblica Amministrazione Il federalismo dei nuovi boiardi
Tutti gli articoli della rubrica: analisi-inchiesta(in tutti i numeri di Proteo)
|
8. I managers del federalismo
Infine, ma non certo per importanza, siamo arrivati ai peggiori di tutti: i managers e gli amministratori delle aziende locali privatizzate o delle nuove aziende del “non profit”. Costoro, a differenza dei segmenti indicati antecedentemente, non vengono più nominati dagli amministratori ma dagli azionisti di riferimento (incluse, lì dove sopravvivono quote azionarie, le amministrazioni locali che hanno privatizzato le aziende) o dai donatori delle aziende “non profit”.
Ma per inquadrare questi protagonisti emergenti della “nuova classe dirigente federalista”, occorre avere una idea della posta in gioco. La tabella non fornisce i dati sui profitti ma possiamo segnalarne alcuni per dare una idea. Nel 1998, la AEM di Milano ha avuto profitti per 348 miliardi, l’ACEA di Roma per 290, la AEM di Torino per 83 e poi, AMGA di Verona per 69, AGAC di Reggio Emilia per 55 miliardi, etc. AEM e ACEA compaiono ormai tra i primi quaranta gruppi industriali italiani [1]. Queste aziende si sono lanciate come corsari nella guerra all’acquisizione di altre aziende in vari settori (inclusa l’UMTS) conformandosi sempre più come “holding multiutilities” con interessi estesi in Italia e all’estero. Il loro vantaggio è la posizione di monopolio che gli deriva dalle concessioni pubbliche sui servizi locali che gli offre una massa critica di partenza e la possibilità di scaricare sulle tariffe dei servizi gli eventuali “insuccessi” delle loro scorrerie. In breve tempo, queste aziende locali privatizzate sono diventate regine delle borse e riferimento delle acquisizioni azionarie della nuova classe dirigente. Prima di Tangentopoli la nomina dei presidenti delle aziende municipalizzate era oggetto di contenzioso e compromesso tra i partiti che gestivano le giunte locali. Oggi il rapporto tra la politica e questi managers è semmai ancora più diretto ma trasversale all’Ulivo e al Polo. In parte ciò ha costruito dei margini di indipendenza tra il business e la politica ma in realtà ha integrato ancora di più che in passato la seconda con il primo. È il sistema della lobbies che caratterizza il modello americano. “Potente, aggressiva e soprattutto trasversale. È la lobby delle ex-municipalizzate. Una rete di intrecci e alleanze tra imperi economici comunali che sta avvolgendo l’Italia e calamitando sempre più su di se affari e denari” [2]. “Settori come quelli dell’energia elettrica e del gas, del teleriscaldamento, del trattamento dei rifiuti costituiscono da qualche anno business assai appetibili, anche perchè tutti caratterizzati da elevato potere di mercato (se non, ancora, da monopolio legale) [3]. Questi commenti non sono nostri ma degli inserti economici dei due maggiori quotidiani italiani, non imputabili quindi a simpatie anticapitaliste o antifederaliste. Essi fotografano una realtà che il federalismo liberista sembra intenzionato a peggiorare ulteriormente nei prossimi anni anche in settori come quelli dell’acqua e dei rifiuti. La possibilità di poter ormai intervenire liberamente sulle tariffe, assicura infatti agli investitori un business e profitti pressochè sicuri. Le tariffe dell’acqua, secondo la Federconsumatori, sono già aumentate del 26,5% negli ultimi cinque anni ma tutto lascia prevedere che la concentrazione dei gestori prevista e legittimata dalla Legge Galli e la liberalizzazione imposta da Bruxelles, spianeranno la strada all’assalto dei monopoli italiani (ENEL, ACEA etc.) e stranieri (Vivendi e General des Eau soprattutto) e ad un pesante aumento delle tariffe. Il giro d’affari sull’acqua rasenta i 100.000 miliardi di lire e le grandi manovre - vedi l’Acquedotto Pugliese o l’Acquedotto De Ferrari a Genova - sono già cominciate. Anche la nettezza urbana è destinata a diventare preda di questi corsari della finanza e dei servizi locali. Il passaggio da tassa a tariffa consegnerà presto il servizio nelle mani dei privati che potranno contare su un aumento delle tariffe che potrebbe raggiungere anche il 200%. In questo scenario appare difficile sperare, come cantava De André, che dal letame possano nascere fiori.
9. La clava della sussidiarietà
Questi nuovi protagonisti dell’assalto ai servizi pubblici, hanno impugnato come una clava la parola magica agitata dagli apprendisti stregoni del federalismo liberista: la sussidiarietà. I servizi pubblici, secondo questa interpretazione, devono essere gestiti dai soggetti privati perchè altrimenti rappresenterebbero un carico per le comunità locali che solo la privatizzazione potrebbe risolvere in termini di efficenza ed economicità. La priorità tra universalità del servizio pubblico e interesse privato viene così invertita favorendo il secondo e sancendo contestualmente il disimpegno del soggetto pubblico (Stato o ente locale) dalle proprie responsabilità nel patto con i cittadini. Questo assioma, diventato una sorta di vangelo, ci indica il nesso tra i managers e gli amministratori delle aziende locali privatizzate e i managers e gli amministratori delle società non profit esplose negli ultimi anni e che hanno avuto proprio nell’Emilia-Romagna il loro laboratorio ideologico e l’incubatoio pratico.
Dunque, tra consiglieri di amministrazioni delle cooperative, delle fondazioni e delle associazioni, si è sviluppato un piccolo esercito di almeno 40.000 managers della buona fede, alcuni di nome, altri di fatto. È un esercito destinato a crescere - stando a tutte le proiezioni- ma anche a ridurre a infima minoranza coloro che danno al non profit una dimensione fortemente etica. La trasformazione di questi amministratori del terzo settore in veri e propri gestori di quote crescenti di ricchezza sociale sta nei fatti. Da un lato il dogma della sussidiarietà affiderà sempre più a costoro la gestione dei servizi sociali “esternalizzati” dalle amministrazioni locali, dall’altro -essendo un settore in sviluppo recettivo di quote crescenti di finanziamenti pubblici e privati in linea con il modello amerikano- sul terzo settore si stanno attrezzando i panzer delle fondazioni bancarie e delle fondazioni private (che spesso veicolano e riciclano soldi in funzione di trattamenti fiscali più favorevoli). La Fondazione Cariplo (la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde), con un patrimonio di 14.000 miliardi è già oggi è all’ottavo posto nel mondo tra le società operanti nel non profit dopo sei società americane ed una inglese (precede addirittura fondazioni storiche come la Rockfeller e la Kellog) [4]. I corsari delle fondazioni bancarie e private, lamentano l’eccessiva dipendenza delle società non profit dal settore pubblico e invocano mano libera e stretta connessione al mondo delle imprese “profit” vere e proprie. Il deus ex machina del terzo settore in Italia, Stefano Zamagni, cattolico “prodiano” e docente all’Università di Bologna, afferma testualmente che si sta delineando una “via italiana al non profit” adeguato al contesto del nostro paese “dominato dalla presenza delle piccole e medie imprese. Non è affatto casuale” aggiunge Zamagni “che in Italia si registri una stretta correlazione tra PMI e iniziative non profit”. Tra l’invasività delle fondazioni e il “dominio” delle piccole e medie imprese, il problema del terzo settore sarà sempre più quello di rendere conto sempre più ai “donatori” e sempre meno agli utenti. È il meccanismo micidiale che ha snaturato e cooptato, ad esempio, la stragrande maggioranza delle ONG attive nella cooperazione internazionale (oggi in Italia ne esistono ben 130 riconosciute dalla Farnesina) fino a renderle in buona parte strumento della politica di smobilitazione nelle aree di conflitto sociale dei paesi in via di sviluppo o strumento di aperta collaborazione con la politica di “ingerenza umanitaria” delle maggiori potenze e dei rispettivi Stati Maggiori o servizi segreti (vedi l’Operazione “Arcobaleno” in Kossovo o il ruolo delle statunitensi “Care”e “IRC” nell’enclave kurda in Iraq). Su questo uno studioso rigoroso e autorevole come James Petras ha scritto osservazioni che andrebbero pubblicizzate e discusse seriamente [5]. La sussidiarietà si rivela così un espediente strettamente connesso al modello liberista e dunque al Profit State. Questa logica è stata imposta dall’alto con il processo di unificazione economica e politica europea ed ha trovato un corrispondente diretto nella richiesta di federalismo degli enti locali. In questo, la devolution di Formigoni o il documento “Il federalismo preso sul serio” dell’assessore regionale emiliano Mariucci (DS), sono perfettamente compatibili fra loro.
10. Conclusioni? No, siamo appena all’inizio
Paradossalmente, ma non troppo, le amministrazioni locali hanno largamente anticipato lo Stato centrale nella realizzazione di questo processo. Solo il “furore federalista” del ministro Bassanini ed i governi dell’Ulivo hanno infine creato la cornice costituzionale per portare fino in fondo l’operazione. Questa nuova classe dirigente è il frutto avvelenato della modernizzazione capitalistica ed europeistica dell’Italia che porta forte l’impronta e il segno della sinistra di governo, su questo c’è un fortissimo nesso tra il Craxi degli ’80 e il D’Alema negli anni ’90. Tra i “rampanti craxiani” e i “rampanti” ulivisti la sola differenza consiste nel fatto che i secondi hanno scalzato i primi con una operazione politica, culturale ed istituzionale che ha potuto contare su maggiore controllo e consenso sociale. I berlusconidi che governano le regioni del Nord sono consapevoli di questa partita e puntano a rafforzarsi sul piano locale che è in grado oggi di assicurare maggiori poteri di un governo centrale su cui pesano sempre più i vincoli di manovra e le ipoteche del supergoverno europeo rappresentato dalla Commissione di Bruxelles. Il quadro emerso in questi mesi porterebbe a dire che non dobbiamo temere solo i vari Mr.H(a)yde(r) prodotti dalla destra in questa Europa ma anche i numerosi dott. Jekill prosperati con i governi di centro-sinistra a livello locale e centrale. [1] “Le cinquemila società leader” classifica curata da Morgan Stanley Capital pubblicata come inserto speciale da Milano/ Finanza, novembre 1999. [2] “Piccoli boiardi. Nuovi e federalisti”in CorrierEconomia del 23 ottobre 2000. [3] “Il Comune imprenditore nemico della concorrenza” in Affari e Finanza del 20 novembre 2000. [4] ”Il boom del terzo settore” in Sole 24 Ore del 25 settembre e dell’8 novembre 2000. [5] “Le ambiguità del ruolo delle ONG in America Latina” in ”Resumen Latinoamericano” dell’aprile 1999. Tradotto e pubblicato in Italia da Contropiano, giugno 1999.
|