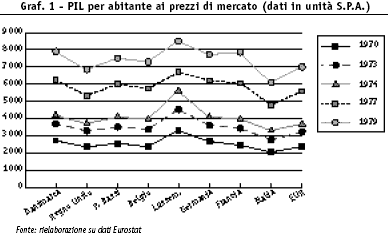![]()
Rubrica
L’analisi-inchiesta
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Luciano Vasapollo Docente di Economia Aziendale, Fac. di Scienze Statistiche, Università’ “La Sapienza”, Roma; Direttore Responsabile Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali (CESTES) - Proteo. Rita Martufi Consulente ricercatrice socio-economica; membro del Comitato Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico Sociali (CESTES) - PROTEO
Ristrutturazione capitalistica
Le tendenze macroeconomiche del processo di ristrutturazione capitalistica
Tutti gli articoli della rubrica: analisi-inchiesta(in tutti i numeri di Proteo)
|
Dopo l’analisi-inchiesta sulla modificazione della geografia dello sviluppo in Italia (n.0 di Proteo), quella sulle privatizzazioni in Italia e in Europa (n.1 e 2/98 di Proteo) e quella sulla legge della rappresentanza sindacale (n.1 e 2/98 di Proteo), la nostra rivista si “tuffa” in una nuova, difficile prova. In questo numero di Proteo e nei primi due numeri del 1999 affronteremo un’analisi-inchiesta a carattere macroeconomico per valutare, attraverso alcuni importanti parametri, come si è andato strutturando il processo di accumulazione capitalistica dagli anni ‘70 ai nostri giorni. La crisi economica che stiamo vivendo è iniziata nel 1968 con la rimessa in causa del Welfare State in occidente; con il 1971, prima della crisi petrolifera, la soppressione della convertibilità del dollaro, e conseguentemente con il rovesciamento di una forma di egemonia americana; con il 1975 e il progetto di un nuovo ordine economico internazionale che i paesi non allineati hanno presentato, e che è stato respinto dai paesi occidentali, aprendo in seguito la crisi del debito del Sud; con l’ingenuo progetto gorbacioviano di perestroika e con la disgregazione, che va dal 1989 al 1991, dell’Europa del Est e lo sfaldamento dell’URSS. Già nel 1970 la crescita economica e di espansione dei mercati era notevolmente rallentata e dal 1980 tutto il mondo è entrato in un periodo di stagnazione. Dal 1980 ad oggi i maggiori paesi capitalistici si sono preoccupati esclusivamente di gestire la crisi nei due terzi del globo inventando nuovi sbocchi finanziari. Per evitare la svalutazione del capitale si sono adoperate un insieme di misure come per esempio sul cambio, sui tassi di interesse, le privatizzazioni, la deregulation. La gestione della crisi, fino ad ora usata, ha degli elementi di debolezza: da un lato accentua la dicotomia del sistema Ovest nuovo Est; dall’altro produce effetti sociali all’interno dell’occidente a capitalismo avanzato che rimettono in discussione gli stessi assetti politici innanzitutto. Finanziariamente porta al predominio di un ciclo di accumulazione accresciuto senza passare attraverso alcun intermediario produttivo: non c’è trasformazione del capitale in mezzi di produzione, in produzione effettiva e in realizzazione del surplus da investimento produttivo. Localmente la finanziarizzazione si unisce ad un aggravio enorme della disuguaglianza nella distribuzione interna del profitto, con conseguenza di un arretramento delle stesse forme politiche ed economiche che erano tipiche delle democrazie in occidente. Oggi il capitale reclama sempre maggiori profitti con la scusa dell’accresciuta competitività internazionale e della globalizzazione. Il pensiero unico neoliberista trasmette nell’intera società la sua cultura di darwinismo economico e sociale, in nome del mercato e degli esclusivi interessi d’impresa. L’attuale situazione economica è caratterizzata da una globalizzazione dell’economia e da una concorrenza molto forte e dura, che è in primo luogo una concorrenza dove ognuno intende aumentare la produttività riducendo però i costi. Oggi sono gli aspetti finanziari a prevalere a tutto il sistema. A essere nel mirino ora sono i salari, i contributi sociali, il sistema sociale nel suo insieme; da parte del capitale viene disdetto lo Stato Sociale come compromesso di classe; prevale una politica neoliberista, cioè una politica di puro mercato. Le esigenze del capitale privato vengono in primo luogo rispettate e la crescita del profitto dell’impresa privata sta al centro delle attività politiche ed economiche. Lo Stato, nelle sue diverse forme e articolazioni, si è fatto Profit State tentando di abbattere anche quelle conquiste minime in termini di “Welfare” ottenute attraverso dure lotte del movimento operaio e dei movimenti sociali che si sono sviluppati in particolare negli anni ‘60 e ‘70. Nello stesso tempo la percezione soggettiva della crisi dello Stato Sociale, nei gruppi che a vario titolo ne sono investiti, determina drammatici fenomeni di rottura della fiducia nei confronti dei ceti politici dello stesso Stato, un profondo scollamento rispetto alle istituzioni. Da un lato, la paura di perdere quei piccoli privilegi che alcuni gruppi sociali intermedi avevano ormai maturato pensando di appartenere a settori garantiti e attività comunque incluse sotto la protezione dello stato sociale. La privatizzazione del pubblico impiego, dei sevizi pubblici, la stessa aziendalizzazione di funzioni tipiche dello Stato Sociale, come l’istruzione, la sanità, ecc. stanno ovunque generando fenomeni di desocializzazione e di unità, almeno ideale, tra ceti ex intermedi e la massa di coloro nei quali opera l’esclusione definitiva dal circuito lavorativo occupazionale e vedono precario il loro futuro. La crisi dello Stato Sociale rappresenta la crisi generale della forma politica e statale attraverso cui l’occidente capitalizzato ha sviluppato un certo rapporto tra momento produttivo e momento sociale. La crescente internazionalizzazione prima dei flussi finanziari e poi l’ampliarsi del processo di deindustrializzazione dei paesi occidentali ha fatto sì che le condizioni economiche e le politiche economiche a livello del singolo paese abbiano oggi scarsa influenza nell’incidere su meccanismi di accumulazione sempre più globali. Da questo punto di vista il processo di internazionalizzazione dell’economia mondiale si fonda su una divisione del lavoro che vede i paesi occidentali detenere in modo sempre più concentrato il potere finanziario e tecnologico ed il controllo dei flussi commerciali e i paesi interagenti del terzo mondo oggetto della semplice trasformazione delle merci. E’ così più semplice globalizzare anche la cultura del “disastro mondiale” se non si accettano le ricette del neoliberismo; la cultura del mercato selvaggio diventa quella della “salvezza dell’umanità” poiché sembra sempre di essere in procinto di un crollo dell’economia internazionale che riporterebbe anche i paesi occidentali a livelli di assoluta povertà. Con questo messaggio si innesca il terrorismo sociale funzionale ai piani di ristrutturazione del capitale e alla ridefinizione per nuove aree di influenza, messaggio fatto proprio anche dai governi di centro-sinistra, da alcuni ex leader di quel che resta ed in forma degenere del socialismo riformista, i quali hanno assunto il capitalismo come utlima possibilità di governo dell’umanità, in modo, come lucidamente suggerisce Milan Kundera, DA POTER RICEVERE UN PÒ D’AVVENIRE IN CAMBIO DEL LORO PASSATO. Altro che crisi economica! Crisi si, ma tutta sulle spalle dei lavoratori, della gente comune, però con incrementi dell’accumulazione complessiva di capitale mai visti prima! Va ricordato immediatamente che negli ultimi venti anni l’incremento medio della produttività del lavoro (2%) è il risultato di una crescente sostituzione del lavoro con il capitale. Questa situazione aggrava ancora di più il problema della disoccupazione anche perché questa sostituzione tra lavoro e capitale dovuto all’innovazione tecnologica, all’aumento dei ritmi di sfruttamento dei lavoratori, non ha realizzato un aumento dei salari reali ma un notevole e consistente aumento dei profitti reali, poiché non si sono verificate neppure diminuzioni di orario di lavoro a parità di salario, né incrementi occupazionali, né aumenti di spesa per la protezione sociale. Le disuguaglianze di reddito e di condizioni di vita nei diversi paesi, anche quelli a capitalismo avanzato, si sono accentuate a causa di sempre più spietate forme di accumulazione capitalistica da parte dei detentori di potere finanziario e monetario. La vera globalizzazione degli anni ‘90 è stata quella delle operazioni monetarie e finanziarie non certo quella degli scambi di beni e libera circolazione delle persone! La finanziarizzazione dell’economia, realizzata anche attraverso investimenti finanziari resi possibili grazie al surplus di profitti derivati dalla mancata distribuzione al fattore lavoro degli incrementi di produttività e destinati solo in piccola parte agli investimenti produttivi, la liberalizzazione degli scambi e i vantaggi della libera circolazione delle merci, hanno assicurato ai grandi gruppi industriali oltre che una maggiore scelta nella diversificazione della tecnologia e degli impianti, incrementando i processi di accumulazione del capitale, anche una differenziazione dell’offerta e della clientela. L’integrazione tra i paesi dell’Unione Europea ha permesso alle grandi imprese di trovare manodopera a basso prezzo all’interno del mercato europeo anche senza dover eccessivamente delocalizzare fuori dall’Europa le loro produzioni. Le differenze esistenti a tutt’oggi tra i vari paesi in merito alle prestazioni sociali (assistenza alle famiglie, le diverse forme di reddito minimo, garantito solo per i livelli assoluti di povertà) ci fanno comprendere ancora più chiaramente che l’Europa monetaria e gli obiettivi del trattato di Maastricht raggiunti con enormi difficoltà, rinvii ed ostacoli vari, non hanno tenuto in alcun conto gli aspetti sociali ed occupazionali. Se dal punto di vista economico, monetario e finanziario è possibile raggiungere una certa apparente corrispondenza economico-finanziaria tra i vari paesi (anche se a nostro avviso con enormi difficoltà e inasprendo ulteriormente l’attacco alle condizioni di vita dei lavoratori) altra cosa è arrivare ad una omogeneità sugli aspetti sociali che richiedono adeguamenti e cambiamenti reali in ciascun paese; obiettivi non realizzati perché i paesi membri , ed in particolare l’Italia, hanno dovuto trascurare ed affossare problemi fondamentali come quello dell’occupazione e di un coerente piano di sviluppo proprio per arrivare a raggiungere i parametri imposti dall’U.E. Il prezzo da pagare per “entrare” nell’Europa dei finanzieri è stato comunque troppo alto! Aumento dei ritmi di lavoro, tagli ai salari reali, disoccupazione, lavoro precario, sottopagato, senza diritti, tagli allo stato sociale, aumento della povertà, emarginazione, peggioramento delle condizioni di vita, è il prezzo pagato e ancora da pagare per l’Unione Europea. L’analisi-inchiesta che inizia con questo numero vuole evidenziare, a partire da una ricerca macroeconomica su dati ufficiali (Eurostat, ISTAT, OCSE, Banca Mondiale, ecc.) quello che sta succedendo nei nuovi assetti dei paesi a capitalismo avanzato, proponendo, in particolare, dei confronti soprattutto fra situazione italiana e quella degli altri paesi europei, con alcuni riferimenti a quella del Giappone e degli Stati Uniti. Nelle tre più importanti aree del capitalismo (quella del dollaro, quella dello yen e la nascente area dell’EURO) verranno analizzati i dati relativi ai fattori del capitale (produttività, investimenti, ammortamenti, tassi di accumulazione, confronti ricavi e profitti) e quelli più direttamente legati al fattore lavoro (occupazione, disoccupazione, orari di lavoro, andamenti salariali, spese sociali più direttamente legate alle politiche del lavoro), fino a cercare di leggere attraverso i dati i processi di internazionalizzazione, concentrazione e delocalizzazione produttiva. Il lavoro che ci aspetta non è semplice, ma d’altra parte come suggerisce Seneca a Lucilio “A VOLTE NON E’ PERCHE’ LE COSE SIANO DIFFICILI CHE NON SI OSA, MA E’ PERCHE’ NON SI OSA CHE ESSE DIVENTANO DIFFICILI”.
1a PARTE. ANALISI STATISTICO-ECONOMICA SULL’ANDAMENTO DEI PARAMETRI RELATIVI AL FATTORE LAVORO
Complessivamente nei paesi della Comunità Europea la riduzione,
rispetto agli anni ‘60, del tasso di crescita per le singole economie nazionali
unita all’accelerazione delle tendenze inflazionistiche, che già dai primi anni
‘70 hanno caratterizzato tutte le economie industrializzate, hanno avuto come
principale conseguenza uno squilibrio a livello dell’offerta e l’avvio di un
processo di stagnazione e inflazione (stagflazione) che si è accompagnato a
una grave situazione monetaria mondiale. I due shock petroliferi degli anni 1973-74 e 1979-80 hanno
ulteriormente aggravato la situazione provocando, già dal 1973, la fluttuazione
dei cambi dei paesi europei (con esclusione del mercato legato al marco tedesco).
Va rilevato che pur essendo in questi anni ancora abbastanza elevato il tasso
di crescita del PIL (circa il 4% l’anno), l’aumento dell’occupazione non ha
seguito questa tendenza (circa lo 0,3% l’anno) e il tasso di disoccupazione
si è attestato intorno al 2,5%. Dal 1974 in poi, inoltre, il tasso di crescita
è sceso al 2% circa l’anno. Considerando il PIL per abitante, come si vede dal Graf.1,
l’Italia, negli anni ‘70, è sempre all’ultimo posto nell’ambito dei più importanti
paesi europei. [1] Prendendo come riferimento la media del PIL per abitante dei
paesi comunitari l’Italia risulta essere sempre al di sotto, mentre, sempre
per gli anni ‘70, sopra la media europea spiccano la Francia, la Germania, il
Lussemburgo. Negli anni ‘80 complessivamente nei paesi della Comunità Europea
il tasso di disoccupazione è molto cresciuto arrivando nel 1985 a circa l’11%;
gli squilibri della bilancia dei pagamenti provocati dai problemi dell’economia
americana (il dollaro risultava essere molto sopravvalutato in confronto con
le altre monete) hanno fatto sì che gli USA tenessero sempre molto elevati i
tassi di interesse e ricorressero ai mercati internazionali dei capitali. Il
livello dell’inflazione ha raggiunto nel 1989 livelli molto elevati provocando
una politica monetaria molto restrittiva che ha avuto inevitabili conseguenze
negative sulla crescita e sugli investimenti rendendo ancora più marcata la
fase di recessione. [1] “Il Prodotto Interno Lordo ai prezzi di mercato (PILpm) rappresenta il risultato finale dell’attività di produzione delle unità produttrici residenti. Corrisponde al valore aggiunto lordo dell’economia (produzione totale di beni e servizi, meno i consumi intermedi) calcolato ai prezzi di mercato, più l’IVA sulla produzione e le imposte nette sulle importazioni (imposte sulle importazioni al netto dei contributi alle importazioni) . Il PIL è anche calcolato a prezzi costanti per neutralizzare gli aumenti o le diminuzioni provocati dall’incremento o dalla riduzione dei prezzi ed è inoltre convertito dalle monete nazionali nell’unità monetaria europea(ECU) e in standard di potere di acquisto (SPA) al fine di confrontare il prodotto interno lordo dei diversi paesi. La crescita economica reale (in termini di volume) è misurata come l’incremento del prodotto interno lordo a prezzi costanti“. Cfr. Eurostat.
|