Dopo l’analisi-inchiesta sulla modificazione della geografia dello sviluppo in Italia (n.0 di Proteo), quella sulle privatizzazioni in Italia e in Europa (n.1 e 2/98 di Proteo) e quella sulla legge della rappresentanza sindacale (n.1 e 2/98 di Proteo), la nostra rivista si “tuffa” in una nuova, difficile prova. In questo numero di Proteo e nei primi due numeri del 1999 affronteremo un’analisi-inchiesta a carattere macroeconomico per valutare, attraverso alcuni importanti parametri, come si è andato strutturando il processo di accumulazione capitalistica dagli anni ‘70 ai nostri giorni.
La crisi economica che stiamo vivendo è iniziata nel 1968 con la rimessa in causa del Welfare State in occidente; con il 1971, prima della crisi petrolifera, la soppressione della convertibilità del dollaro, e conseguentemente con il rovesciamento di una forma di egemonia americana; con il 1975 e il progetto di un nuovo ordine economico internazionale che i paesi non allineati hanno presentato, e che è stato respinto dai paesi occidentali, aprendo in seguito la crisi del debito del Sud; con l’ingenuo progetto gorbacioviano di perestroika e con la disgregazione, che va dal 1989 al 1991, dell’Europa del Est e lo sfaldamento dell’URSS. Già nel 1970 la crescita economica e di espansione dei mercati era notevolmente rallentata e dal 1980 tutto il mondo è entrato in un periodo di stagnazione.
Dal 1980 ad oggi i maggiori paesi capitalistici si sono preoccupati esclusivamente di gestire la crisi nei due terzi del globo inventando nuovi sbocchi finanziari.
Per evitare la svalutazione del capitale si sono adoperate un insieme di misure come per esempio sul cambio, sui tassi di interesse, le privatizzazioni, la deregulation. La gestione della crisi, fino ad ora usata, ha degli elementi di debolezza: da un lato accentua la dicotomia del sistema Ovest nuovo Est; dall’altro produce effetti sociali all’interno dell’occidente a capitalismo avanzato che rimettono in discussione gli stessi assetti politici innanzitutto. Finanziariamente porta al predominio di un ciclo di accumulazione accresciuto senza passare attraverso alcun intermediario produttivo: non c’è trasformazione del capitale in mezzi di produzione, in produzione effettiva e in realizzazione del surplus da investimento produttivo. Localmente la finanziarizzazione si unisce ad un aggravio enorme della disuguaglianza nella distribuzione interna del profitto, con conseguenza di un arretramento delle stesse forme politiche ed economiche che erano tipiche delle democrazie in occidente.
Oggi il capitale reclama sempre maggiori profitti con la scusa dell’accresciuta competitività internazionale e della globalizzazione. Il pensiero unico neoliberista trasmette nell’intera società la sua cultura di darwinismo economico e sociale, in nome del mercato e degli esclusivi interessi d’impresa. L’attuale situazione economica è caratterizzata da una globalizzazione dell’economia e da una concorrenza molto forte e dura, che è in primo luogo una concorrenza dove ognuno intende aumentare la produttività riducendo però i costi. Oggi sono gli aspetti finanziari a prevalere a tutto il sistema. A essere nel mirino ora sono i salari, i contributi sociali, il sistema sociale nel suo insieme; da parte del capitale viene disdetto lo Stato Sociale come compromesso di classe; prevale una politica neoliberista, cioè una politica di puro mercato. Le esigenze del capitale privato vengono in primo luogo rispettate e la crescita del profitto dell’impresa privata sta al centro delle attività politiche ed economiche. Lo Stato, nelle sue diverse forme e articolazioni, si è fatto Profit State tentando di abbattere anche quelle conquiste minime in termini di “Welfare” ottenute attraverso dure lotte del movimento operaio e dei movimenti sociali che si sono sviluppati in particolare negli anni ‘60 e ‘70.
Nello stesso tempo la percezione soggettiva della crisi dello Stato Sociale, nei gruppi che a vario titolo ne sono investiti, determina drammatici fenomeni di rottura della fiducia nei confronti dei ceti politici dello stesso Stato, un profondo scollamento rispetto alle istituzioni. Da un lato, la paura di perdere quei piccoli privilegi che alcuni gruppi sociali intermedi avevano ormai maturato pensando di appartenere a settori garantiti e attività comunque incluse sotto la protezione dello stato sociale. La privatizzazione del pubblico impiego, dei sevizi pubblici, la stessa aziendalizzazione di funzioni tipiche dello Stato Sociale, come l’istruzione, la sanità, ecc. stanno ovunque generando fenomeni di desocializzazione e di unità, almeno ideale, tra ceti ex intermedi e la massa di coloro nei quali opera l’esclusione definitiva dal circuito lavorativo occupazionale e vedono precario il loro futuro.
La crisi dello Stato Sociale rappresenta la crisi generale della forma politica e statale attraverso cui l’occidente capitalizzato ha sviluppato un certo rapporto tra momento produttivo e momento sociale. La crescente internazionalizzazione prima dei flussi finanziari e poi l’ampliarsi del processo di deindustrializzazione dei paesi occidentali ha fatto sì che le condizioni economiche e le politiche economiche a livello del singolo paese abbiano oggi scarsa influenza nell’incidere su meccanismi di accumulazione sempre più globali. Da questo punto di vista il processo di internazionalizzazione dell’economia mondiale si fonda su una divisione del lavoro che vede i paesi occidentali detenere in modo sempre più concentrato il potere finanziario e tecnologico ed il controllo dei flussi commerciali e i paesi interagenti del terzo mondo oggetto della semplice trasformazione delle merci.
E’ così più semplice globalizzare anche la cultura del “disastro mondiale” se non si accettano le ricette del neoliberismo; la cultura del mercato selvaggio diventa quella della “salvezza dell’umanità” poiché sembra sempre di essere in procinto di un crollo dell’economia internazionale che riporterebbe anche i paesi occidentali a livelli di assoluta povertà. Con questo messaggio si innesca il terrorismo sociale funzionale ai piani di ristrutturazione del capitale e alla ridefinizione per nuove aree di influenza, messaggio fatto proprio anche dai governi di centro-sinistra, da alcuni ex leader di quel che resta ed in forma degenere del socialismo riformista, i quali hanno assunto il capitalismo come utlima possibilità di governo dell’umanità, in modo, come lucidamente suggerisce Milan Kundera, DA POTER RICEVERE UN PÒ D’AVVENIRE IN CAMBIO DEL LORO PASSATO.
Altro che crisi economica! Crisi si, ma tutta sulle spalle dei lavoratori, della gente comune, però con incrementi dell’accumulazione complessiva di capitale mai visti prima! Va ricordato immediatamente che negli ultimi venti anni l’incremento medio della produttività del lavoro (2%) è il risultato di una crescente sostituzione del lavoro con il capitale. Questa situazione aggrava ancora di più il problema della disoccupazione anche perché questa sostituzione tra lavoro e capitale dovuto all’innovazione tecnologica, all’aumento dei ritmi di sfruttamento dei lavoratori, non ha realizzato un aumento dei salari reali ma un notevole e consistente aumento dei profitti reali, poiché non si sono verificate neppure diminuzioni di orario di lavoro a parità di salario, né incrementi occupazionali, né aumenti di spesa per la protezione sociale. Le disuguaglianze di reddito e di condizioni di vita nei diversi paesi, anche quelli a capitalismo avanzato, si sono accentuate a causa di sempre più spietate forme di accumulazione capitalistica da parte dei detentori di potere finanziario e monetario. La vera globalizzazione degli anni ‘90 è stata quella delle operazioni monetarie e finanziarie non certo quella degli scambi di beni e libera circolazione delle persone!
La finanziarizzazione dell’economia, realizzata anche attraverso investimenti finanziari resi possibili grazie al surplus di profitti derivati dalla mancata distribuzione al fattore lavoro degli incrementi di produttività e destinati solo in piccola parte agli investimenti produttivi, la liberalizzazione degli scambi e i vantaggi della libera circolazione delle merci, hanno assicurato ai grandi gruppi industriali oltre che una maggiore scelta nella diversificazione della tecnologia e degli impianti, incrementando i processi di accumulazione del capitale, anche una differenziazione dell’offerta e della clientela.
L’integrazione tra i paesi dell’Unione Europea ha permesso alle grandi imprese di trovare manodopera a basso prezzo all’interno del mercato europeo anche senza dover eccessivamente delocalizzare fuori dall’Europa le loro produzioni. Le differenze esistenti a tutt’oggi tra i vari paesi in merito alle prestazioni sociali (assistenza alle famiglie, le diverse forme di reddito minimo, garantito solo per i livelli assoluti di povertà) ci fanno comprendere ancora più chiaramente che l’Europa monetaria e gli obiettivi del trattato di Maastricht raggiunti con enormi difficoltà, rinvii ed ostacoli vari, non hanno tenuto in alcun conto gli aspetti sociali ed occupazionali.
Se dal punto di vista economico, monetario e finanziario è possibile raggiungere una certa apparente corrispondenza economico-finanziaria tra i vari paesi (anche se a nostro avviso con enormi difficoltà e inasprendo ulteriormente l’attacco alle condizioni di vita dei lavoratori) altra cosa è arrivare ad una omogeneità sugli aspetti sociali che richiedono adeguamenti e cambiamenti reali in ciascun paese; obiettivi non realizzati perché i paesi membri , ed in particolare l’Italia, hanno dovuto trascurare ed affossare problemi fondamentali come quello dell’occupazione e di un coerente piano di sviluppo proprio per arrivare a raggiungere i parametri imposti dall’U.E.
Il prezzo da pagare per “entrare” nell’Europa dei finanzieri è stato comunque troppo alto! Aumento dei ritmi di lavoro, tagli ai salari reali, disoccupazione, lavoro precario, sottopagato, senza diritti, tagli allo stato sociale, aumento della povertà, emarginazione, peggioramento delle condizioni di vita, è il prezzo pagato e ancora da pagare per l’Unione Europea.
L’analisi-inchiesta che inizia con questo numero vuole evidenziare, a partire da una ricerca macroeconomica su dati ufficiali (Eurostat, ISTAT, OCSE, Banca Mondiale, ecc.) quello che sta succedendo nei nuovi assetti dei paesi a capitalismo avanzato, proponendo, in particolare, dei confronti soprattutto fra situazione italiana e quella degli altri paesi europei, con alcuni riferimenti a quella del Giappone e degli Stati Uniti. Nelle tre più importanti aree del capitalismo (quella del dollaro, quella dello yen e la nascente area dell’EURO) verranno analizzati i dati relativi ai fattori del capitale (produttività, investimenti, ammortamenti, tassi di accumulazione, confronti ricavi e profitti) e quelli più direttamente legati al fattore lavoro (occupazione, disoccupazione, orari di lavoro, andamenti salariali, spese sociali più direttamente legate alle politiche del lavoro), fino a cercare di leggere attraverso i dati i processi di internazionalizzazione, concentrazione e delocalizzazione produttiva.
Il lavoro che ci aspetta non è semplice, ma d’altra parte come suggerisce Seneca a Lucilio “A VOLTE NON E’ PERCHE’ LE COSE SIANO DIFFICILI CHE NON SI OSA, MA E’ PERCHE’ NON SI OSA CHE ESSE DIVENTANO DIFFICILI”.
1a PARTE. ANALISI STATISTICO-ECONOMICA SULL’ANDAMENTO DEI PARAMETRI RELATIVI AL FATTORE LAVORO
Complessivamente nei paesi della Comunità Europea la riduzione,
rispetto agli anni ‘60, del tasso di crescita per le singole economie nazionali
unita all’accelerazione delle tendenze inflazionistiche, che già dai primi anni
‘70 hanno caratterizzato tutte le economie industrializzate, hanno avuto come
principale conseguenza uno squilibrio a livello dell’offerta e l’avvio di un
processo di stagnazione e inflazione (stagflazione) che si è accompagnato a
una grave situazione monetaria mondiale. I due shock petroliferi degli anni 1973-74 e 1979-80 hanno
ulteriormente aggravato la situazione provocando, già dal 1973, la fluttuazione
dei cambi dei paesi europei (con esclusione del mercato legato al marco tedesco).
Va rilevato che pur essendo in questi anni ancora abbastanza elevato il tasso
di crescita del PIL (circa il 4% l’anno), l’aumento dell’occupazione non ha
seguito questa tendenza (circa lo 0,3% l’anno) e il tasso di disoccupazione
si è attestato intorno al 2,5%. Dal 1974 in poi, inoltre, il tasso di crescita
è sceso al 2% circa l’anno. Considerando il PIL per abitante, come si vede dal Graf.1,
l’Italia, negli anni ‘70, è sempre all’ultimo posto nell’ambito dei più importanti
paesi europei. [1] Prendendo come riferimento la media del PIL per abitante dei
paesi comunitari l’Italia risulta essere sempre al di sotto, mentre, sempre
per gli anni ‘70, sopra la media europea spiccano la Francia, la Germania, il
Lussemburgo. Negli anni ‘80 complessivamente nei paesi della Comunità Europea
il tasso di disoccupazione è molto cresciuto arrivando nel 1985 a circa l’11%;
gli squilibri della bilancia dei pagamenti provocati dai problemi dell’economia
americana (il dollaro risultava essere molto sopravvalutato in confronto con
le altre monete) hanno fatto sì che gli USA tenessero sempre molto elevati i
tassi di interesse e ricorressero ai mercati internazionali dei capitali. Il
livello dell’inflazione ha raggiunto nel 1989 livelli molto elevati provocando
una politica monetaria molto restrittiva che ha avuto inevitabili conseguenze
negative sulla crescita e sugli investimenti rendendo ancora più marcata la
fase di recessione.----- La situazione descritta ha avuto come conseguenza una riduzione
delle prestazioni salariali in molti paesi europei ed un aumento del tasso di
disoccupazione. Considerando congiuntamente l’andamento della crescita dell’economia
e dell’occupazione si nota (Graf.2) che nel periodo 1970-1992 la minore
differenza si ha negli USA, rispetto all’Europa e al Giappone, ma va considerato
che molta della crescita occupazionale statunitense si è realizzata attraverso
un’alta flessibilità e precarizzazione del lavoro. Dal 1982 (escludendo gli anni 1990-1992) il trend dei salari
unitari (comprensivi dei contributi sociali) si è mantenuto in linea con la
caduta dell’inflazione; l’aumento dei salari reali è stato di oltre l’1% inferiore
alla crescita globale della produttività del lavoro, comportando un aumento
della produttività distribuita al fattore capitale (profitti). Nei paesi europei il differenziale salariale è molto alto in
Irlanda, Spagna, Francia, Lussemburgo, Austria e Regno Unito, mentre è molto
minore in Italia, Belgio, Germania, Olanda, Finlandia e Svezia; in particolare
le minori disuguaglianze fra i salari più bassi si hanno in Belgio ed in Germania.
L’inferiore disparità salariale ai livelli più bassi di retribuzione di questi
ultimi paesi possono essere in parte spiegati dall’omogeneità della loro struttura
economica, con modelli di sviluppo in parte più avanzati e coordinati, oltre
che da ragioni sociali e storiche legate anche al modello di capitalismo, apparentemente
più sociale, che si richiama alla tipologia renano-nipponica. Tale modello infatti
si contrappone al capitalismo selvaggio di tipo anglosassone che comprime maggiormente
le modalità redistribuite al fattore lavoro. Infatti, ad esempio, è opportuno
ricordare che negli anni ‘70 e ‘80 negli USA i salari dei lavoratori maschi
hanno subito un calo di circa il 30%; questo significa che il grado di dispersione
dei salari è stato il prezzo per aumentare l’occupazione, ma si è trattato prevalentemente
con alto livello di atipicità, flessibilità del lavoro e salariale, quindi ad
alto connotato di precarizzazione. Tale modello statunitense, ha inoltre implicato
una diminuzione ancora più marcata delle prestazioni e dei benefici sociali
(pensioni, sanità, assistenza, ecc.). Nel periodo considerato la crescita allarmante della pressione
inflazionistica, causata da una espansione della domanda troppo rapida in rapporto
alla capacità produttiva, le politiche economiche alterate, che hanno portato
ad un sovraccarico di politiche monetarie con la crescita dei tassi di interesse
che ha generato un evidente rallentamento nella creazione dei posti di lavoro
e nella crescita economica, ed ancora le profonde crisi monetarie con i disordini
conseguenti, hanno determinato un particolare impatto negativo sulla crescita
economica di tutti i paesi della Comunità Europea. L’andamento negli anni ‘80 del PIL per abitante nell’ambito
dei maggiori paesi europei (vedi Graf.3) si appiattisce intorno alla
media europea, con l’anomalia al rialzo del Lussemburgo. Considerando l’andamento
della crescita economica e dell’occupazione si nota (Graf.4) che per
il periodo 1970-1992 per i paesi europei la forbice si allarga in maniera impressiona nte. Il quadro macroeconomico degli anni ‘90 per il complesso dei
paesi della Comunità Europea si è caratterizzato oltre che per la crescita molto
debole dei tassi del PIL (nel 1993 è diventato negativo) anche per una deflazione
sempre crescente, accompagnata da una congiuntura mondiale molto instabile con
continui movimenti monetari e finanziari. La tendenza è quella di una insoddisfacente
crescita, che ha anche colpito i livelli occupazionali per tutta la prima metà
degli anni ‘90. Il risultato generale macroeconomico mondiale degli anni ‘90
è stato contemporaneamente caratterizzato da tassi di crescita molto deboli
del Pil, compresi i paesi come il Giappone che hanno svolto una funzione trainante
nei confronti del resto dell’economia mondiale. Una deflazione crescente; una
congiuntura mondiale estremamente instabile, inframmezzata da sussulti monetari
e finanziari. La crescita della disoccupazione di massa, raddoppiata da un allineamento
dei salari, dalla flessibilità del lavoro e dalle condizioni sempre più precarie
del lavoro. L’accentuarsi dell’ineguaglianza tra aree geografico-economiche
e delle diseguaglianze di reddito e di condizioni di vita all’interno di ognuno
dei paesi capitalizzati singolarmente considerato; la marginalizzazione di intere
regioni del globo dal sistema di scambi e una concorrenza internazionale sempre
più intensa, generatrice di seri conflitti commerciali tra le grandi potenze
(Usa, Giappone, Unione europea). Questi elementi devono essere interpretati come l’avvisaglia
della maturità di un grande regime di accumulazione mondiale nuovo, il funzionamento
del quale è sottomesso alle priorità del capitale privato e finanziario altamente
concentrato. Durante gli anni 1990-96 la crescita media del PIL nella Comunità
è stata solo dell’1,5%, questo risultato è molto più basso del tasso medio di
crescita del 3,3% realizzato nella seconda metà degli anni ‘80, ed è inoltre
inferiore del tasso medio di sviluppo del 2% registrato durante gli anni1974-85. La bassa crescita ha colpito fortemente l’andamento dell’occupazione,
infatti si sono persi oltre la metà dei 10 milioni di posti di lavoro creati
durante il periodo di crescita 1986-90. Dopo un periodo di espansione avutosi dalla fine del 1993 al
primo trimestre del 1995, si è avuto un brusco rallentamento caratterizzato
da una recessione particolarmente acuta nei paesi le cui monete sono aumentate
di valore durante il turbinio monetario dei primi mesi del 1995. Nei paesi comunitari
in generale, l’aumento della formazione di capitale (gli investimenti) si è
bloccato e il livello delle esportazioni si è ridotto, sia dentro sia al di
fuori dell’Europa. [2] Lo sviluppo dell’economia americana, la flessione registrata
in alcuni paesi emergenti dell’Asia e dell’America Latina, il ristagno di quella
giapponese hanno condizionato la crescita e il progresso dell’intera economia
mondiale. In Giappone infatti si è registrata nel 1997 una forte riduzione
dei consumi e degli investimenti causando una diminuzione del tasso di crescita
dell’economia che è arrivata ad appena lo 0,9%; anche il 1998 ha confermato
questa tendenza (il PIL è stato nel primo trimestre dell’1,3%). Anche gli Stati Uniti pur ottenendo una crescita media del
3,8% hanno registrato livelli minimi di occupazione; lo stesso dicasi per i
paesi dell’Unione Europea, i quali hanno registrato un incremento di prodotto
del 2,7% accompagnato però da un alto livello di disoccupazione. La liberalizzazione
degli scambi insieme alla deregolamentazione e allo smantellamento della legislazione
a tutela dei salari, ha permesso ai gruppi delle multinazionali di sfruttare
simultaneamente i vantaggi della libera circolazione delle merci e delle forti
disparità tra i paesi, le regioni o i luoghi situati all’interno della stesso
mercato unico europeo. Il grande mercato continentale assicura contemporaneamente
ai gruppi economico-finanziari delle multinazionali una totale libertà di scelta
dei differenti elementi costitutivi di una produzione integrata a livello internazionale,
rispondendo anche alle esigenze delle strategie di differenziazione dell’offerta
e della fedeltà della clientela, esigenze che sono proprie alla concorrenza
oligopolistica. Se si considerano la Tab.1 e il Graf.5 si ha
un immediato confronto fra l’andamento del PIL per il periodo 1988-1994 dei
più importanti paesi europei e il dato complessivo dell’Europa dei 15. E’ importante notare nel Graf.6 l’andamento del PIL
per abitante tra il 1990 e il 1995, che evidenzia come unica grande anomalia,
fortemente al rialzo rispetto al dato medio europeo, quella del Lussemburgo. E’ in questo quadro macroeconomico che viene impressa una brusca
accelerazione al processo di unificazione europea, tutto incentrato su intensi
processi di finanziarizzazione dell’economia, senza alcun riferimento alle dinamiche
politiche e alla salvaguardia delle istanze sociali. L’ingresso del nostro Paese nell’Unione Europea può essere
considerato un momento politico ed economico tra i più difficili ed importanti
che hanno caratterizzato la storia italiana, ma lo stesso vale per gli altri
paesi europei, di questi ultimi anni. I molteplici ed infiniti “sacrifici” che
i cittadini europei, e in particolare la popolazione economicamente più debole,
hanno dovuto sopportare in nome dell’Europa di Maastricht hanno acutizzato e
non certo risolto i già pesanti problemi economici e sociali che hanno contraddistinto
questa fine del millennio. L’architettura di Maastricht è costituita su tre pilastri:
moneta unica, politica estera e di sicurezza comune, lotta alla criminalità.
Originariamente i tre pilastri dovevano crescere insieme. Moneta unica e integrazione
politica dovevano reggersi reciprocamente. A causa del divergere degli interessi
nazionali nel dopo ottantanove, si è preferito affidare alla moneta il compito
di anticipare e stimolare l’unità politica. Risulta sempre più evidente che
il Trattato di Maastricht e un trattato geopolitco soprattutto per quanto riguarda
la Germania nel contesto Unione Europea. L’Europa, infatti, dà via libera alla Germania per la riunificazione
in tempi rapidi, ottenendo come contropartita l’europeizzazione del marco. L’esigenza di stabilizzare il livello di inflazione, i tassi
di interesse, i tassi di cambio, il rapporto fra debito pubblico e PIL e quello
fra deficit rispetto al PIL, hanno imposto in questi ultimi anni adeguamenti
delle politiche economiche di ogni paese membro con il risultato che sono state
adottate misure di tagli alla spesa pubblica, riforme fiscali e tagli occupazionali
di enorme portata con ripercussioni sugli strati più deboli e disagiati della
popolazione. Per raggiungere gli obiettivi iniziali dell’Unione Europea
è fissato che in ogni paese il debito pubblico non deve superare il 60% del
PIL, il deficit pubblico non deve essere superiore al 3% del PIL, l’inflazione
non deve essere maggiore di oltre l’1,5% dell’inflazione media dei tre paesi
con tasso di inflazione più basso ed, infine, i tassi di interesse a lungo termine
non devono superare il 2% della media dei tassi a lunga scadenza dei tre paesi
con inflazione più bassa (cfr. Schema 1). Dai dati emerge chiaramente come la maggior parte dei Paesi
(l’Italia in particolar modo) si siano trovati a dover adeguare ai parametri
comunitari situazioni economiche interne di grande diversità nella rincorsa
alla germanizzazione dell’Europa, mascherata da una auspicata europeizzazione
della superpotenza tedesca: ma attualmente la Germania non è una superpotenza.
L’ex RDT si è rivelata un fardello più che una risorsa per i cittadini tedeschi.
La Germania unita è emersa più grande per popolazione e territorio della vecchia
Repubblica Federale, ma più debole in termini di equilibri politici, struttura
economica, capacità di governare se stessa e di esercitare una paziente influenza
sui suoi vicini. L’economia della Repubblica Federale è cresciuta di neppure
il 7%, i suoi abitanti del 25%; la sua area geografica del 40%; il suo tasso
di disoccupazione del 60%. C’è da tener presente che gli obiettivi originari
della Germania rispetto a quelli di Francia e Italia erano opposti. A Francia
e Italia interessava togliere il marco ai tedeschi, mentre ai tedeschi interessava
germanizzare le politiche economiche e finanziarie dei partner, adeguarle ai
criteri di stabilità su cui hanno costruito il “miracolo” del secondo dopoguerra.
Inoltre, attraverso una calibrata manovra dei tassi di interesse gestita dalla
Bundesbank, intendevano garantirsi un forte flusso di capitali europei verso
la Germania, necessari a riempire la voragine dell’ex RDT. E’ lampante quanto imponenti siano state le politiche di adattamento
per raggiungere i traguardi necessari per l’accesso all’Unione Monetaria (si
veda anche il Graf.7) e si noti il livello dei molto alti tassi di disoccupazione
dell’Europa rispetto agli USA e al Giappone. A questo punto sorgono spontanee delle domande: in che modo
si pensa di raggiungere, attuare e mantenere nel tempo gli obiettivi del Trattato?
L’elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del
tenore e della qualità della vita si possono raggiungere con l’attuazione di
un modello economico che ha aggravato notevolmente i già gravi scompensi sociali
esistenti? Ed ancora: quale scuola di pensiero e quale modello prevarrà? Quello
del neoliberismo selvaggio, che sostiene di ridurre al minimo le normative sociali
che sono di ostacolo alla libera concorrenza o quel liberismo temperato neokeynesiano
impostato su un modello di società basato su di uno Welfare State che considera
ancora le spese sociali necessarie e fondamentali per non minacciare la pace
sociale? “L’obiettivo di raggiungere una posizione finanziaria governativa
stabile nel lungo periodo è stato fissato dalla Comunità a partire dal 1993.....Gli
Stati membri hanno il compito di fare ulteriori passi, negli anni successivi
al 1997, per assicurare un continuo miglioramento nelle loro posizioni di bilancio,
per raggiungere l’obiettivo di portarsi vicini alla stabilità, in brevi tempi,
e addirittura ad un surplus in circostanze normali”, [3] ( si vedano nel Graf.8
i parametri macroeconomici fondamentali per il 1998). I criteri di convergenza dell’Unione monetaria, scritti nel
trattato di Maastricht , hanno come obiettivo principale la stabilità monetaria
e sono frutto di una politica monetarista. Quest’ultima ha come suo obiettivo
centrale il tasso di inflazione e quindi la riduzione dei deficit pubblici dei
diversi paesi. Una tale politica significa disoccupazione di massa e smantellamento
dello stato sociale. Un unione monetaria senza una convergenza sui contenuti
della politica economica monetaria senza che converga sui contenuti della politica
economica non serve, e i criteri di tale convergenza non devono essere solo
criteri monetari; quello che occorre è invece una politica che affronti attivamente
i problemi occupazionali e sociali. Da quanto detto fino ad ora è evidente che dalla firma del
Trattato di Maastricht la disoccupazione è aumentata, la crescita economica
ristagna, lo Stato Sociale è ovunque in crisi. Il tenore di vita è diminuito,
la leggittimizzazione degli Stati, a cominciare dall’Italia è messa in questione
senza che si intraveda l’alba dell’unità politica europea. Sulla scena internazionale,
l’Unione Europea non esiste. Il risanamento dei bilanci pubblico non può prescindere certamente
da parametri socialmente accettabili, ma così nella realtà non è, ed è quello
che cercheremo di verificare e quantificare nel seguito di questa analisi-inchiesta. -----
Tra i diritti fondamentali sanciti dai Trattati U.E. sono reputati
decisivi quello all’occupazione, alla protezione sociale; si tratta dunque di
impegnare gli Stati verso una politica di sviluppo durevole, grazie a strumenti
d’azione, e di solidarietà. E’ interessante ricordare che l’articolo 2 del trattato sull’Unione
Europea recita testualmente: “La Comunità ha il compito di promuovere ...uno sviluppo
armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell’insieme delle comunità,
una crescita sostenibile, ...un elevato livello di occupazione e di protezione
sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita... e la solidarietà
tra gli Stati membri.” Gli obiettivi vengono descritti più minutamente nell’art.3:
“Ai fini enunciati all’art.2, l’azione della Comunità comporta... l’abolizione,
tra gli stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all’entrata
e all’uscita delle merci ...una politica commerciale comune ...una politica comune
nei settori dell’agricoltura e della pesca; una politica comune nel settore
dei trasporti ...una politica nel settore sociale comprendente un Fondo Sociale
Europeo; ...una politica nel settore dell’ambiente ...una politica nel settore della
cooperazione allo sviluppo...”. Tali premesse sono rimaste solo buoni principi in quanto il
processo mondiale di ristrutturazione capitalistica ha provocato anche in Europa
turbolenze e instabilità che hanno determinato, nel conflitto aspro tra
diverse economie capitalistiche, una crescita dell’inflazione e un aumento del
debito pubblico che ha realizzato livelli patologici, a cui si è aggiunta la
turbolenza di precari rapporti monetari. Oggi è il mercato a dettare le regole
e la flessibilità e variabilità del mercato hanno operato una condizione che
ha proposto una modificazione profonda dell’organizzazione del lavoro, della
produzione e quindi dell’occupazione. Tutto questo in un periodo di crescita
rallentata. Il potere di controllo sociale dei lavoratori è stato l’oggetto
di uno scardinamento prodotto dalla ristrutturazione e dalla grande offensiva
politica al cui centro c’è stato l’attacco al costo del lavoro, a tutte le forme
di salario diretto e differito compresa la sua proiezione sullo stato sociale,
attraverso la ristrutturazione del mercato del lavoro. Tutto ciò ha comportato per la nuova borghesia imprenditoriale
una nuova forma di sviluppo capitalistico, che si è evidenziato negli
ultimi venti anni anche attraverso trasformazioni profonde nell’ambito della
società europea, trasformazioni che hanno generato la nascita di nuove esigenze
e bisogni legati ai diversi modi di vita e alla mutata struttura economico-produttiva,
(nel Graf.9 si evidenzia il crollo dell’occupazione agricola e
il continuo aumento nel terziario). E’ importante rilevare che in realtà queste nuove esigenze
restano comunque insoddisfatte e i lavoratori hanno sempre dimostrato ciò in
termini di conflitto contro i processi di ristrutturazione del capitale. Un dato interessante ci viene dall’analisi delle giornate lavorative
perdute per conflitti di lavoro dall’inizio degli anni ’70 fino alla prima metà
degli anni ’90 (Cfr. Schema 2 e i Graf.10 e 11). Risalta immediatamente
che l’Italia, mostra sempre un andamento molto marcato dei valori a conferma
di una forte sensibilità dei lavoratori ai problemi legati alla loro condizione.
[4] Anche la nuova ondata di progresso tecnologico in settori come
l’elettronica, l’informatica e le telecomunicazioni, pur aumentando l’andamento
già in crescita della produttività totale non è stata accompagnata
da una corrispondente crescita dei livelli occupazionali. In effetti
le risorse create non sono state riutilizzate e la relazione tra creazione e
distruzione di lavoro non poteva essere positiva, né sono state create le condizioni
per occupare la crescente forza lavoro e ridurre la disoccupazione. Per comprendere appieno la gravità del problema è sufficiente
pensare al calo drammatico che si è avuto nei primi anni ‘90 nel tasso di
occupazione industriale ed agricolo. Dal 1991 al 1996 l’occupazione nei servizi è
aumentata di circa il 4% mentre nel settore industriale è diminuita del 3% e
nel settore agricolo dell’1%. Nel 1996 risultavano essere occupati nell’industria
il 30% dei lavoratori, nell’agricoltura il 5% ed il restante 65% nel
settore dei servizi. Nel 1996 in Belgio, in Germania e in Grecia il settore
occupazionale più rilevante risulta essere quello dei servizi (con valori
rispettivamente intorno al 75%, al 65% e al 60%); anche in Spagna ed in Francia
ed in Olanda il settore dei servizi impiega il maggior numero di occupati (rispettivamente
circa il 65%, il 70% ed il 70%). Il Regno Unito conferma la tendenza degli altri
stati (gli occupati nei servizi sono circa il 70%). Se è pur vero che l’occupazione nei servizi costituisce la
principale porzione di lavoro nei paesi europei va ricordato che questo settore
si caratterizza per la presenza di una maggiore frequenza di lavoro a tempo
parziale (circa il 20% è rappresentato da lavori ad orario ridotto con una
partecipazione molto elevata di personale femminile) e per una elevata proporzione
di lavoratori autonomi e di piccole e medie imprese (circa il 15% del
lavoro in servizi è svolto da prestatori d’opera, collaboratori domestici, lavoratori
autonomi). La maggiore presenza di occupati nei servizi si accompagna,
quindi, ad una rilevante partecipazione delle donne (circa il 49,4% degli
occupati nei servizi è rappresentata dalle donne a fronte di una quota molto
inferiore, il 28%, impiegata nell’industria). Considerato che, in rapporto all’occupazione totale, la media
europea dell’occupazione dipendente è di circa l’80% a fronte di un valore del
20% di occupazione indipendente, dalla Tab.2 emerge chiaramente che il
Lussemburgo, Regno Unito, Germania, Francia, Danimarca si discostano dalla media
per una elevata presenza di occupazione dipendente (90%circa) rispetto a quella
indipendente; il contrario si registra invece in Italia con valori di occupazione
dipendente del 69% e indipendente del 31%, anche se c’è da considerare che il
nostro Paese si caratterizza per una forte componente di “falso” lavoro autonomo
(si tratta dell’enorme mondo delle “partite IVA” che spesso configurano forme
di lavoro subordinato). E’ interessante rilevare che in Europa la media di occupazione
maschile si attesta intorno al 60%, la Tab.3 mostra chiaramente che l’Italia
è il paese che più si discosta dalla media europea con valori del 65% per l’occupazione
maschile; la Danimarca, al contrario, registra differenze minori tra i due sessi
con valori del 53% (occup. maschile) e del 47 % (occup. femminile); segue subito
dopo il Regno Unito (55% e 45%) e la Francia (56% e 44%). Per quanto riguarda il regime di tempo di lavoro va rilevato
che in Europa l’86% della popolazione lavora a tempo pieno a fronte di un restante
14% impiegato a tempo parziale. In Olanda la percentuale dei lavoratori a tempo
parziale arriva la 35%, in Danimarca al 23% e nel Regno Unito al 24%; mentre
Lussemburgo e Italia si attestano su valori molto bassi (rispettivamente il
7% e il 5% dei lavoratori è occupato a tempo parziale). E’ questo un dato particolarmente interessante: negli ultimi
anni un numero sempre crescente di donne è entrato a far parte del mondo del
lavoro (in Danimarca oltre il 50% della popolazione femminile è economicamente
attiva, in Irlanda oltre il 21%, in Spagna circa il 20%) anche se questi dati
apparentemente positivi ed incoraggianti devono essere valutati attentamente,
poiché la presenza femminile nel mercato del lavoro è avvenuta senza alcuna
specializzazione o con una specializzazione molto bassa, oltre che con salari
inferiori a quelli degli uomini e con forte precarizzazione e flessibilità. Si nota, infatti, nel Graf.12 come in tutti i paesi
europei le donne occupate a tempo parziale riferite al totale delle donne occupate
siano sempre di gran lunga molto più alte delle percentuali maschili. I settori nei quali la presenza femminile è più elevata restano
quelli della sanità, dell’istruzione e dei servizi domestici mentre i lavori
a livello dirigenziale e tecnico restano monopolio della popolazione maschile.
Ad esempio nella Pubblica Amministrazione il 40% della forza lavoro è costituito
da donne, ma solo il 10% di queste riveste funzioni manageriali e non sono quasi
rappresentate a livelli superiori. Per quanto riguarda la retribuzione si ha una differenza di
salario che va dal 15 al 35% e questa differenza si accentua tra le lavoratrici
non manuali (si arriva al 40%) in quanto di solito le donne hanno soprattutto
compiti impiegatizi mentre gli uomini più lavori a carattere dirigenziale. La mancanza di politiche per la qualificazione professionale
delle donne le porta ad essere maggiormente esposte al problema della disoccupazione
e del precariato; infatti ad eccezione della Svezia, del Regno Unito e della
Finlandia in tutti gli altri Paesi dell’Unione Europea il tasso di disoccupazione
femminile è molto più elevato di quello maschile. Inoltre le tendenze verso nuove e moderne possibilità occupazionali
presentano una elevata concentrazione maschile di nuovi posti di lavoro di medio-alto
livello formativo. Infatti negli anni 1994-1996 vi è stata una crescita del
numero dei dirigenti, funzionari e tecnici mentre si è ridotto il numero dei
lavoratori di posizioni di base. Ciò è dovuto soprattutto ai processi di innovazione
tecnologica e alla voluta mancanza di adeguate politiche di formazione, soprattutto
femminile; si pensi tra l’altro che nel 1996 circa il 35% dei disoccupati dei
paesi della Comunità Europea di età superiore ai 25 anni non aveva alcun titolo
di studio superiore all’istruzione di base. I motivi che hanno portato alla situazione odierna sono molteplici:
ci troviamo al termine del ciclo taylorista-fordista-keynesiano caratterizzato
da produzioni che si imponevano sul mercato e quindi permettevano un controllo
sull’economia. Oggi è la divinità del mercato a dominare e la disoccupazione
di massa, strutturale, si innesta in questo meccanismo come espressione di una
scelta politica che consente di controllare i salari e la forza lavoro, provocando
intensi processi di precarizzazione e flessibilità del lavoro e del salario. Il fenomeno della deregolamentazione del rapporto di
lavoro, la parcellizzazione, la flessibilità e la variabilità dell’occupazione,
conseguenza della fase di postfordismo che si sta vivendo, ha portato da un
lato alla nascita di lavori che non permettono di soddisfare a chi li esercita
i principali e basilari bisogni ed esigenze umane (con la conseguenza così di
accrescere il numero di coloro che vivono al di sotto o al limite della soglia
di povertà); dall’altro lato ci si trova di fronte alla nascita sempre più frequente
di microimprese (sino ad arrivare ad imprese individuali gestite da lavoratori
espulsi dal ciclo produttivo) che, oltre a non garantire alcuna stabilità, sono
soggette più di altre al ricatto del grande capitale. L’aspetto che si evidenzia maggiormente è la precarizzazione
del lavoro come elemento costitutivo della nuova divisione del lavoro. Ne
sono un esempio il contratto di prestito delle forze-lavoro, la competizione
mondiale tra i lavoratori, la svalutazione e svalorizzazione del lavoro dipendente
salariato, la perdita di autonomia contrattuale del lavoratore dipendente. A
tale processo si unisce un attacco al salario diretto, indiretto, differito
e sociale; vengono messi in discussione il servizio sanitario nazionale con
violenti processi di privatizzazione, la previdenza sociale, la scuola, l’assistenza
e i servizi pubblici in genere. Negli anni 1975-1995 a fronte di una crescita di occupati
(cioè lavoratori che hanno un qualsiasi tipo di occupazione) negli Stati
Uniti di circa il 45%, in Europa si è avuto un incremento del 12,6% e in Italia
il livello di occupazione nel 1995 è cresciuto di appena 400.000 unità rispetto
a venti anni prima (nel 1997 si è avuto nell’industria in senso stretto un decremento
dello 0,6%). A ciò occorre aggiungere il fatto che la disoccupazione è diversificata
oltre che per categorie di persone anche per l’età e per la collocazione territoriale
(In Italia tra il 1975 e il 1995 si è registrato un alto differenziale del tasso
di disoccupazione tra Nord e Sud). Nello stesso periodo sia in
Europa sia negli USA si è manifestato inoltre un crescente divario tra la cosiddetta
“economia sommersa” e il lavoro “tutelato”; si ha anche uno sfasamento sempre
più marcato tra produzione ed occupazione in quanto se la produzione diminuisce
l’occupazione cala mentre non è vero il contrario: ossia ad un amento della
produzione non si accompagna un pari aumento di occupazione. A conferma di ciò
si ricorda che negli ultimi tre anni la crescita di prodotto nel terziario (nei
servizi vendibili) è stata accompagnata da una notevole perdita di posti di
lavoro, in particolare in Europa complessivamente. Anche l’elasticità nell’andamento della produzione, ossia la
misura del prodotto interno lordo e andamento dell’occupazione che in passato
era in rapporto tre a uno, (cioè ad un incremento pari al 3% del PIL corrispondeva
un aumento dell’1% ) rimasta stabile per diversi anni è ora decrescente. Inoltre, nessun paese dell’Unione Europea è riuscito ad assorbire
l’aumento di offerta di lavoro femminile e giovanile: in Italia il tasso di
disoccupazione femminile è del 16% contro il 13% in Europa e il 5,5% negli USA;
ed ancora in Italia un terzo della disoccupazione totale è rappresentato da
giovani mentre in Europa i giovani senza lavoro sono un quinto e negli USA un
ottavo del totale disoccupati. In questa situazione sono nati e proliferati i contratti atipici
di lavoro quali il contratto di solidarietà, il contratto di formazione lavoro,
i contratti di inserimento e il lavoro interinale, ossia il lavoro in affitto. I vantaggi per le imprese nell’assunzione dei lavoratori temporanei
sono molteplici: oltre alla possibilità di corrispondere salari più bassi motivati
dalla poca esperienza del lavoratore e alla totale assenza di costi di formazione,
che sono di solito a carico dell’agenzia di lavoro interinale, si registra un
aumento della flessibilità e una maggiore fluttuazione della domanda (le imprese
possono svolgere attività legate a determinati periodi dell’anno). Vi è infine
la possibilità di utilizzare dei lavoratori specializzati solo nel momento del
bisogno e ad un costo inferiore. Una stima effettuata per cercare di quantificare il lavoro
sommerso ha rilevato che in Europa nel 1996 il rapporto fra lavoratori sommersi
e lavoratori in regola era di 1 a 4; attraverso il ricorso al lavoro nero in
Europa, sempre nel 1996 si realizza oltre il 23,3% della produzione di beni
e servizi. Va rilevato però che è molto difficile effettuare delle valutazioni
scientifiche e quindi ad alta scientificità su questo tipo di lavoro in quanto
i dati non sono disponibili per tutte le categorie e si rischia inoltre di non
cogliere la reale dimensione del fenomeno; uno studio effettuato recentemente
ha messo in risalto che il lavoro nero produce circa il 26% del PIL in Italia.
Se si guardano i dati relativi al tasso di disoccupazione europea
ci si trova in una situazione paradossale: infatti a fronte di oltre 19 milioni
di disoccupati ufficiali (oltre il 10% della popolazione attiva) a fine 1997,
si hanno circa 13 milioni di disoccupati occulti o “invisibili”. Questa categoria
di “non occupati” comprende i precari, i sottoccupati, le persone che hanno
lavorato solo qualche ora in un mese, oltre ai disoccupati “scoraggiati” che
non si iscrivono neppure più al collocamento. Ciò è dovuto anche al diverso
modo di rilevazione statistica dei disoccupati. Infatti, in alcuni paesi europei,
e anche negli stessi Stati Uniti, il solo fatto di lavorare poche ore a settimana
o in un mese comporta la classificazione di occupati. Si arriva così a oltre
32 milioni di disoccupati nell’Unione Europea e tra questi non vengono contabilizzati
i cosiddetti “lavoratori in nero” di cui difficilmente si può avere un riferimento
quantitativo vicino alla realtà.
Qualche esempio: l’Employment policy institute dopo accurate
indagini effettuate in Gran Bretagna conclude rilevando che il tasso di disoccupazione
dichiarato ufficialmente del 5% è in realtà un dato molto “ottimista” essendo
invece quello reale molto vicino al 15%. In Francia la situazione non è molto
diversa: i dati ufficiali parlano di circa 3,5 milioni di disoccupati, in realtà
i dati effettivi portano il numero di disoccupati a circa 8 milioni. L’istituto
IAB in Germania calcolando le categorie a carico della previdenza sociale segnala
oltre 8 milioni di disoccupati a fronte dei 4,5 milioni di disoccupazione ufficiale.
L’Olanda che registra un tasso ufficiale di disoccupazione del 7,4%; la realtà
però è molto diversa essendo il tasso reale di disoccupazione intorno al 20%.
Anche il nostro Paese si trova in una situazione simile: a fronte di 3 milioni
di disoccupati “ufficiali” si hanno in realtà oltre 7 milioni di disoccupati
“reali” .-----
In sostanza la cifra dei 19 milioni di disoccupati ufficiali
si allontana molto dalla realtà. Considerato che la Germania, la Francia e l’Italia
insieme registrano oltre 12 milioni di disoccupati “invisibili” appare chiaro
come si arrivi per la Comunità Europea ad un numero di gran lunga superiore
ai 32 milioni di persone in cerca di occupazione. Innanzitutto occorre chiarire che per disoccupati si intendono
tutti coloro che sono in cerca di occupazione (ossia sia chi è in cerca di una
prima occupazione sia coloro che hanno perso il precedente posto di lavoro);
secondo la classificazione Eurostat alle quali si attiene l’ISTAT le persone
in cerca di occupazione sono coloro che oltre a non aver svolto ore di lavoro
nella settimana di riferimento dell’indagine sono disponibili immediatamente
a lavorare e hanno condotto una ricerca di lavoro nei 30 giorni precedenti l’intervista;
quindi se la persona interpellata ha svolto un qualsiasi tipo di attività lavorativa
e in qualsiasi modalità, anche precaria, è comunque classificata come occupata. Il tasso di disoccupazione (calcolato dividendo il numero dei
disoccupati per la somma dei disoccupati più gli occupati per 100) complessivo
destagionalizzato complessivo nell’Europa dei 15 è stato valutato nel gennaio
1998 intorno al 10,5%; si vedano i Graf.13 e Graf.14 per un
confronto tra i maggiori paesi europei. Ma già dagli anni ’70 con l’accentuarsi dei processi di mondializzazione
dell’economia e la dura concorrenza tra le imprese (aumento della produttività
riducendo i costi) ha portato i salari ed il sistema sociale nella sua totalità
ad essere sempre più soggetti alle regole ferree del puro mercato e del profitto.
Il fenomeno della disoccupazione, accentuatosi in Europa e nel mondo dopo lo
shock petrolifero dei primi anni ‘70, è cresciuto da allora ad un ritmo
rapidissimo nei periodi di recessione e non è diminuito durante le fasi di espansione
economica (in Europa si è arrivati ad un tasso di disoccupazione sei volte superiore
a quella registrata negli anni ‘60, in Italia 2,5 volte più elevata rispetto
a quegli anni). Va comunque rilevato che la disoccupazione nei paesi dell’Unione
Europea è attualmente uno dei problemi di maggiore drammaticità interessando
circa 19 milioni di disoccupati ufficiali; e circa 32 milioni se si considerano
anche gli “invisibili” alle statistiche ufficiali. Si noti che nell’U.E. negli
ultimi 25 anni l’occupazione totale è aumentata di circa il 9% a fronte di un
aumento del volume di ricchezza prodotta di oltre il 90%. Oltre ad una sempre maggiore precarietà del lavoro, alla diminuzione
dei salari reali si è aggiunto l’attacco sempre più aspro al Welfare, al servizio
sanitario , alla previdenza sociale, alla scuola. Pur in presenza di un elevato
incremento di produttività non si è realizzata di pari passo una diminuzione
del tasso di disoccupazione, come si può osservare dal Graf.15 per i
più importanti paesi europei. L’andamento del tasso di disoccupazione si può schematizzare
in tre fasi: la prima dagli anni 1983-1986 nella quale si registra una crescita
generale del tasso di disoccupazione; la seconda che comprende gli anni che
vanno dal 1986 al 1990 nei quali si è avuta una leggera diminuzione della disoccupazione;
ed infine la terza fase che va dal 1990 ad oggi nella quale si è avuta una nuova
crescita del tasso di disoccupazione. Oggi la disoccupazione è espressione dell’incapacità della
nuova fase di sviluppo capitalistico di perseguire il pieno impiego, è espressione
di una scelta politica e sociale di mantenere la disoccupazione per poter determinante
attraverso questa il controllo delle dinamiche salariali e della forza lavoro.
Il fatto che salario e produttività non siano più collegati tra loro implica
che la distribuzione del reddito a livello nazionale e di conseguenza la domanda
nazionale di consumo non abbiano più rilevanza nel risolvere il processo di
accumulazione. In tale situazione non esiste una modernizzazione del consumo.
Questo modo di produzione capitalistico produce per una popolazione ridotta,
per consumi ridotti e di un certo tipo, mentre stimola la competizione violenta
e assoluta per conquistare spazi di mercato in una condizione in cui queste
nicchie non sono più segnati dall’ascesa e dall’attesa di una crescita ininterrotta
della produzione e dei consumi. La disoccupazione non è frutto di arretratezza, di una scelta
nello sviluppo di un nuovo processo capitalistico. Se si analizzano i dati riguardanti i giovani si assiste ad
un fenomeno analogo a quello del tasso di disoccupazione totale; va rilevato
però che i giovani risultano essere molto più penalizzati rispetto agli adulti
come si evince dal Graf.16. In Francia , in Lussemburgo e in Belgio il tasso di disoccupazione
giovanile (sotto i 25 anni) è il doppio di quello degli adulti; in Olanda, In
Danimarca e in Gran Bretagna i valori sono più elevati di una volta e mezzo,
mentre in Italia i disoccupati sotto i 25 anni sono 2,5 volte più elevati degli
adulti; unica eccezione la Germania nella quale i tassi di disoccupazione totale
e giovanile sono meno distanti. E’ anche estremamente interessante ricordare che i tassi di
disoccupazione variano molto all’interno dei paesi dell’Unione Europea (si passa
dal 3% in Lussemburgo al 22% in Spagna nell’anno 1995). Se si analizzano i dati
disaggregati per realtà regionali la situazione è ancora più allarmante: si
passa dal 4% nelle regioni centrali del Portogallo a percentuali del 32% nelle
regioni del sud della Spagna. Le regioni a bassa disoccupazione sono rimaste
stabili negli ultimi dieci anni ma restano concentrate ad un numero ristretto
di aree geografiche: il sud dell’Olanda, il sud della Germania, il nord dell’Italia
le regioni del nord-est e del nord-ovest della Danimarca, il nord e il centro
del Portogallo. Paesi come la Finlandia e la Francia (in particolare Parigi
e dintorni) che erano sempre state a basso tasso di disoccupazione hanno avuto
un aumento di disoccupati nei primi anni ‘90. Il Graf.17 evidenzia che per l’Europa dei 15 il tasso
di disoccupazione complessivo maschile destagionalizzato è intorno al 9% nel
gennaio 1998; la Spagna presenta un tasso molto superiore alla media ( 15,3%)
mentre la Danimarca e il Lussemburgo si attestano su valori sensibilmente inferiori
(rispettivamente 4,5 e 2,4%). La Francia e l’Italia presentano valori superiori
alla media (rispettivamente 10,7% e 9,2% nell’ottobre 1997). Il Graf.18 mostra che per il complesso dei paesi dell’Europa
dei 15 il tasso di disoccupazione femminile destagionalizzato è del 12,4% (genn.1998);
la Spagna anche in questo caso presenta valori molto alti rispetto alla media
(27,8%) mentre il Lussemburgo registra valori molto inferiori (5,1%). La Francia
e l’Italia mostrano valori superiori alla media ( rispettivamente 14,2% e 16,9%
nel genn.1998), confermandosi come paesi con le più forti contraddizioni in
termini di ricadute economico-sociali relativamente ai processi di ristrutturazione
del capitale che stanno attraversando l’intera Europa. Analizzando i Graff.19, 20 e 21 è evidente come
per l’Europa dei 15 il tasso di disoccupazione giovanile destagionalizzato complessivo
sia molto alto (del 20,3%) nel gennaio 1998 ossia quasi il doppio del tasso
di disoccupazione totale destagionalizzato (che è del 10,4%). Le donne registrano
una differenza con il tasso totale complessivo pari al 9,9%, mentre gli uomini
si attestano al 9,6%. Se si confronta poi il tasso complessivo degli uomini e quello
delle donne al di sotto dei 25 anni si nota che il tasso di disoccupazione maschile
è significativamente inferiore a quello complessivo, confermando che per le
donne la situazione occupazionale nell’intera Europa dei 15 assume ancora percentuali
drammatiche. La Tab.4 analizza il tasso di disoccupazione di lunga
durata (ossia di disoccupati per oltre 12 mesi); dai dati emerge chiaramente
che l’Italia si attesta sempre su valori più alti rispetto agli altri
paesi (nel 1995 il valore è del 63,6%), mentre i paesi con valori più bassi
sono la Danimarca e il Lussemburgo (con valori nel 1995 rispettivamente del
28,1% e del 23,3%). Il Belgio invece si avvicina a valori simili a quelli registrati
nel nostro Paese(62,4% nel 1995). Se si analizza da vicino il nostro Paese si evidenziano
dati di alta drammaticità che minano alle basi la stessa convivenza sociale
e sopravvivenza di larghi strati della popolazione. In Italia siamo di
fronte ad un incremento della produttività fra i più alti degli ultimi anni,
ma la disoccupazione non è stata sostanzialmente toccata e nel mezzogiorno raggiunge
quote devastanti. Per risolvere il problema disoccupazione non serve, dunque,
aumentare la produttività ed il profitto nazionale, anzi è evidente che tale
processo ha portato la società moderna alla crisi occupazionale. Ad esempio
alla fine del 1997 a fronte di 20.126.000 occupati e 2.486.000 disoccupati i
giovani occupati erano 4.743.000 e i disoccupati 1.743.000; in sostanza quindi
i giovani costituivano il 24% degli occupati ed il 61% dei disoccupati. Se si disaggregano ulteriormente i dati emerge chiaramente
che esiste un forte divario territoriale fra i tassi di disoccupazione, in quanto
al Sud c’è una percentuale doppia rispetto al Centro e al Nord d’Italia (a fronte
di una percentuale inferiore al 20% al Nord per giovani in età compresa tra
i 15 e i 24 anni, al Sud la percentuale si aggira intorno al 50% tra i giovani
in età compresa tra i 15 e i 24 anni, ed arriva la 30% nella fascia di età 25-29
anni). Tendenza che si conferma in tutte le ripartizioni con il crescere dell’età,
dal momento che mentre al Nord i tassi di disoccupazione si abbassano dopo i
20 anni (si arriva a circa il 10% nella fascia di età compresa tra i 20 e i
29 anni) e ciò non accade al Centro e soprattutto al Sud tra i giovani in età
compresa tra i 20 e i 30 anni (i tassi rimangono introno al 40% fino ai 29 anni
e superano il 60% tra le giovani donne). Ed ancora: mentre al Nord circa la metà dei giovani ha un lavoro
ed un terzo studia nel Mezzogiorno invece solo il 20% è occupato.
Si deve osservare che nelle regioni del Nord-Est d’Italia si studia meno che
al sud in quanto la struttura produttiva basata sulla piccola e media impresa
garantisce una possibilità maggiore di impiego in lavori manuali; la situazione
è un po’ diversa nel Nord-Ovest in quanto essendo queste regioni caratterizzate
dalla presenza di attività terziarie è richiesto per lavorare un livello di
istruzione medio. L’area comunque nella quale si studia di più è il Centro Italia
che ha un livello di disoccupazione intermedio; in questa regione, caratterizzata
da un’alta presenza di lavoro impiegatizio e burocratico, è richiesto un livello
di istruzione di più alto livello. Se si analizza il tasso di occupazione per
titolo di studio e classe di età emerge chiaramente sempre nel 1997 che l’Italia
risulta essere un paese con livelli di istruzione bassi rispetto agli
altri paesi europei; la percentuale degli occupati in possesso di laurea è di
circa l’11% e i lavoratori con un diploma sono circa il 29%; quasi il 38% degli
occupati ha la licenza media ed il 15% ha una licenza elementare o nessun titolo
di studio. Vi è un dato che merita di essere evidenziato: la maggiore istruzione
delle donne rispetto agli uomini; a fronte di un 10% degli occupati laureati
vi è quasi il 15% di donne laureate sempre della stessa fascia di età. Ed ancora
il 29% dei maschi occupati è in possesso di un diploma di scuola media superiore
contro un 37% di donne. La disoccupazione è accompagnata da uno sfruttamento crescente
dei salariati che restano in attività. L’intensificazione del lavoro porta allo
stress nel lavoro e fuori dal lavoro. Il padronato fa del tempo di lavoro
un elemento essenziale del supersfruttamento dei salari e della ridefinizione
della società a partire dall’impresa. È un processo che ha avuto inizio con l’esplosione della precarietà,
della flessibilità, della deregolamentazione, del supersfruttamento, sotto forme
senza precedenti per i salariati in attività. Anche la riduzione dell’orario di lavoro può essere considerato
uno dei modi per cercare di risolvere il problema dell’occupazione e di redistribuzione
degli incrementi di produttività. Un altro obiettivo centrale della ristrutturazione capitalistica
riguarda l’orario di lavoro, ed in particolare il problema della riduzione dell’orario
di lavoro, che potrebbe essere, nelle condizioni esistenti un contributo importante
per salvaguardare e creare posti di lavoro, puchè regolata da una politica contrattuale
ad alto livello. Ma per far ciò sarebbe necessaria una politica economica alternativa,
che sappia affrontare realmente i problemi occupazionali. Anche la domanda pubblica
deve essere usata per questi obiettivi: deve diventare uno strumento per orientare
gli investimenti verso la creazione di occupazione e il miglioramento della
qualità della vita. Ci vorrebbe una politica che non solo rispetti le esigenze
ecologiche, ma che metta al suo centro la riconversione ecologica e favorisca
la produzione di prodotti socialmente utili. Ciò che avviene invece è la flessibilizzazione
dell’orario di lavoro in funzione dei trend di domanda e dei processi di ristrutturazione
d’impresa e della struttura capitalistica. In tal senso un fattore decisivo nella determinazione dell’orario
di lavoro diventa sempre più l’orario straordinario: è chiaro infatti che una
riduzione dell’orario di lavoro può generare la nascita di nuova occupazione
solo se non vi è un incremento degli straordinari, anzi se il lavoro straordinario
viene fortemente penalizzato. Nei paesi occidentali si sono avute tre fasi fondamentali.
La prima legge che risale al 1833 (Factory Act) stabiliva l’orario massimo di
otto ore giornaliere per lavoratori al di sotto dei 13 anni e 12 ore per quelli
tra i 13 e i 18 anni; legge che ha poi fissato nel 1847 a dieci le ore lavorative
per tutti. Vi è poi la seconda fase che, partendo dagli Stati Uniti si è poi
estesa alla fine dell’800 a tutti i paesi industrializzati, durante la quale
l’orario settimanale è diminuito da 66 a 54 ore per continuare la sua diminuzione
dal 1930 al 1938. Infine vi è la terza fase, avvenuta nel secondo dopoguerra
nella quale l’orario di lavoro si è attestato su 40 ore settimanali da ripartire
in cinque giorni lavorativi. Il Graf.22 mostra che le ore medie settimanali lavorate
nei paesi della Comunità Europea evidenziano una tendenza alla diminuzione (con
l’eccezione del Regno Unito che nel periodo 1987-1991 ha registrato un lieve
aumento). L’Italia e il Lussemburgo evidenziano una tendenza verso la stabilità
dell’orario settimanale, mentre la Francia e il Belgio mostrano valori che segnalano
una leggera diminuzione dell’orario. Danimarca, Olanda e Germania mostrano diminuzioni
dell’orario di lavoro molto più evidenti rispetto agli altri paesi.----- Va rilevato che il numero delle ore di lavoro settimanali registrano
una tendenza alla diminuzione dal 1985; i Graff.23 e 24 mostrano
che questa diminuzione è più evidente nel settore dei servizi; anche in questo
caso fa eccezione il Regno Unito che mostra una tendenza all’aumento delle ore
lavorate in tutti i settori. In Italia fino alla fine dell’ottocento l’orario di
lavoro era di 12 ore al giorno e solo con la legge 692 del 1923 si è stabilito
un orario massimo di otto ore al giorno o di 48 ore settimanali; nel 1997 con
il recepimento della direttiva comunitaria si è stabilito l’orario legale a
40 ore settimanali. Sono in fase di attuazione diversi incentivi alla riduzione
dell’orario di lavoro attraverso la riduzione per le imprese delle aliquote
contributive; la finanziaria del 1998, inoltre ha destinato 800 miliardi di
lire per favorire la riduzione dell’orario di lavoro. In tal modo è evidente
che si continua la politica a favore degli imprenditori e del profitto poiché
non si intaccano né si redistribuiscono gli incentivi di produttività al fattore
lavoro.
Il primo impegno effettivo, almeno ufficiale anche se poi si
è rivelato più teorico che pratico, dell’azione comunitaria nei confronti di
obiettivi di carattere sociale si è avuto con le disposizioni della carta comunitaria
dei diritti fondamentali dei lavoratori, la Carta Sociale del 1989 che cita
: “Ogni lavoratore deve essere retribuito in modo equo” intendendo come giusto
un salario che corrisponda ad almeno il 68% delle retribuzioni medie di ogni
paese. Vengono poi enunciati i diritti basilari dei lavoratori tra i quali il
diritto all’occupazione, alla formazione e i diritti alla protezione sociale,
alla parità professionale tra uomini e donne, alla sanità e alla sicurezza sul
luogo del lavoro. Il modello sociale “europeo” più di carattere renano-nipponico
(basato sul sistema governo-impresa-sindacato) si differenzia dalla soluzione
liberista anglosassone basata sul concetto di “meno welfare e più mercato” ed
è definito in maniera un po’ singolare e non tenendo conto della drammaticità
sociale che attualmente tocca l’intera Europa come “la scelta difficile tra
posti di lavoro ed eguaglianza sociale, fra efficienza ed equità”. Ma anche il modello sociale giapponese e tedesco registra notevoli
problemi e differenze sociali, come ad esempio quelle di salario tra i lavoratori
impiegati nelle piccole e medie imprese e quelli delle grandi imprese, la scarsa
protezione dei ceti sociali più deboli a conferma dei limiti di un sistema sociale
poco favorevole ed efficiente. Tale modello, poi, quando imposto a realtà socio-produttive
completamente diversificate provoca effetti perversi, dirompenti che si coniugano
o meglio vengono resi esplosivi dalle dinamiche di ristrutturazione interna
del capitale di ogni singolo paese. Nel Graf.25, ad esempio, si può osservare come
l’Italia sia seconda solo all’Olanda come più basso incremento della spesa pro
capite per la protezione sociale fra il 1990 e il 1995. La Tab.5 mostra chiaramente che il paese che impiega
meno risorse economiche per la protezione sociale (in % del PIL) è la Grecia
che nell’arco degli anni 1985-1994 non ha mai superato il 16,1%; anche il Portogallo
si attesta su valori bassi ma va rilevato che presenta una tendenza alla crescita
(nel 1985 il valore era del 14,1%, nel 1994 è arrivato al 19,5%). L’Italia oscilla
intorno a valori del 25% mentre la Danimarca e l’Olanda sono i paesi che impiegato
le maggiori risorse per la spesa sociale (rispettivamente nel 1994 il 33,7%
ed il 32,3%). Va ricordato che i dati sulle protezioni sociali per i Paesi
dell’U.E. sono comparabili fra loro in quanto le metodologie adottate sono
molto simili fra i vari Stati. Il Graf.26 mostra che la tendenza
dell’impiego di risorse economiche verso le prestazioni di protezione sociale
è in aumento in tutti i Paesi della Comunità; il Lussemburgo registra un valore
molto alto (nel 1994 è pari a 166) mentre l’Olanda il minore (sempre nel 1994
è pari a 116); l’Italia è in media rispetto agli altri paesi della Comunità
(nel 1994 è pari a 143). I dati riguardanti l’anno 1995 confermano il fatto che l’Italia
risulta essere tra i paesi che destinano quote minori di reddito alla protezione
sociale seguita solo dall’Irlanda, la Grecia e il Portogallo (questo paese però,
pur trovandosi in una situazione molto critica dal punto di vista economico,
sta aumentando in modo considerevole le risorse da destinare alla spesa sociale
in quanto il valore degli interventi sul mercato del lavoro è più che raddoppiato
negli ultimi dieci anni. Il Regno Unito si attesta nel 1995 su valori intorno
al 25%, mentre la Francia e i paesi scandinavi si attestano intorno al 30% del
PIL. Per quanto riguarda la spesa sanitaria totale (spesa per assistenza
sanitaria e altre spese del settore quali amministrazione, investimenti, ecc.)
la Francia è il paese che assegna la quota più elevata del PIL alla spesa sanitaria
totale (il 9,6% nel 1996). La Germania e l’Italia invece dopo una fase di maggiore
accrescimento (l’Italia è arrivata a valori dell’8,6% nel 1993 e la Germania
a valori del 9,3% nel 1992) si sono attestate su valori molto più bassi rispetto
alla Francia (rispettivamente il 7,5% per la Germania e il 7,6% per l’Italia
nel 1996). L’Austria e i Paesi Bassi superano la media europea (che è del 7,62%)
con valori pari all’8,2% nel 1996 per l’Austria e pari all’8,8% per i Paesi
Bassi nel 1995. La Grecia e la Danimarca invece presentano valori inferiori
alla media (rispettivamente nel 1996 il 5,9% e il 6,4%). A conferma della mancanza di una corretta e coerente politica
sociale che colloca l’Italia come fanalino di coda rispetto a paesi come Francia,
Germania, Regno Unito per non parlare dei paesi del Nord Europa, basta considerare
che nel nostro Paese le tre maggiori voci della sicurezza sociale, la previdenza
(pensioni), l’assistenza (famiglia, lavoro, servizi sociali) e la sanità (ospedali,
assistenza sanitaria) hanno rappresentato nel 1997 il 24% del PIL (valori a
prezzi correnti); valore che risulta essere in termini assoluti il più basso
almeno dal 1990 ad oggi e che evidenzia la tendenza alla forte compressione. A ciò si aggiunge che, a differenza di altri paesi dell’Unione
Europea in Italia non è previsto alcun sistema diretto alla disoccupazione e
all’inserimento al lavoro di “reddito sociale garantito” per chi non
ha lavoro e vive in condizioni di estrema povertà, non potendo essere annoverato
tra queste forme di sussidio il cosiddetto “Minimo vitale” attualmente in via
di sperimentazione. Nel nostro Paese tra i cosiddetti “ammortizzatori sociali”
stabiliti per tutelare la sospensione del rapporto di lavoro, il licenziamento
collettivo od individuale, è previsto il sussidio ordinario di disoccupazione
dovuto ai lavoratori licenziati (non iscritti alle liste di mobilità) che abbiano
operato nei due anni precedenti il licenziamento per almeno un anno e che possiedano
almeno due anni di anzianità contributiva. Il valore di questo sussidio corrisponde
oggi a circa il 30% dell’ultimo salario percepito, ha una durata massima di
sei mesi per i lavoratori licenziati e di tre mesi per i lavoratori al nero
o che abbiano lasciato il lavoro di propria volontà. La legge Finanziaria del 1996 ha stabilito delle misure di
sostegno per i lavoratori in alcuni settori soggetti a privatizzazione (banche,
trasporto pubblico) demandando alla contrattazione collettiva la definizione
dei criteri di assegnazione di questi sussidi. Si tratta comunque di tipologie
di sostegno ai disoccupati legate a situazioni specifiche e non possono essere
quindi in alcun modo confrontate con quelle esistenti negli altri Paesi europei.
Si rileva nel nostro Paese, in sostanza, la totale mancanza di assistenza finale
oltre il primo intervento per la perdita del lavoro (ed anche per questo “primo
intervento” i tassi medi di copertura sono molto bassi e non omogenei tra i
vari settori). I risultati di un’inchiesta svolta tra i paesi dell’U.E. dalla
OECD Employment Outlook nel 1996, rilevano che in Italia (includendo la Cassa
Integrazione Guadagni e il prepensionamento) circa l’80% dei disoccupati non
riceve alcuna forma di sussidio economico. E’ interessante osservare
che la Spagna, paese con il maggiore tasso di disoccupazione giovanile all’interno
della Comunità Europea, presenta sussidi alla disoccupazione complessivamente
tre volte superiori a quelli del nostro Paese. La discriminazione esistente tra i lavoratori delle grandi
imprese industriali (che hanno garantito l’accesso ai sussidi ) rispetto agli
altri lavoratori è evidente se si pensa che nel 1996 in Italia circa 100.000
lavoratori risultavano essere in Cassa Integrazione straordinaria a zero ore,
300.000 erano in liste di mobilità e vi erano circa 6 milioni di iscritti al
collocamento. Nel 1996 gli interventi sul mercato del lavoro hanno rappresentato
per il nostro Paese l’1,8% circa del PIL, a fronte del 3,8% della Germania,
del 3,3% della Francia, del 3.6% della Spagna e del 2,2% del Regno Unito. Sempre
in Italia nel 1997 si sono ridotte le spese per gli ammortizzatori sociali :
rispettivamente del 4,6% per l’indennità ordinaria di disoccupazione e del 2,5%
per la Cassa Integrazione Guadagni. Anche per quanto riguarda gli oneri sociali
si è accentuata in questi ultimi anni la quota a carico dei lavoratori per il
finanziamento della sicurezza sociale. Le prestazioni sociali a favore delle famiglie disagiate per
consentire loro di far fronte a determinati eventi associati alla malattia,
alla vecchiaia, alla maternità, all’invalidità, alla disoccupazione ecc. rappresentano
quindi un elemento fondamentale nella politica economica ed è importante analizzare
e confrontare l’atteggiamento dei diversi paesi. Va rilevato che anche se l’Europa spende una quota superiore
al Giappone e agli Stati Uniti per la sicurezza sociale, vi sono al suo interno
differenze sostanziali tra i vari Paesi. Mentre fino al 1991 la quota dei contributi
sociali è pressoché costante nei paesi dell’UE (ad eccezione del Regno Unito
nel quale sono decrescenti), si nota un aumento dei valori fino al 1994, anno
in cui la tendenza cambia e si registra una notevole flessione. Lo stesso andamento
si rileva per le spese inerenti le prestazioni di protezione sociale e le spese
sanitarie (dal 1995 in poi si registra una notevole riduzione di queste prestazioni
in tutti i paesi dell’U.E.). Per quanto riguarda gli assegni familiari i dati testimoniano
che paesi come il Lussemburgo, la Finlandia, Il Belgio contribuiscono maggiormente
nelle indennità; invece tra i paesi che contribuiscono in misura inferiore troviamo
la Spagna, la Grecia, Il Portogallo. Ad esempio il valore degli assegni familiari segue una tendenza
che cresce fino al 1993 per poi diminuire nel 1994; l’Italia con l’Olanda è
tra i paesi che registra quote di spesa più bassa fra i paesi dell’UE. Per la
spesa sanitaria si registrano i valori più bassi dell’area comunitaria europea
in Grecia ed in Irlanda mentre le quote più alte sono da imputarsi alla Francia
e la Germania; l’Italia che ha evidenziato valori crescenti dal 1986 al 1994
ha registrato nel 1995 e 1996 una consistente diminuzione (si passa da una percentuale
dell’8,4% nel 1994 al 7,6% nel 1996). Nella Tab.6, il Graf. 27 e il Graf.28 sono
rappresentati gli andamenti dell’ammontare delle prestazioni sociali a favore
dei disoccupati che evidenziano differenze sostanziali tra i vari paesi; ad
esempio in Italia e nel Regno Unito si è avuta nel periodo 1984-1989 una diminuzione
elevata delle spese sociali (per l’Italia del 40% e per il Regno Unito del 60%),
in altri paesi come la Francia si registra una tendenza all’aumento. Se poi
ci si sofferma ad analizzare la spesa a favore dei disoccupati in termini di
percentuale del PIL (prendendo come esempio i dati dell’anno 1992) ci si accorge
che l’Italia risulta essere il paese che ha speso meno dell’0,5% del PIL per
le prestazioni sociali a favore dei disoccupati, anche se il tasso di disoccupazione
è stato superiore alla media europea. La Danimarca, l’Olanda e il Belgio invece
sono i paesi che hanno impiegato la percentuale più elevata del PIL per la disoccupazione
(rispettivamente il 3,7%, il 2,7% e il 2,6%). 7. Le politiche salariali I paesi dell’Unione Europea affrontano in modo diverso le dinamiche
legate all’andamento salariale: in Germania la presenza dei sindacati e dei
Consigli di fabbrica porta a contrattazioni tendenti a ridurre differenze salariali
tra i vari settori ma anche al rinnovo annuale dei contratti essendo vietata
qualsiasi forma di indicizzazione. In Francia le leggi impongono agli imprenditori la contrattazione
annuale dei salari effettivi, dell’organizzazione e degli orari di lavoro, mentre
nel Regno Unito sono state emanate leggi che tendono ad eliminare dal mercato
qualsiasi tipo di influenza e soprattutto il peso dei sindacati, demandando
tutto alla “divinità e saggezza” del mercato. La Svezia invece si contraddistingue per il fatto che la dinamica
dei salari è legata alla produttività settoriale attraverso anche forme concertative
autoregolamentate dai sindacati. Il Graf.29 analizza le retribuzioni orarie medie lorde
(si intendono retribuzioni lorde le remunerazioni a carico del datore di lavoro
prima della detrazione delle imposte, le ammende e i contributi di previdenza
sociale a carico dei lavoratori) degli operai nell’industria; va ricordato che
per operai si intendono i lavoratori manuali legati all’impresa da un contratto
di lavoro (sono esclusi i capisquadra, i lavoratori a domicilio, i coadiuvanti
familiari e gli apprendisti). Il grafico mostra una generale tendenza alla crescita
di salari reali nei vari paesi in particolare in Germania e in Lussemburgo,
ma come si vedrà nel prossimo numero di PROTEO, in tutti i paesi tale crescita
non ha mai realizzato una pari ed equa redistribuzione al lavoro degli incrementi
di produttività, sia totale ma anche del solo lavoro, realizzata nello stesso
periodo. In Italia, nel dopoguerra si è avuta una fase di contrattazione
centralizzata che definiva le differenziazioni e i livelli salariali e si deve
arrivare agli anni ‘70 (periodo di grande conflittualità sociale) per avere
una regolamentazione dell’orario di lavoro, delle assunzioni e dei licenziamenti.
La crisi economica che ha investito il nostro Paese dalla metà degli anni ‘70
alla fine degli anni ‘80, ha portato a gestire di nuovo a livello centrale il
sistema di contrattazione. Lo sviluppo della concertazione triangolare (sindacato,
impresa, governo) ha portato alla nascita della cosiddetta “politica dei redditi”.
Nel 1993 l’accordo sul lavoro ha eliminato i meccanismi automatici di adeguamento
dei salari all’inflazione (la cosiddetta scala mobile) e ha stabilito la determinazione
degli aumenti salariali nazionali e la non specificità o sovrapposizione dei
livelli contrattuali per consentire che i livelli di contrattazione (nazionali
per categoria e aziendali) siano coordinati e complementari l’uno all’altro.
Questa politica ha evidenziato la necessità di fissare più chiaramente la redistribuzione
di riferimento, ossia la parte di salario reale che dovrebbe essere salvaguardata
dall’inflazione.----- In Italia i salari lordi, valutati al netto dei contributi
a carico dei lavoratori e delle imposte, pur essendo aumentati di circa l’1%
nel 1997 risultano essere ancora inferiori a quelli del 1991. Infatti dal 1992
tutto il settore privato e pubblico registra una diminuzione della retribuzione
reale media per unità di lavoro (nella Pubblica Amministrazione i salari reali
sono diminuiti di circa il 10% tra il 1991 e il 1995, mentre nel settore privato
la retribuzione reale era il 99% di quella del 1991. L’andamento dei salari
nominali e l’incremento dei guadagni di produttività (il 5.6% nel 1994 e
il 7% nel 1995) hanno provocato una riduzione del costo del lavoro per unità
di prodotto pari al 3,3% nel 1994 e dello 0,7% nel 1995; il costo del lavoro
per unità di prodotto nell’industria in senso stretto è stato inferiore nel
1995 a quello del 19927. Tale indice (costo del lavoro diviso valore
aggiunto) ha avuto un calo del 10% circa negli anni 1982-1988 per la maggior
parte dei paesi occidentali, con l’unica eccezione della Germania nella quale
la diminuzione è stata della metà. Negli anni ‘90 le aziende maggiori hanno avuto un aumento della
produttività ed hanno adottato una dinamica retributiva più sostenuta
a conferma del fatto che i risultati aziendali, la produttività e il potere
contrattuale della forza lavoro determinano lo slittamento salariale. Infatti
nei settori più avanzati tecnologicamente e maggiormente protetti dalla concorrenza
internazionale i salari risultano essere più elevati se confrontati con quelli
adottati nei settori maggiormente condizionati dalla concorrenza estera e più
tradizionali.
8. Un confronto tra i paesi europei
Per completare questa Prima Parte dell’analisi-inchiesta verranno
presentate alcune figure che immediatamente possono evidenziare per i maggiori
paesi europei il confronto fra i parametri che abbiamo analizzato nelle pagine
precedenti (orario di lavoro, retribuzioni, tasso di disoccupazione e rapporto
spesa sociale per la disoccupazione su PIL); è ovvio che in ogni figura gli
andamenti delle variabili riferite a scale di misura fra loro differenti non
sono comparabili. La Fig.1 mette a confronto per la Germania l’andamento
degli orari di lavoro, delle retribuzioni, del tasso di disoccupazione e delle
Spese sociali per la disoccupazione nell’arco di tempo che va dal 1983 al 1993.
Emerge chiaramente che a fronte di una tendenza ad una lieve diminuzione dell’orario
di lavoro si ha un aumento delle retribuzioni di circa il 20% in dieci anni;
anche il tasso di disoccupazione diminuisce nel corso degli anni raggiungendo
il valore minimo nel 1991, fino a quasi il 4%, riprende poi a salire fino ad
attestarsi nel 1993 al 6%. Per quanto riguarda le spese sociali per i disoccupati
in rapporto al PIL si registra una diminuzione negli anni (il valore minimo
si è avuto nel 1991). Lo stesso confronto è stato effettuato per la Francia (vedi
Fig.2); si nota subito una certa stabilità nell’orario di lavoro mentre
per quanto riguarda le retribuzioni i dati disponibili (fino al 1987) non permettono
di effettuare una analisi completa (si registra comunque dal 1983 al 1987 una
crescita abbastanza contenuta). Il tasso di disoccupazione cresce notevolmente
negli anni esaminati arrivando all’11,7% nel 1993, anche le spese sociali per
i disoccupati registrano un leggero aumento. Per quanto riguarda l’Italia (vedi Fig.3) il
confronto è stato fatto solo tra l’orario di lavoro, il tasso di disoccupazione
e le spese sociali per i disoccupati non essendo stato possibile avere i dati
riguardanti le retribuzioni. A fronte di una tendenza alla stabilità registrata
nell’orario di lavoro (nel 1993 le ore settimanali dei lavoratori dipendenti
si sono attestate sul valore di 37,8) si nota un aumento del tasso di disoccupazione
(nel 1993 si arriva al 10,3%) non accompagnato da un incremento delle spese
sociali che si mantengono su valori estremamente bassi (nel 1991 lo 0,39% del
PIL). L’Olanda (vedi Fig.4) mostra un andamento dell’orario
di lavoro decrescente nel periodo 1983-1984 per poi stabilizzarsi intorno alle
32 ore negli anni seguenti; le retribuzioni crescono anche se in modo molto
lento mentre il tasso di disoccupazione diminuisce (nel 1993 è introno al 7%).
Le spese sociali per i disoccupati hanno raggiunto il valore massimo nel 1984
(circa il 4%) per poi scendere negli anni seguenti intorno al 2,6%. Si configura
quindi una politica occupazionale fortemente caratterizzata dal part-time, da
lavori precari che abbassano solo apparentemente la disoccupazione, diminuendo
invece le forme di Welfare State e di protezione in genere per i disoccupati. Anche il Belgio (vedi Fig.5) mostra una certa stabilità
nell’orario di lavoro (intorno a 35 ore settimanali) a fronte di una tendenza
all’aumento lieve delle retribuzioni (i cui valori massimi sono nel 1993). Il
tasso di disoccupazione è in diminuzione attestandosi intorno al 9% nel 1993,
mentre la spesa sociale per i disoccupati si riduce (l’anno che registra i valori
minori è il 1989).1. Tendenze macroeconomiche degli anni ‘70 ,’80 e ‘90 nell’area europea,
statunitense e giapponese
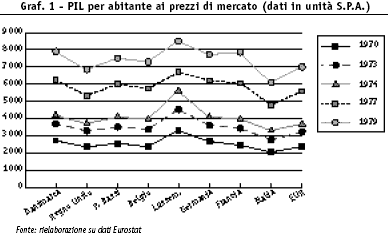
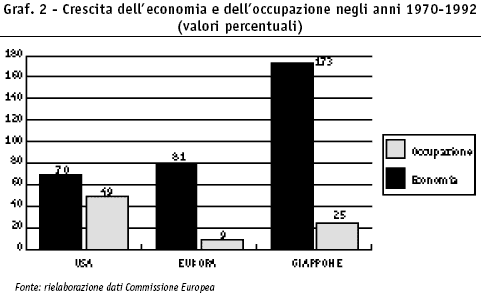
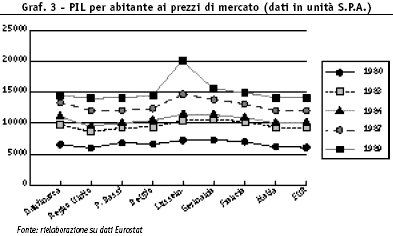
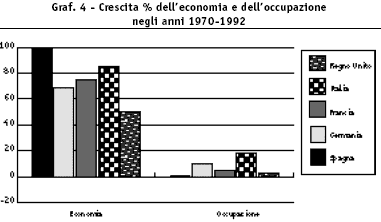
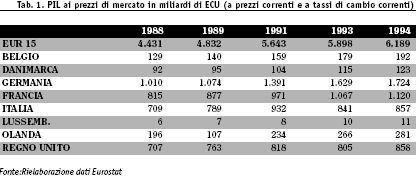
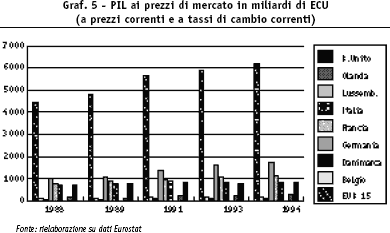
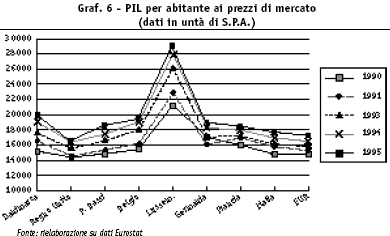
2. Il quadro macroeconomico dell’Europa di Maastricht
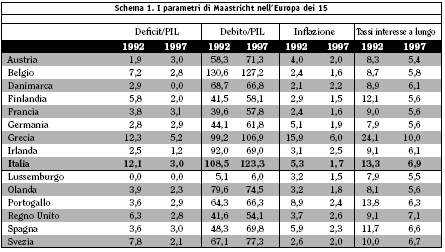
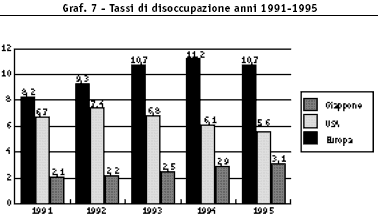
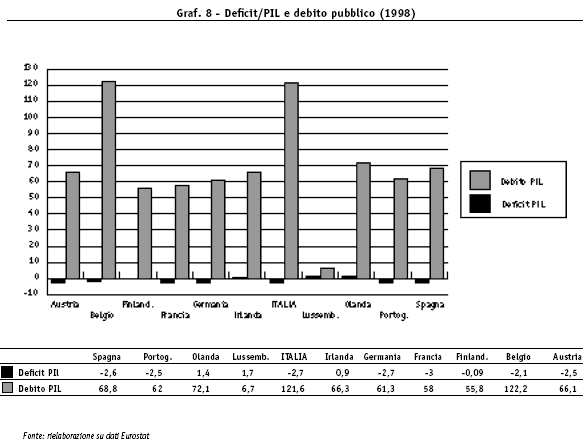
3.L’occupazione
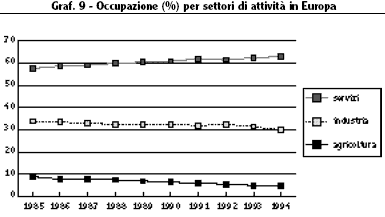
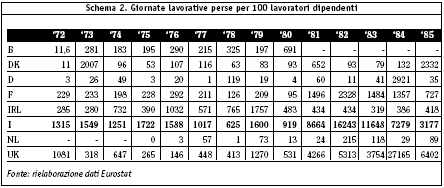
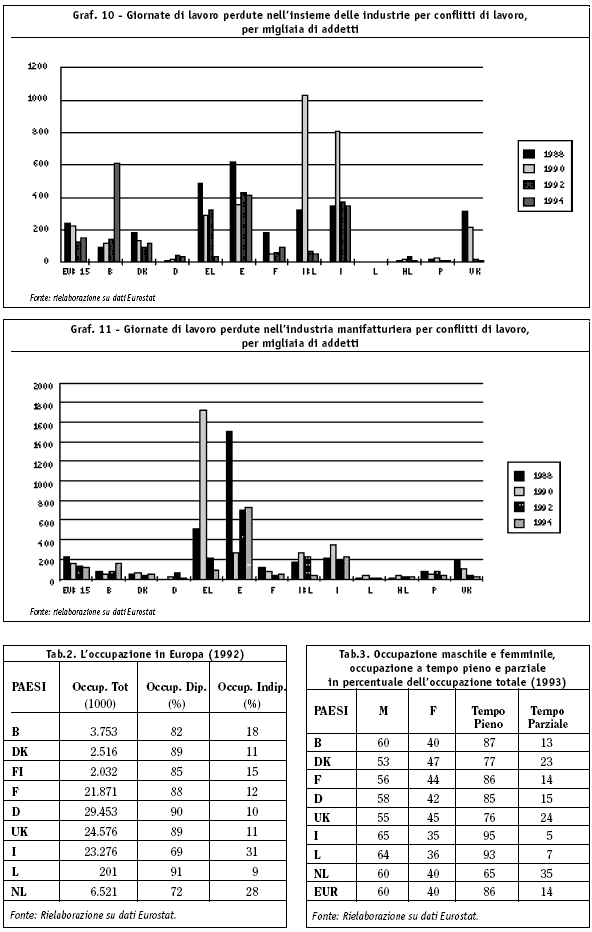
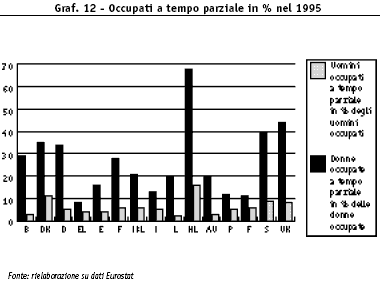
4. La disoccupazione
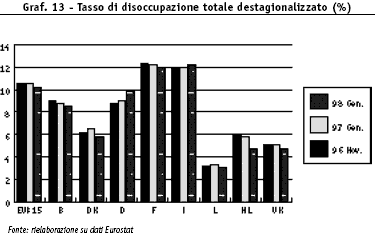
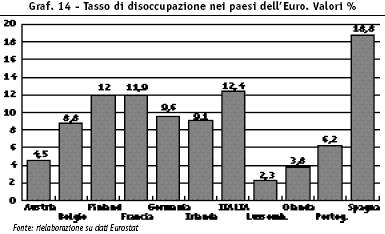
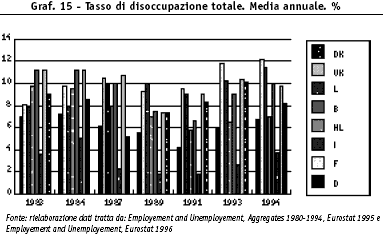
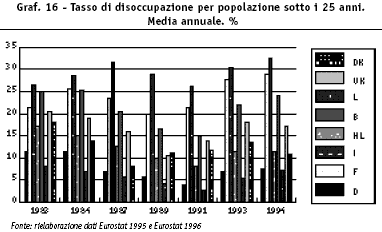
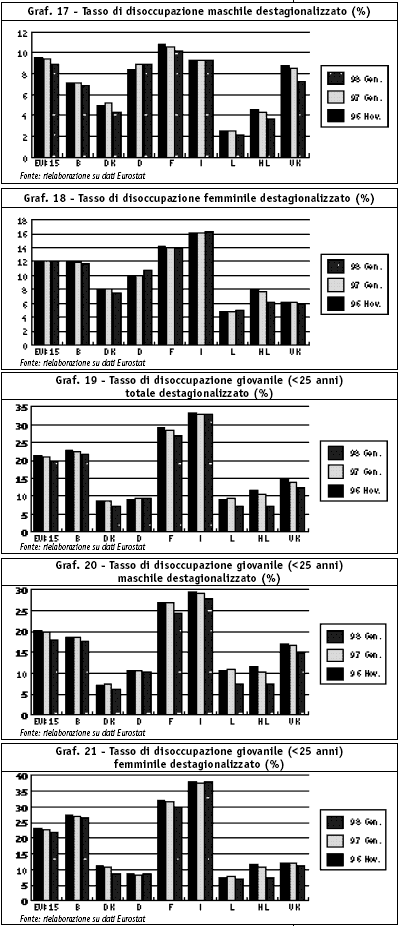
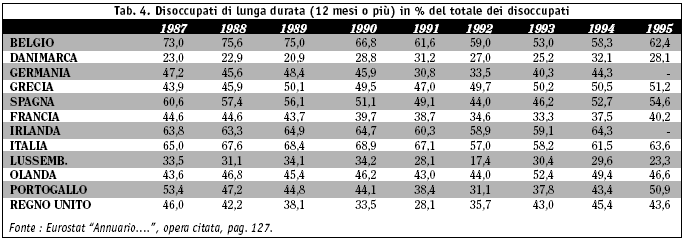
5. L’orario di lavoro
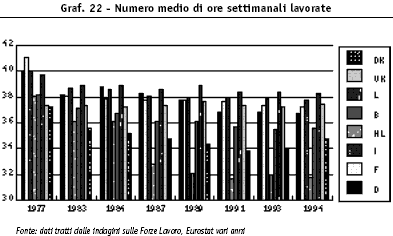
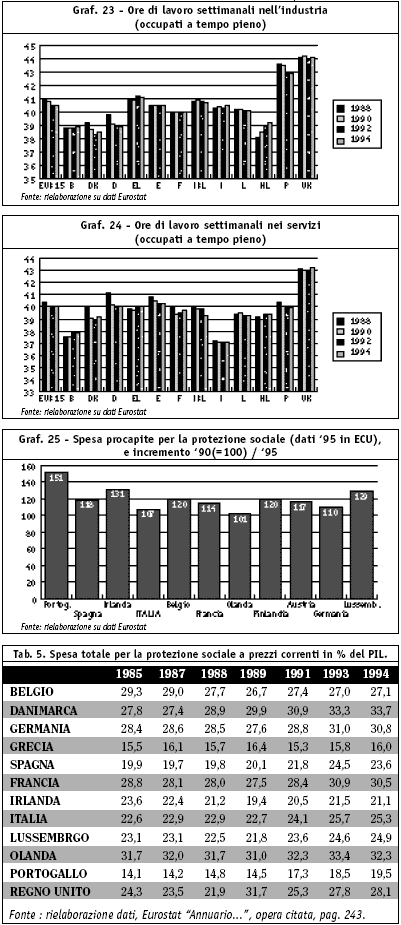
6. Prestazioni Sociali per le politiche del lavoro
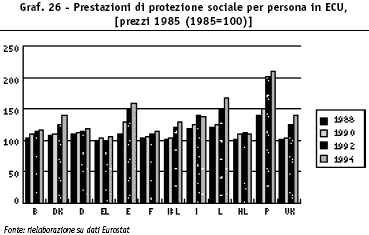
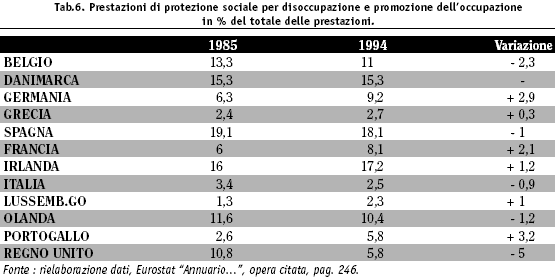
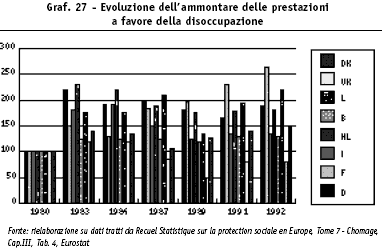
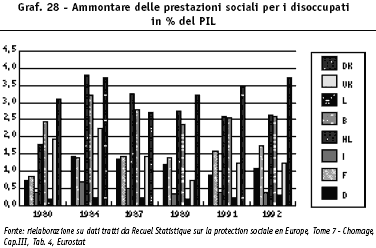
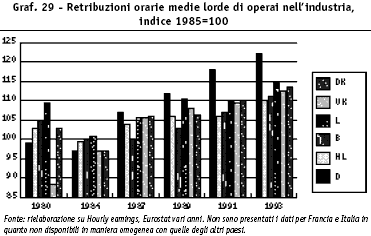
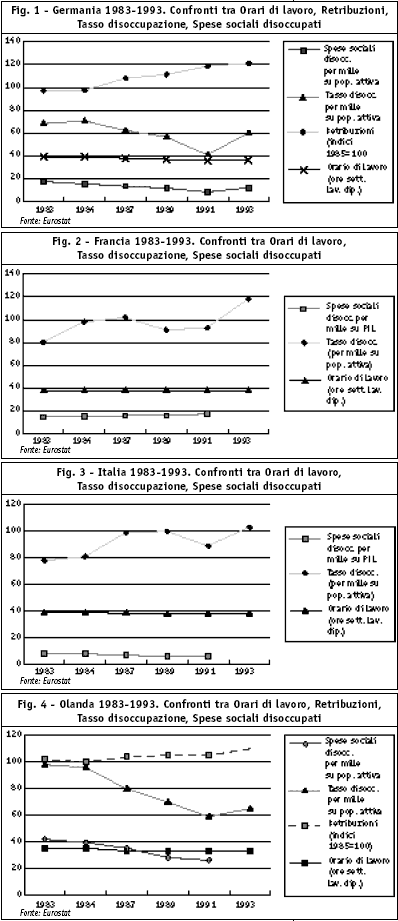
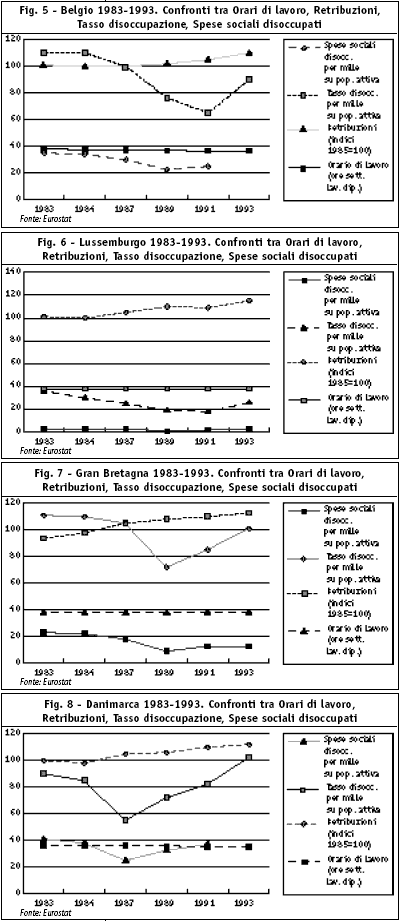
Il Lussemburgo (vedi Fig.6) registra una stabilità nell’orario
di lavoro accompagnata da un leggero aumento delle retribuzioni. Va rilevato
che la propensione alla diminuzione del tasso di disoccupazione, che ha avuto
il suo valore minore nel 1991 (1,7%) ha mostrato una leggera inversione di tendenza
nel 1993 anno in cui si è avuto un aumento (2,7%), mentre le spese per prestazioni
sociali per la disoccupazione in rapporto al PIL si mantengono costanti a livelli
bassissimi. La Gran Bretagna (vedi Fig.7) registra una stabilità
nell’orario di lavoro (i valori sono intorno alle 37 ore settimanali) ed un
leggero aumento delle retribuzioni. Il tasso di disoccupazione ha un andamento
fluttuante in quanto si riduce al massimo nel 1989 raggiungendo il 7% per poi
aumentare di nuovo gli anni seguenti ed arrivare al 10,4% nel 1993. Le spese
sociali per i disoccupati sono molto limitate e mostrano una tendenza alla diminuzione
(nel 1989 arrivano ad appena lo 0,85%) attestandosi poi intorno all’1,3%. La Danimarca, (vedi Fig.8), ha un andamento abbastanza
stabile dell’orario di lavoro (i valori sono intorno alle 34 ore settimanali);
le retribuzioni mostrano un andamento lentamente crescente mentre il tasso di
disoccupazione ha registrato il suo valore minimo nel 1987 (5,4%) ed è risalito
poi negli anni seguenti (nel 1993 il valore è stato del 10,1%). Per quanto riguarda
le spese sociali i dati mostrano una tendenza alla stabilità registrando valori
intorno al 3%. Si riportano, infine, i dati riepilogativi al 1996 dei paesi
precedentemente esaminati, potendo così confrontare l’andamento di alcuni parametri
macroeconomici tra i singoli paesi e il dato complessivo dell’Europa dei 15. Come si può osservare dalla Fig.9 la crescita del PIL
del 1996 in tutti i paesi europei è molto contenuta, tanto è vero che il dato
complessivo dell’Europa dei 15 segna una crescita annua dell’1,6% nettamente
inferiore a quella degli Stati Uniti (2,4%) e del Giappone (3,6%). A fronte
di tali livelli di crescita i dati della disoccupazione ufficiale, sempre per
il 1996, evidenziano per l’Europa dei 15 oltre 18 milioni di disoccupati contro
gli oltre 7 milioni degli Stati Uniti e i 2.259.000 del Giappone, con rispettivamente
un tasso di disoccupazione del 10,9% per l’Europa dei 15, il 5,4% per gli USA
e il 3,4% per il Giappone (si ricorda che nelle rilevazioni USA e giapponesi
qualsiasi forma di occupazione anche a pochissime ore di lavoro mensili fa si
che il lavoratore sia considerato un occupato). Anche tutti gli altri parametri
macroeconomici presenti nella Figura 9 rispecchiano l’andamento dei primi anni
‘90 già presentato precedentemente con, in generale tassi di disoccupazione
maschile e femminile che aumentano fortemente in tutti i paesi europei e retribuzioni
dirette e indirette (in termini salariali e di prestazioni sociali), che si
incrementano in modo assai lento senza assolutamente rispondere ad una equa
redistribuzione ai fattori produttivi capitale e lavoro degli incrementi di
prodotto e di produttività, segnando, infatti, una forte carenza redistributiva
verso le forme di remunerazione al fattore lavoro. Ciò è anche confermato con l’andamento dei parametri macroeconomici
per il 1997 che segnano un incremento del PIL sull’anno precedente del 3,8%
per gli USA, dello 0,9% per il Giappone, del 2,2% per la Germania, del 2,3 per
la Francia, del 3,3% per il Regno Unito e infine dell’1,5% per l’Italia; rispettivamente
negli stessi paesi si hanno variazioni percentuali sull’anno precedente dell’occupazione
del 2,3%, 1,1%, -1,4%, 0,3%, 1,7 e valori anche estremamente bassi per l’Italia. Nel 1997 si hanno tassi di disoccupazione del 5% per gli USA,
del 3,4% per il Giappone, dell’11,5% per la Germania, del 12,5% per la Francia,
del 5,6 per il Regno Unito e del 12,3% per l’Italia. Per gli stessi paesi è
infine importante riferire gli indicatori economici relativi al costo del lavoro
per unità di prodotto che vede rispettivamente incrementi dello 0,9% in USA,
del -2,8% in Giappone, del -5,8% in Germania, del -3% in Francia, del 3,3% nel
Regno Unito e del 2% in Italia. E’ proprio a partire da tale ultimo indicatore riferito al
CLUP ( Costo del Lavoro per Unità di Prodotto) che si rende necessario un immediato
raffronto con l’andamento della produttività, degli investimenti, dei ricavi
e dei profitti relativi ai singoli paesi e ai vari settori economici per meglio
capire la forte distorsione distributiva a favore dei profitti che si sta verificando
da ormai moltissimi anni. E questo sarà l’argomento che verrà trattato nel prossimo numero
di PROTEO (n.1/99) nella Seconda Parte di questa analisi-inchiesta. Le Tappe dell’Unità europea
Per collocare storicamente l’idea di un’Europa unita si deve
risalire al 1951, anno in cui è stato firmato il Trattato della Comunità Europea
del Carbone e dell’Acciaio; i paesi aderenti alla CECA sono stati: il Belgio,
l’Italia, il Lussemburgo, la Germania Federale, i Paesi Bassi e la Francia. Nel 1957 i sei stati membri della CECA hanno firmato dei trattati
relativi alla costituzione di un mercato comune per mezzo dell’unione doganale
e nel 1958 si è riunita a Strasburgo per la prima volta l’assemblea parlamentare
della CEE (142 deputati ); la politica agricola comune (PCA) è stata attivata
nel 1961, mentre la prima moneta della Comunità Europea è stata l’unità di conto
(UC). Nel 1968 si è attuata l’unione doganale tra i sei paesi membri
e nel 1973 entrano a far parte della Comunità Europea il Regno Unito, la Danimarca
e l’Irlanda. Lo SME (sistema monetario europeo) costituito nel 1979 rappresenta
un sistema fondato su tassi di cambio stabile tra le monete degli Stati aderenti
basato su tassi di riferimento disposti in funzione della nuova unità di conto,
l’ECU (European Currency Unit) con una banda di oscillazione intorno al 2,25%. Sempre nel 1979 per la prima volta vengono eletti direttamente
dai cittadini i 410 deputati del Parlamento europeo; nel 1981 anche la Grecia
aderisce alla comunità europea, nel 1986 la Spagna e il Portogallo (i deputati
salgono così a 518) e nel 1990 , dopo il crollo del muro di Berlino nel 1989,
anche la Germania orientale. Il Trattato di Maastricht entra in vigore il 1 novembre 1993
ed istituisce l’Unione Europea ( i paesi si impegnano a realizzare una unione
monetaria ed economica con una moneta stabile ed unica e ad attuare politiche
estere comuni in grado di consentire il mantenimento della pace). Nel 1995 i deputati europei salgono a 626 con l’adesione dell’Austria,
della Svezia e della Finlandia ; in questo stesso anno entra in vigore la convenzione
di Schengen (libera circolazione delle persone entro i confini dell’unione)
e si decide che la moneta comune sarà l’Euro (che dovrà entrare in vigore entro
il 2002 con valutazioni dei singoli Stati per l’ammissione all’Unione Monetaria
nel 1998 sui dati effettivi del 1997). Il 17 giugno del 1997 si riunisce ad Amsterdam il Consiglio
Europeo che si accorda per un nuovo progetto di Trattato e fissa disposizioni
per un passaggio “più facile” alla terza fase dell’Unione Economica e Monetaria. Ed infine il 2 maggio 1998 viene redatta la lista dei Paesi
che dovranno adottare l’euro contabile dal 1 gennaio 1999. A PROPOSITO DI POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE
Per quanto riguarda l’occupazione il Trattato di Maastricht
ha istituito il Fondo Sociale Europeo che ha l’obiettivo di “promuovere all’interno
della comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale
dei lavoratori.....in particolare attraverso la formazione e la riconversione
professionale”(art.123) al fine di promuovere pari opportunità di lavoro, lottare
contro la disoccupazione e l’esclusione dal mercato del lavoro e favorire la
creazione di nuovi posti di lavoro. Tra il 1994 e il 1999 il Fondo Sociale Europeo ha messo a disposizione
die paesi dell’Unione Europea circa 93.000 miliardi di lire del bilancio comunitario
per cofinanziare le attività degli stati membri. ----- Il FSE finanzia programmi al fine di : • offrire assistenza alle regioni europee che presentano
difficoltà socio-economiche; • lottare contro la disoccupazione di lunga durata, facilitare
l’inserimento professionale dei giovani e di persone minacciate d’esclusione
dal mercato del lavoro, promuovere le pari opportunità sul mercato del lavoro
tra i due sessi; • favorire l’adattamento dei lavoratori ai cambiamenti industriali
e all’evoluzione dei sistemi di produzione. La copertura monetaria del FSE arriva fino al 75% del costo
totale dei progetti nei settori che necessitano di maggiore assistenza mentre
negli altri finanzia fino al 50%. Nel novembre 1997 in Lussemburgo si è svolto un vertice dei
paesi dell’Unione Europea in materia di occupazione ed il Consiglio ha concordato
la creazione di una struttura comune per i Piani di Azione Nazionali (PAN). Il Pilastro Occupabilità invita gli Stati membri ad
intraprendere azioni concrete per raggiungere gli obiettivi: • orientamenti 1 e 2: applicare un approccio preventivo in
modo da ridurre significativamente il passaggio di disoccupati giovani e adulti
nella categoria della disoccupazione di lunga durata; • orientamento 3: incentivare il passaggio del disoccupato
da una condizione di dipendenza dai sussidi sociali verso il lavoro e la formazione,
attraverso una politica del mercato del lavoro più attiva; • orientamenti 4 e 5 : sviluppare la compartecipazione come
quadro per la fornitura di formazione e formazione permanente; • orientamenti 6 e 7 : agevolare la transizione dalla scuola
al mondo del lavoro. Il Pilastro Adattabilità invita gli stati a raggiungere
gli obiettivi di: • orientamento 13: le parti sociali sono invitate a negoziare
accordi per modernizzare l’organizzazione del lavoro. Tali accordi possono
riguardare diverse configurazioni dell’orario di lavoro e diverse forme di
lavoro. In esse si dovrebbe raggiungere un equilibrio fra flessibilità e sicurezza; • orientamento 14: per tenere in debito conto la varietà
crescente delle forme di occupazione, gli Stati membri cercheranno di introdurre
tipi di contratti più adattabili, garantendo al contempo adeguati livelli
di sicurezza; • orientamento 15: gli Stati membri incoraggeranno lo sviluppo
della formazione interna alle imprese e gli investimenti nelle risorse umane. Il pilastro relativo alle Pari Opportunità
invece persegue i seguenti obiettivi: • orientamento 16: colmare il divario tra i sessi nell’occupazione
e nella disoccupazione; • orientamento 17: conciliare la famiglia e il lavoro; • orientamento 18: facilitare il reinserimento nel mondo
del lavoro; • orientamento 19: promuovere l’inserimento delle persone
disabili nel mondo del lavoro 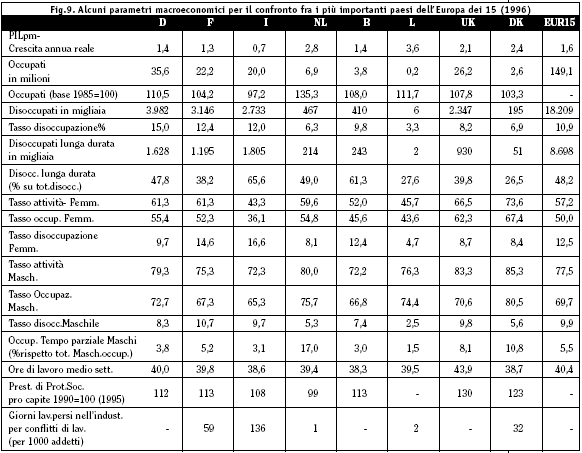
Tra le politiche apparentemente ritenute valide per risolvere il problema della disoccupazione va ricordata anche la nascita in questi ultimi anni del cosiddetto Terzo settore e delle aziende non-profit.
Salamon e Anheier hanno effettuato uno studio a livello internazionale su questo argomento rilevando che circa 11 milioni di occupati (in sette paesi sviluppati) appartengono a questo settore (negli USA circa il 6,8% degli occupati, in Germania il 3,7%, in Italia l’1,8%, il 4% nel Regno Unito e il 4,2% in Francia).
Negli anni ‘80 in Germania le imprese non profit hanno creato l’11% di nuovi posti di lavoro, in Francia il 16%, negli USA il 12,7% e in Italia il terzo settore ha creato il 39% di nuova attività lavorative; va rilevato però che questi dati si accompagnano ad un peggioramento delle condizioni di lavoro e ad una diminuzione dei salari, ad una precarizzazione in sostanza delle condizioni salariali e di lavoro, assumendo nel contempo la forma di “concorrenza” e svuotamento del Welfare e delle politiche pubbliche a carattere di intervento pubblico. -----
Glossario dall’Annuario EUROSTAT
Disoccupati
Secondo la definizione accettata internazionalmente, sono le persone non occupate che sono attivamente in cerca di occupazione e sono immediatamente disponibili ad accettare un lavoro.
Lavoratori dipendenti
Persone legate a un’impresa da un contratto di lavoro che garantisce loro una remunerazione del lavoro prestato.
Prestazioni di protezione sociale
Trasferimenti - in denaro o in natura - effettuati dai regimi di protezione sociale a favore delle famiglie e dei singoli individui e finalizzati a permettere loro di far fronte a determinati eventi o di soddisfare particolari bisogni (associati alla vecchiaia, alla malattia, alla maternità e alla famiglia, all’invalidità, alla disoccupazione ecc.).
Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato
Risultato finale dell’attività di produzione delle unità produttrici residenti. Corrisponde alla produzione totale di beni e servizi di un’economia meno i consumi intermedi. Calcolato ai prezzi di mercato, comprende l’IVA sulla produzione e le imposte nette sulle importazioni.
Prodotto interno lordo in parità di potere d’acquisto (PPA)
Prodotto interno lordo convertito nell’unità di potere d’acquisto, basata sui prezzi relativi e utilizzata per i confronti di volume.
Redditi da lavoro dipendente
Compenso complessivo, in denaro o in natura, riconosciuto dal datore di lavoro a un lavoratore dipendente quale corrispettivo per il lavoro svolto da quest’ultimo durante il periodo in esame. I redditi da lavoro dipendente comprendono le retribuzioni lorde, i contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoro e i contributi sociali figurativi.
Retribuzioni nell’industria
I dati sulle retribuzioni nell’industria si riferiscono all’insieme del settore; industria manifatturiera, energia, edilizia e opere civili.
Retribuzioni nette
Sono calcolate detraendo dalle retribuzioni lorde i contributi sociali e le imposte a carico dei lavoratori dipendenti e aggiungendovi, se del caso, gli assegni familiari. I dati si riferiscono alle retribuzioni medie degli operai delle imprese dell’industria manifatturiera con 10 o più dipendenti nell’ottobre di ogni anno.
Tasso di attività
Percentuale delle forze di lavoro rispetto al totale della popolazione in età lavorativa (15 anni ed oltre).
Tasso di disoccupazione
Percentuale di disoccupati rispetto alle forze di lavoro.
Tasso di occupazione
Percentuale degli occupati rispetto al totale della popolazione in età lavorativa (15 anni ed oltre).
Unione Europea
E’ nata il 1º Gennaio 1994, con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht. L’U.E. si componeva al 31 dicembre 1994 di 12 Stati membri: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito (EUR 12). Dal gennaio 1995 comprende tre nuovi Stati membri: Austria, Finlandia e Svezia.
Simboli utilizzati per i paesi
EUR 15 (insieme dei 15 Stati membri dell’U.E.); B (Belgio); DK (Danimarca);D (Germania); EL (Grecia); E (Spagna); F (Francia); IRL (Irlanda); I (Italia); L (Lussemburgo); NL (Paesi Bassi); A (Austria); P(Portogallo); FIN (Finlandia); S (Svezia); UK (Regno Unito) ISL (Islanda); NOR (Norvegia); CHE (Svizzera); USA (Stati Uniti d’America); CAN (Canada); JPN (Giappone).-----
Riferimenti Bibliografici ESSENZIALI
Il giusto lavoro per un mondo giusto. Dalle 35 ore alla qualità del tempo di vita. (1995)
Interventi di: Luigi Vinci, Fausto Bertinotti, Ken Coates, Jean-Marie Martin, Salvador Jové, Helmut Schauer, Sergio Bologna, Mario Agostinelli, Dini Greco, Andrea Fumagalli, Giorgio Lunghini, Giovanni Mazzetti, Samir Amin, Giorgio Nebbia, Gianfranco La Grassa, Carla Ravaioli, Costanzo Preve, Alfonso Gianni, Mimmo Porcaro.
Ed. Punto Rosso.
La mondializzazione capitalistica nell’epoca presente. (1995)
Interventi di: Samir Amin, Jorge A. Calderòn Salazar, Josè Luiz Del Roio, Fausto Bertinotti.
Ed. Punto Rosso.
Contro Maastricht. Una nuova prospettiva per il vecchio continente. (1996)
Interventi di: Farid Adli, Bruno Amoroso, Pietro Barcellona, Heinz Bierbaum, Massimo Cacciari, Francois Chesnais, Philippe Herzog, Emilio Molinari, Manuel Monereo, Manfred Muller, Luigi Vinci, Fausto Bertinotti.
Ed. Punto Rosso.
AA. VV., (1997), La democrazia del reddito universale, manifestolibri srl.
Altieri Giovanni, (1997), Lavoro nero e irregolare: eterogeneità del fenomeno e differenziazione delle politiche per favorire l’emersione, in Assistenza Sociale n. 3 luglio-settembre, Ediesse.
Barbieri Paolo, Cambiamenti del modello occupazionale italiano e problemi di regolamentazione. Uno sguardo d’insieme, in “Il lavoro che cambia”, La transizione regolativa, Assistenza Sociale n. 3 luglio-settembre 1997, Rivista trimestrale sulle prospettive del Welfare, Ediesse
Caracciolo Lucio, (1997), Euro No. Non morire per Maastricht. Ed. Laterza.
Cavaterra Rita, (1997), Il lavoro che cambia: nuove figure, nuovi diritti, nuove tutele sociali, in Assistenza Sociale n. 3 luglio-settembre, Ediesse.
Cersosimo Domenico, (1996), Lavoro e non lavoro, Meridiana Libri.
Chies Laura - Trombetta Francesco, Riduzione dell’orario di lavoro e disoccupazione: il dibattito tedesco, in Economia&Lavoro Anno XXXI, n. 3-4, Saggi pp. 281-307.
Geroldi Gianni, (1997), Ammortizzatori sociali e incentivi all’impiego nel quadro dei nuovi strumenti di politica del lavoro, in Assistenza Sociale n. 3 luglio-settembre, Ediesse.
Johnston Peter, (1997), Gestione virtuale: una rivoluzione culturale in atto. Gestire nella società dell’informazione: politica ed iniziative dell’Europa unita, in “Speciale Telelavoro”, in Lavoro e Sicurezza Sociale, Rivista trimestrale della C.I.D.A. (Confederazione Italiana Dirigenti d’Azienda), n. 1 gennaio-marzo, Franco Angeli s.r.l.
Mazzetti Giovanni, (1995), Economia e orario. Le ragioni economiche della riduzione a parità si salario. Ed. Datanews.
Paci Massimo, (1997), Le politiche attive del lavoro, in Assistenza Sociale n. 3 luglio-settembre, Ediesse.
Paone Gianni, (1997), Lavoro «grigio», lavoro autonomo, lavoro atipico, in Assistenza Sociale n. 3 luglio-settembre, Ediesse.
Trentin Bruno, (1997), La città del lavoro, Feltrinelli.
Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro, ISTAT, rilevazioni trimestrali di vari anni.
Annuario EUROSTAT, vari anni.
Annuario ISTAT, vari anni.
Rilevazioni OCSE, vari anni.
Banca d’Italia Assemblea Generale Ordinaria dei Partecipanti, vari anni.
[1] “Il Prodotto Interno Lordo ai prezzi di mercato (PILpm) rappresenta il risultato finale dell’attività di produzione delle unità produttrici residenti. Corrisponde al valore aggiunto lordo dell’economia (produzione totale di beni e servizi, meno i consumi intermedi) calcolato ai prezzi di mercato, più l’IVA sulla produzione e le imposte nette sulle importazioni (imposte sulle importazioni al netto dei contributi alle importazioni) . Il PIL è anche calcolato a prezzi costanti per neutralizzare gli aumenti o le diminuzioni provocati dall’incremento o dalla riduzione dei prezzi ed è inoltre convertito dalle monete nazionali nell’unità monetaria europea(ECU) e in standard di potere di acquisto (SPA) al fine di confrontare il prodotto interno lordo dei diversi paesi. La crescita economica reale (in termini di volume) è misurata come l’incremento del prodotto interno lordo a prezzi costanti“. Cfr. Eurostat.
[2] Cfr. “The composition of unemployment form an economic perspective”, European Economy, n. 59, 1995.
[3] 5 Cfr.”Growth, employment.-intensive growth”, European Economy, n.62, 1996
[4] “Diversamente dai principali aggregati socioeconomici quali popolazione, occupazione, prodotto interno lordo, che presentano andamenti relativamente regolari, le serie statistiche che riguardano i conflitti di lavoro sono caratterizzate da brusche variazioni, in corrispondenza ad esempio di scioperi generali o scioperi settoriali di lunga durata. I conflitti di lavoro sono connessi a vertenze (contratti collettivi o questioni finanziarie o sociali) che in certi casi si protraggono a lungo e non consentono quindi confronti significativi tra gli anni”, cfr. Annuari Eurostat, vari anni.