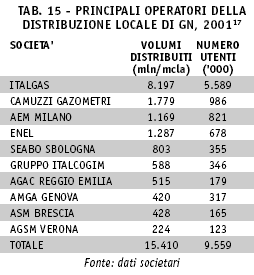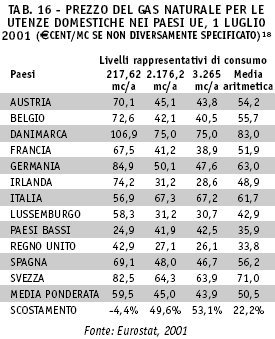![]()
Rubrica
L’analisi-inchiesta
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Rita Martufi Consulente ricercatrice socio-economica; membro del Comitato Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico Sociali (CESTES) - PROTEO
Tutti gli articoli della rubrica: analisi-inchiesta(in tutti i numeri di Proteo)
|
Per le tariffe del Trasporto Pubblico Urbano la riforma ha stabilito che debbano essere determinate in sede di contratto di servizio; ad oggi però questo elemento non è stato ancora attuato. Se si analizza ad esempio il servizio urbano si ricorda che il costo medio di un biglietto a gennaio 2002 nelle maggiori città italiane era di e 0,86 con un valore massimo di e 1,03 a Firenze e un valore minimo di e 0,77 ad esempio a Roma, Napoli, Torino, ecc.
Con la legge finanziaria del 2002 (art. 35) è previsto che la proprietà delle reti e degli impianti resti agli enti locali. Entro la fine del 2003 la gestione dei servizi di trasporto dovrà essere attuata attraverso gare. 4. Il settore del gas naturaleIl processo di liberalizzazione dei servizi pubblici avviata nella Comunità europea ha interessato anche il settore del gas, infatti il recepimento della direttiva europea 98/30/CE ha posto le basi per la costituzione di un mercato interno concorrenziale del gas naturale. Il decreto legislativo n.164 del 23 maggio 2000 (decreto Letta) fissa le regole per una ristrutturazione del settore. Il decreto cita testualmente: Art. 1. Liberalizzazione del mercato interno del gas naturale "1. Nei limiti delle disposizioni del presente decreto le attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale, in qualunque sua forma e comunque utilizzato, sono libere". La liberalizzazione del mercato del gas prevede l’accesso libero alla rete di trasporto da parte dei "clienti idonei", ossia operatori in grado di poter scegliere il proprio fornitore di gas. L’importazione di gas naturale è libera nei paesi UE mentre per gli altri paesi al di fuori dell’UE è necessaria l’autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive. La produzione nazionale è incentivata con contributi statali e la ricerca geofisica è libera anche se sottoposta ad autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive. Per quanto riguarda l’attività di trasporto e dispacciamento va ricordato che queste vengono definite dal decreto come attività di interesse pubblico e il Ministero delle attività produttive definisce le condizioni di emergenza e sicurezza. L’ENI per poter separare le attività di trasporto e dispacciamento del gas dai settori di approvvigionamento e vendita ha distaccato dalla SNAM la rete del trasporto del gas nel nostro Paese; la nuova società, la Snam Rete Gas ha un valore riconosciuto dall’Autorità di 9,5 miliardi di euro. Per quanto riguarda l’attività di distribuzione (anch’essa considerata di servizio pubblico) il decreto stabilisce che "Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato..." [1] (Si ricorda che per enti locali si intendono Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane). La vendita del gas naturale può essere svolta solo da imprese che abbiano l’autorizzazione del Ministero dell’Industria, il quale ha il compito di accertare la disponibilità di un servizio adeguato, la provenienza del gas e dell’affidabilità del trasporto. Le tariffe per il trasporto e dispacciamento, per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, per l’utilizzo dei terminali di GNL e per la distribuzione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito, sono stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas [2]. Il decreto prevede, inoltre, che dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2010, non possono essere venduti più del 50% dei consumi nazionali di gas naturale ai clienti finali da nessuna impresa (sia direttamente sia indirettamente) per rispettare lo sviluppo della concorrenza. Il decreto stabilisce, poi, il rispetto delle condizioni di reciprocità secondo le quali le imprese del gas italiane possono avere contratti con clienti stranieri e viceversa. Si ricorda che nel 2001 si sono avuti consumi pari a 70,1 mld/mc; il 22% del fabbisogno totale è stato effettuato con produzione nazionale (di cui la maggior parte dal gruppo ENI e in minima quota dal Edison Gas); il restante 78% di consumo totale è soddisfatto dalla importazioni da paesi come Russia, Algeria, Paesi Bassi, Norvegia. Va ricordato che gli usi del gas sono stati nel 1998 per il 58,2% indirizzati verso il riscaldamento domestico, per il 20,7% verso usi artigianali, commerciali e di piccola industria, per il 18,6% verso usi di cucina e acqua calda ed infine il 2,5% verso usi ospedalieri. Il Nord del Paese assorbe circa il 70% del gas distribuito, anche perché in queste regioni oltre ad una più alta rigidità del clima sono presenti le maggiori concentrazioni industriali. L’offerta del gas naturale è contraddistinta da un’alta frammentazione soprattutto perché di solito il servizio di distribuzione viene effettuato dai Comuni.
Negli ultimi anni si è assistito ad un rilevante processo di consolidamento delle aziende di distribuzione e vendita di gas naturale. I dati riferiti al 2001 dimostrano una elevata concentrazione degli operatori del settore; le 10 più grandi imprese di distribuzione hanno servito circa il 60% dei clienti finali assegnando il 50% del volume complessivo di gas naturale. La tabella seguente [3] mostra come ad esempio l’Italgas detenga il 26,6% del mercato complessivo; di seguito vi è la Camuzzi che si aggiudica però solo il 5,8% nel 2001.
Se si analizzano le tariffe va evidenziato che nel nostro Paese, a differenza degli altri paesi europei, non vi sono tariffe regressive rispetto al consumo; infatti l’Italia pur avendo prezzi bassi per consumi ridotti è svantaggiata rispetto all’Europa per quanto riguarda le utenze con alti consumi (cfr. Tab.16 [4]).
Con la delibera n. 237/2000 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha stabilito nuovi sistemi di tariffe per la distribuzione e vendita del gas naturale. Infatti la citata delibera stabilisce: - "I criteri per la determinazione delle tariffe di distribuzione, tramite la definizione di un vincolo sui ricavi massimi conseguibili da tale attività e l’individuazione di un livello di costo minimo per l’utente. - Lo schema per il calcolo delle tariffe per l’attività di vendita ai clienti del mercato vincolato che resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2002, data a partire dalla quale tutti i clienti si qualificheranno come idonei. L’Aeeg ha stabilito... la tariffa unica per ambito territoriale in cui i costi del servizio abbiano natura congiunta ed indivisibile..." [5] [1] Art.14 Decreto n.164 del 23 maggio 2000 [2] Cfr. Art.23, Decreto n.164 del 23 maggio 2000 [3] Cfr. "The Times They are a- Changin’....", op. cit., pag.110 [4] Cfr. "The Times They are a- Changin’....", op. cit., pag.115 [5] Cfr. "The Times They are a- Changin’....", op. cit., pag.117.
|
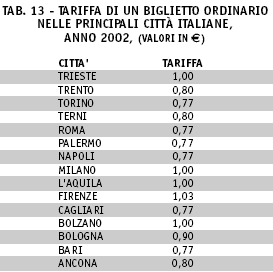
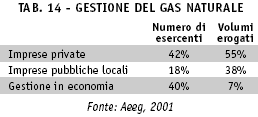 La
gestione è prevalentemente di tipo privato (il 42% delle imprese totali) anche
se un certo rilevo assumono anche le imprese pubbliche locali. (cfr. Tab.14).
La
gestione è prevalentemente di tipo privato (il 42% delle imprese totali) anche
se un certo rilevo assumono anche le imprese pubbliche locali. (cfr. Tab.14).