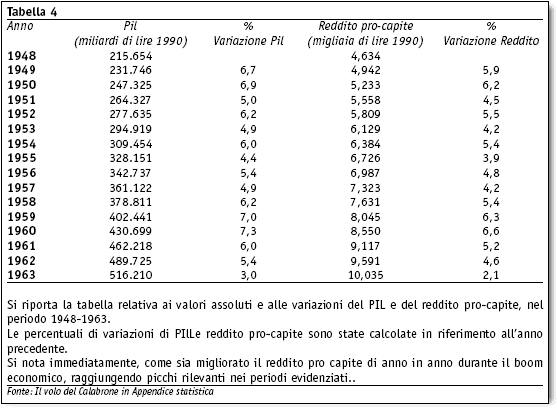![]()
Rubrica
Analisi-inchiesta: il movimento dei lavoratori:tra cambiamento e indipendenza
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Luciano Vasapollo Docente di Economia Aziendale, Fac. di Scienze Statistiche, UniversitÓ’ “La Sapienza”, Roma; Direttore Responsabile Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali (CESTES) - Proteo. Rita Martufi Consulente ricercatrice socio-economica; membro del Comitato Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico Sociali (CESTES) - PROTEO Sabino Venezia Coordinamento Nazionale RdB Pubblico Impiego
Il contraddittorio legame tra le trasformazioni economico-produttive e alcuni passaggi-chiave della storia del movimento sindacale dal dopoguerra ad oggi (Prima parte)
Tutti gli articoli della rubrica: analisi-inchiesta(in tutti i numeri di Proteo)
|
“la programmazione viene infatti intesa come una coerente ed efficace strategia interna del sindacato sulla politica economica di sviluppo, una razionalizzazione omogenea delle politiche rivendicative e delle linee di azione...” [1] La fase della programmazione, elemento propulsivo dell’unità sindacale, perde la sua forza quando traspare che l’unità non è frutto di un processo che ha coinvolto a pieno la base dei lavoratori, bensì l’equilibrio tra le forze politiche che ispirano i dirigenti sindacali; la tanto decantata indipendenza, (contestata alla sinistra CGIL “cinghia di trasmissione” ma non dalla componente comunista) [2], svela la falsa strategia innovatrice e riformista della corrente socialista CGIL, ne determina la pressoché totale disfatta negli anni ’70 [3], e ne compromette l’esistenza negli anni ’80 nonostante, con l’avvento del craxismo, il partito sarà più presente sulla scena del sistema politico [4]
6. Gli anni ’60
6.1 Le trasformazioni socio-occupazionali
Una attenta analisi del decennio in esame, il ’60, evidenzia tutti i limiti del sindacalismo italiano che, con la strategia unitaria della programmazione, non si accorge della crisi capitalistica che il mondo attraversa né tantomeno percepisce il rischio che corre il mondo del lavoro nelle soluzioni e nelle dinamiche che si tengono per dare soluzione a tale crisi; si pensi che dal ’53 al ’60 l’indice di rendimento del lavoro passa dal 100 al 140,6% mentre quello dei guadagni da lavoro dipendente da 100 a 108,9%. Il miracolo economico si basa prevalentemente sulla compressione dei salari e sullo sfruttamento della manodopera. Uno dei principali ambiti di sviluppo della dottrina della programmazione sarà la politica dei redditi, frequentemente confusa con la sola politica dei salari, alla quale lo stesso Governo dell’epoca tentò di ricorrere. Il Governo di quegli anni, spinto anche da una “dottrina sociale della Chiesa” che caratterizzava ampi strati della Democrazia Cristiana, si predispose verso una politica delle riforme, nel campo del lavoro, di particolare importanza: “Si cominciò nel 1959 con l’estensione per legge a tutti i lavoratori delle stesse condizioni economiche e normative contenute nei contratti collettivi.
Si proseguì poi con la fondamentale riforma dell’intermediazione di manodopera del 1960, che consentì di superare la pratica del “caporalato”, che metteva i lavoratori in mano ad organizzazioni criminali, soprattutto al sud, e li esponeva allo sfruttamento per l’applicazione di condizioni deteriori ma tuttavia “legali”. La legge vietò la mera intermediazione, garantendo condizioni paritarie in caso di appalto di mano d’opera tra lavoratori dell’appaltatore e dell’appaltante e costituendo una spinta decisiva verso una delle caratteristiche fondamentali del “diritto del lavoro”: la prevalenza della “sostanza” sulla “forma”. Nel diritto del lavoro, infatti, conta, e può essere accertato giudizialmente, chi è il vero datore di lavoro, quale è la vera natura del rapporto di lavoro (autonomo o subordinato), quali sono le vere condizioni e modalità del rapporto, a prescindere dagli aspetti formali del contratto. Seguì poi la riforma del contratto a termine (nel 1962), che vincolò l’utilizzazione di questo strumento a ben precise condizioni e forme, con l’automatica conversione in rapporto a tempo indeterminato in caso di violazione, per evitarne l’abuso allo scopo di sottrarsi alle norme a tutela del lavoro a tempo indeterminato (ma l’importanza della riforma divenne più evidente a seguito soprattutto del successivo sviluppo della normativa sui licenziamenti) e la legge del 1963 sul divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio.” [5]
[1] A. Pepe - il sindacato nell’Italia del ’900 - Rubbettino editore Dicembre ’96 pag. 211. [2] La sinistra di V. Foa traeva ispirazione proprio dal rifiuto della programmazione per giustificare il processo unitario e costruire un sindacato conflittuale e rappresentativo delle nuove esperienze del mondo del lavoro. [3] Sarà G. Giugni nel ’74, in apertura di un Convegno sindacale del Partito Socialista, ad individuare una forte crisi di identità del sindacalismo socialista. [4] Va comunque considerato, per onestà intellettuale, che i “convegni sindacali” svolti tra la componente socialista e l’ufficio della direzione del partito, erano sempre occasione per ribadire la piena autonomia oltre che per verificare la coesione interna e la capacità organizzativa. [5] Giovanni Cannella (magistrato di Corte d’Appello)(pubblicato su D&L, Riv. crit. dir. lav. 4/2001, p.873) L’articolo, che è pubblicato anche su Omissis (www.omissis.too.it), e sul numero monografico di marzo 2002 della rivista “Il Ponte” intitolato”Quale governo quale giustizia” riproduce la relazione introduttiva per l’assemblea pubblica e dibattito dal titolo “No al lavoro senza diritti”, organizzata a Roma il 14/12/01 dal Forum Diritti-Giustizia (Social Forum Roma)-Antigone, Cred, Giuristi democratici, Progetto diritti, Camera del lavoro e del non lavoro, Cobas, Rdb, Avvocati progressisti italiani, Magistratura democratica romana.
|