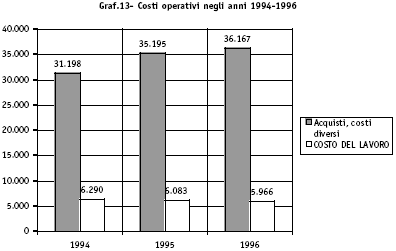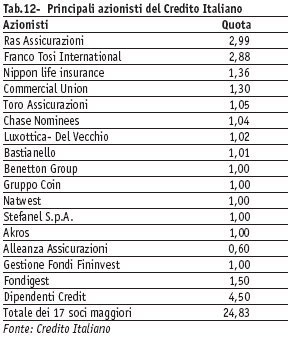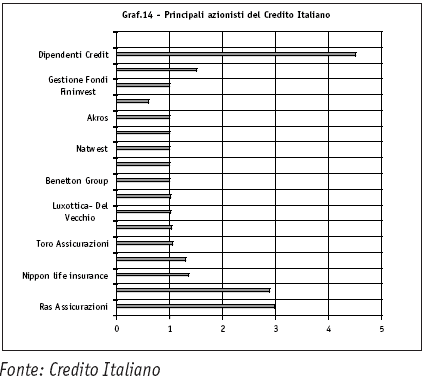![]()
Rubrica
L’analisi-inchiesta
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Luciano Vasapollo Docente di Economia Aziendale, Fac. di Scienze Statistiche, Università’ “La Sapienza”, Roma; Direttore Responsabile Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali (CESTES) - Proteo.
I diversi modelli del capitalismo internazionale si confrontano sulle strategie di privatizzazione Le diverse forme di privatizzazione Privatizzazioni e mercati finanziari La via alle privatizzazioni nel modello capitalistico italiano. Un’indagine statistico-aziendale
Tutti gli articoli della rubrica: analisi-inchiesta(in tutti i numeri di Proteo)
|
Tra le altre attività svolte dall’ENi vi sono le attività di finanziamento e di assicurazione per le imprese gestite dalle finanziarie Enifin, Sofid ed Eni International Holding. Nel 1992 l’Eni è stata trasformata in società per azioni ed, in base alle leggi emanate per la privatizzazione, il Ministero del Tesoro ha disposto la vendita al pubblico delle azioni. Il decreto del 10 maggio 1995 ha deliberato la vendita delle partecipazioni detenute dal Ministero del Tesoro nell’ENI S.p.A., attraverso l’offerta pubblica e il collocamento privato. Nel 1996 circa 84.000 persone erano occupate nell’ENI S.p.A. (delle quali 8.200 assunte a tempo determinato) ed all’estero impiegava circa 25.500 dipendenti. La ristrutturazione che si è avuta negli anni che vanno dal 1992 al 1996 ha portato ad una riduzione del personale di circa il 33.5%; la principale causa di questa situazione va imputata alla chiusura di alcuni impianti industriali alla cessione di alcune attività e agli incentivi al prepensionamento ed uscita dall’Ente. Come si evince dalla Tab 10 e Graf.11, la diminuzione occupazionale più rappresentativa si è avuta nel settore petrolchimico e nelle attività in corso di dismissione (si è avuta una riduzione del 53% nel primo e del 86.4% nel secondo).
E’ interessante anche mostrare attraverso la Tab.11 e
il Graf.12 come sia stata ripartita, tra le varie categorie, la riduzione
del numero degli occupati. Dalla tabella a dal g Va ancora evidenziato che negli anni che vanno dal 1994 al 1996 si registra un aumento di costi operativi derivati dall’incremento degli acquisti, dalle prestazioni di servizi e costi diversi delle attività del gas naturale e del petrolio ( ci si riferisce agli aumentati accantonamenti ai fondi svalutazione crediti, alla crescita del costo del gas naturale e delle materie prime dei prodotti petroliferi). Diversa è invece la situazione per quanto riguarda il costo del lavoro che registra un calo di oltre 117 miliardi di lire(l’1,9%). In sostanza comunque, l’incidenza percentuale dei costi operativi
sui ricavi è aumentata (si passa dal 72,6% al 73%). (Cfr. Graf.13)
La privatizzazione dell’Eni ha avuto, nelle intenzioni formali, due obiettivi principali: il primo consisteva nell’eliminazione di settori in perdita e non strategici; il secondo invece intendeva garantire il supporto finanziario dei settori in sviluppo del Gruppo, rispettando l’equilibrio tra mezzi propri e debito. Nella fase di attuazione dell’operazione di dismissione é stato garantita l’omogeneità di trattamento, predisponendo un’asta suddivisa in 2 fasi: • la prima, in cui si prevede un offerta preliminare; • la seconda, più articolata per la definizione dell’offerta finale vincolante. In ambedue i casi i potenziali acquirenti hanno ricevuto le stesse informazioni nello stesso momento. Per consentire all’intera operazione il massimo della trasparenza è stata attuata una procedura d’asta tramite la pubblicazione di un annuncio che descriveva le fasi fondamentali e precisava il calendario. Nel 1992 si è avviato il processo di cessione di attività nei settori :chimico, minerario - metallurgico , meccano - tessile e turistico; una tra le cessioni più importanti è stata quella del Nuovo Pignone.
Le operazioni di dismissioni si sono avute principalmente in attività che non consolidavano il business dell’ENI, ma operavano su interventi sociali.
La prima fase di privatizzazioni si è avuta nel dicembre 1995 ed è stata avviata anche grazie al record del bilancio consolidato del’94 ,che ha toccato un’utile netto di 3.215 miliardi, il più alto di tutta la storia e uno dei più alti in Italia. L’operazione di privatizzazione è stata rivolta all’intero mercato azionario con quotazioni a Milano, New York, Londra, Tokyo. Il compito di coordinare l’operazione, deciso dal Comitato Interministeriale (Ministro del Tesoro, del Bilancio, dell’Industria e Presidente del Consiglio) è stato affidato all’IMI e a Credit SuisseFirt Boston; si è avuta una offerta pubblica italiana , una offerta pubblica internazionale e una offerta pubblica negli Stati Uniti. Va ricordato che i dipendenti del gruppo, (i quali si impegnavano a mantenere ininterrottamente il possesso azionario per un anno), potevano ricevere azione gratis ogni 10 acquistate, con un massimo di 300; è stato riservato loro il 25% delle azioni, ma ne è stato utilizzato solo il 15%. L’Offerta, per la quota dei dipendenti è stata effettuata tramite la SOFID SIM S.p.A. E’ stato, inoltre previsto il pagamento delle azioni mediante anticipo fino al 50% sul TFR. Nella seconda fase del collocamento la composizione del consorzio internazionale è rimasta uguale a quella della prima trance. Nella prima trance hanno trovato maggior collocamento i grossi investitori ,in questa seconda fase si è cercato di favorire i piccoli risparmiatori con 3 strumenti diversi: sconto sul prezzo ,bonus in azioni e, se possibile, partly paid (pagamento rateizzato). La quota azionaria offerta dall’ENI , in questa seconda trance, è stata del 10%, con una parte rilevante destinata ai piccoli risparmiatori. Il giorno 21 /10/1996 il Tesoro ha deciso un prezzo massimo di 7.425 lire ed è stato concesso al pubblico uno sconto del 3.5% . Il terzo collocamento è stato effettuato sulla base di quello precedente senza particolari cambiamenti. L’offerta pubblica di vendita è avvenuta dal 23 al 27 giugno 1997; il Ministero del Tesoro ha messo in vendita un miliardo di azioni, pari al 14,4% del capitale e a un controvalore di 10mila miliardi circa. In questo modo la quota pubblica è scesa dal 69% ( dopo il secondo collocamento ) al 51% del capitale. Le azioni oggetto dell’offerta pubblica , con esclusione della quota destinata ai dipendenti dell’ENI , sono state collocate tra il pubblico attraverso il “Consorzio Italiano” di cui fanno parte l’IMI , la Banca Commerciale Italiana, il Credito Italiano e l’Istituto Bancario San Paolo di Torino. Invece, le azioni riservate ai dipendenti sono state collocate esclusivamente per il tramite della SOFID SIM S.p.A. Le azioni ENI sono state vendute attraverso un collocamento privato destinato ad investitori istituzionali , riservato ad Italia, Regno Unito, Europa e Resto del Mondo; un collocamento privato destinato ad investitori istituzionali riservato al Canada ed una offerta pubblica riservata agli USA . I risparmiatori, per la prima volta, hanno potuto comprare le azioni , oltre che in banca, anche presso gli uffici postali. In questi giorni è in corso un intenso dibattito fra forze politiche parlamentari, e altre forze sociali (sindacati confederali, Confindustrial, Banca d’Italia, ecc.) per dare definitivamente il via alla quarta fase di privatizzazione dell’ENI.
IL CREDITO ITALIANO
Il Credito Italiano (fondato nel 1870 [1]) è senza dubbio uno dei maggiori gruppi bancari del mondo; è quotato in Borsa dal 1895 e dal 1989 è quotato al sistema telematico di contrattazione internazionale dei valori mobiliari di Londra (SEAQ); nel 1992 il Credito Italiano era il settimo gruppo bancario italiano. Tra le sue attività bancarie, parabancarie e finanziarie, svolte sia in Italia sia all’estero, vanno inclusi i finanziamenti, l’intermediazione in titoli, l’accettazione di depositi, finanziamenti all’import-export, operazioni di capital market corporate finance, gestione di portafoglio, sconto effetti, leasing, factoring, assicurazioni ed operazioni di cambio. Nel 1993 l’IRI possedeva l’81,4% del suo pacchetto azionario (64,1% azioni ordinarie, e 17,3% azioni di risparmio); la quota restante era detenuta da circa 40.000 azionisti (cfr. Tab.12 e Graf.14). Prima del 1990 (anno della legge Amato n.218) la banca e la sua società finanziaria (Credit Holding Italia S.p.A.) gestivano direttamente le società controllate, le categorie e le partecipazioni del gruppo. Nel 1992 invece sono state istituite altre due società finanziarie la Credit Holding Bank S.p.A. e la Credit Holding International S.p.A. che hanno affiancato la prima; le tre società hanno gestito quindi oltre alle attività bancarie nazionali, anche le attività non bancarie e le attività internazionali. Il Credito Italiano inoltre controlla direttamente, oltre alla SIMCredit (società di intermediazione mobiliare), anche la Banca Popolare di Spoleto. La dismissione del Credito Italiano ha rappresentato, insieme a quella dello SME, la principale operazione su cui si è attuato il programma di privatizzazione in Italia.
Il 6 Dicembre 1993, infatti l’IRI ha messo in vendita il 64% del capitale azionario della banca; l’offerta delle azioni (con esclusione delle azioni di risparmio ai dipendenti e degli investitori professionali) si è attuata solo in Italia; invece il collocamento privato di azioni ordinarie (riservate agli investitori istituzionali) si è svolta in molti altri paesi europei e degli Stati Uniti. Con questa vendita lo Stato ha trasformato una banca di interesse nazionale in una public companies; l’offerta pubblica che ha riguardato il 40% delle azioni detenute dall’IRI ha coinvolto i piccoli risparmiatori, mentre i grandi investitori istituzionali hanno partecipato ad una contemporanea operazione privata che ha interessato anche gli investitori stranieri (è stato fissato come limite massimo di acquisto per gli investitori istituzionali ed esteri una quota pari al 2%). Alcune azioni privilegiate (il 17,4% del totale), azioni di risparmio convertibili in azioni ordinarie, sono state destinate ai dipendenti del Gruppo. [1] L’IRI, che nel 1933 ha assunto il controllo effettivo della Banca, ha stabilito nel 1936 che questo istituto poteva operare come istituto a breve termine (sino a 18 mesi) o istituto di credito ordinario, con la possibilità di concedere crediti a medio termine entro limiti prefissati; sempre nel 1936 il Credito Italiano, insieme alla Banca Commerciale Italiana e al Banco di Roma, è stato classificato come banca di interesse nazionale (definizione ora abolita).
|
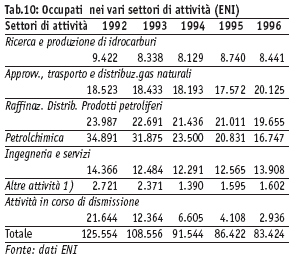
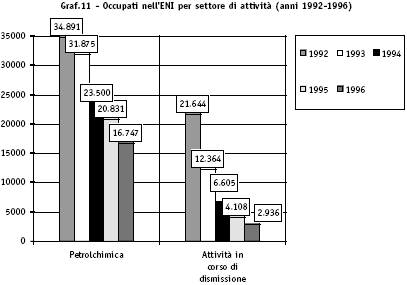
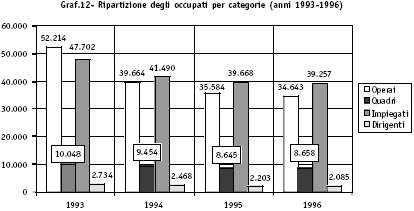 rafico
ci si accorge che dal 19
rafico
ci si accorge che dal 19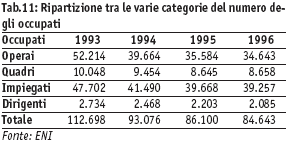 93
al 1996 si è avuta una diminuzione del 23,7% dei dirigenti, del 17,7% degli
impiegati, del 13,8% dei quadri e del 33,7% degli operai.
93
al 1996 si è avuta una diminuzione del 23,7% dei dirigenti, del 17,7% degli
impiegati, del 13,8% dei quadri e del 33,7% degli operai.