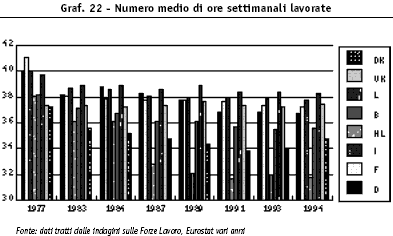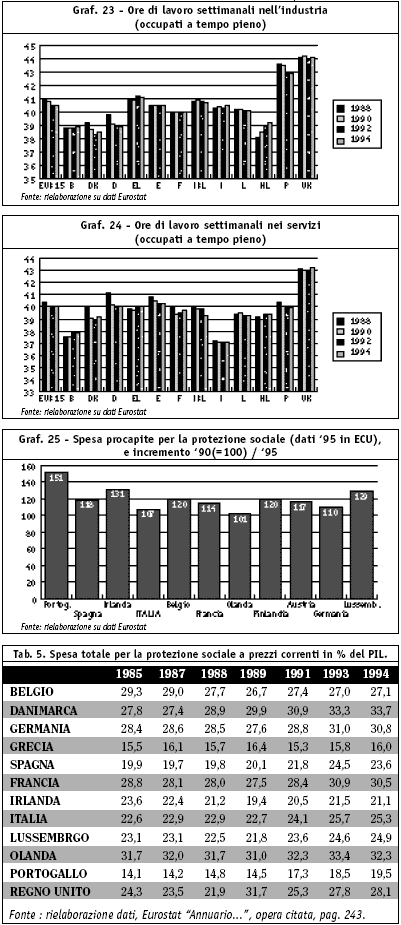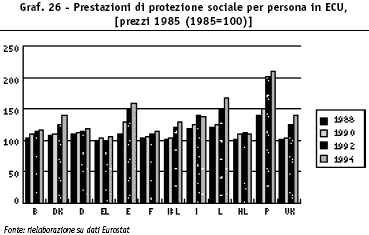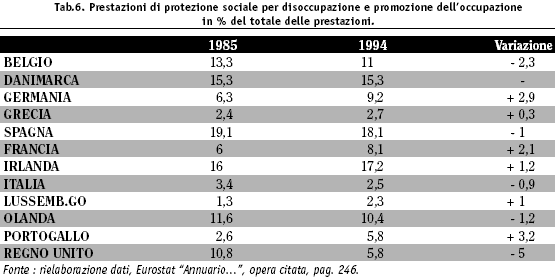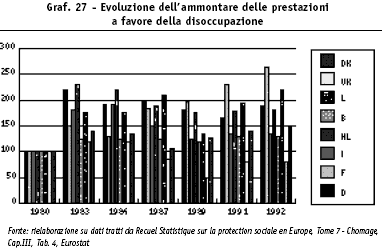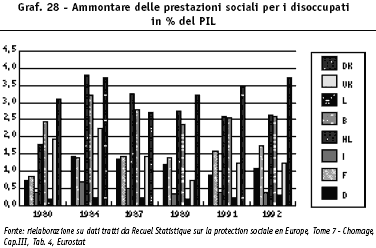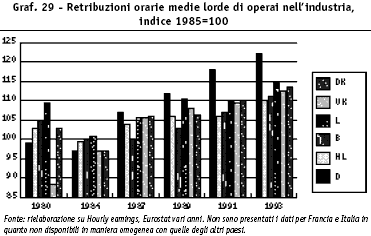![]()
Rubrica
L’analisi-inchiesta
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Luciano Vasapollo Docente di Economia Aziendale, Fac. di Scienze Statistiche, Università’ “La Sapienza”, Roma; Direttore Responsabile Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali (CESTES) - Proteo. Rita Martufi Consulente ricercatrice socio-economica; membro del Comitato Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico Sociali (CESTES) - PROTEO
Ristrutturazione capitalistica
Le tendenze macroeconomiche del processo di ristrutturazione capitalistica
Tutti gli articoli della rubrica: analisi-inchiesta(in tutti i numeri di Proteo)
|
Va rilevato che il numero delle ore di lavoro settimanali registrano una tendenza alla diminuzione dal 1985; i Graff.23 e 24 mostrano che questa diminuzione è più evidente nel settore dei servizi; anche in questo caso fa eccezione il Regno Unito che mostra una tendenza all’aumento delle ore lavorate in tutti i settori.
In Italia fino alla fine dell’ottocento l’orario di lavoro era di 12 ore al giorno e solo con la legge 692 del 1923 si è stabilito un orario massimo di otto ore al giorno o di 48 ore settimanali; nel 1997 con il recepimento della direttiva comunitaria si è stabilito l’orario legale a 40 ore settimanali. Sono in fase di attuazione diversi incentivi alla riduzione dell’orario di lavoro attraverso la riduzione per le imprese delle aliquote contributive; la finanziaria del 1998, inoltre ha destinato 800 miliardi di lire per favorire la riduzione dell’orario di lavoro. In tal modo è evidente che si continua la politica a favore degli imprenditori e del profitto poiché non si intaccano né si redistribuiscono gli incentivi di produttività al fattore lavoro.
6. Prestazioni Sociali per le politiche del lavoro
Il primo impegno effettivo, almeno ufficiale anche se poi si è rivelato più teorico che pratico, dell’azione comunitaria nei confronti di obiettivi di carattere sociale si è avuto con le disposizioni della carta comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori, la Carta Sociale del 1989 che cita : “Ogni lavoratore deve essere retribuito in modo equo” intendendo come giusto un salario che corrisponda ad almeno il 68% delle retribuzioni medie di ogni paese. Vengono poi enunciati i diritti basilari dei lavoratori tra i quali il diritto all’occupazione, alla formazione e i diritti alla protezione sociale, alla parità professionale tra uomini e donne, alla sanità e alla sicurezza sul luogo del lavoro. Il modello sociale “europeo” più di carattere renano-nipponico (basato sul sistema governo-impresa-sindacato) si differenzia dalla soluzione liberista anglosassone basata sul concetto di “meno welfare e più mercato” ed è definito in maniera un po’ singolare e non tenendo conto della drammaticità sociale che attualmente tocca l’intera Europa come “la scelta difficile tra posti di lavoro ed eguaglianza sociale, fra efficienza ed equità”. Ma anche il modello sociale giapponese e tedesco registra notevoli problemi e differenze sociali, come ad esempio quelle di salario tra i lavoratori impiegati nelle piccole e medie imprese e quelli delle grandi imprese, la scarsa protezione dei ceti sociali più deboli a conferma dei limiti di un sistema sociale poco favorevole ed efficiente. Tale modello, poi, quando imposto a realtà socio-produttive completamente diversificate provoca effetti perversi, dirompenti che si coniugano o meglio vengono resi esplosivi dalle dinamiche di ristrutturazione interna del capitale di ogni singolo paese. Nel Graf.25, ad esempio, si può osservare come l’Italia sia seconda solo all’Olanda come più basso incremento della spesa pro capite per la protezione sociale fra il 1990 e il 1995. La Tab.5 mostra chiaramente che il paese che impiega meno risorse economiche per la protezione sociale (in % del PIL) è la Grecia che nell’arco degli anni 1985-1994 non ha mai superato il 16,1%; anche il Portogallo si attesta su valori bassi ma va rilevato che presenta una tendenza alla crescita (nel 1985 il valore era del 14,1%, nel 1994 è arrivato al 19,5%). L’Italia oscilla intorno a valori del 25% mentre la Danimarca e l’Olanda sono i paesi che impiegato le maggiori risorse per la spesa sociale (rispettivamente nel 1994 il 33,7% ed il 32,3%). Va ricordato che i dati sulle protezioni sociali per i Paesi dell’U.E. sono comparabili fra loro in quanto le metodologie adottate sono molto simili fra i vari Stati. Il Graf.26 mostra che la tendenza dell’impiego di risorse economiche verso le prestazioni di protezione sociale è in aumento in tutti i Paesi della Comunità; il Lussemburgo registra un valore molto alto (nel 1994 è pari a 166) mentre l’Olanda il minore (sempre nel 1994 è pari a 116); l’Italia è in media rispetto agli altri paesi della Comunità (nel 1994 è pari a 143).
I dati riguardanti l’anno 1995 confermano il fatto che l’Italia risulta essere tra i paesi che destinano quote minori di reddito alla protezione sociale seguita solo dall’Irlanda, la Grecia e il Portogallo (questo paese però, pur trovandosi in una situazione molto critica dal punto di vista economico, sta aumentando in modo considerevole le risorse da destinare alla spesa sociale in quanto il valore degli interventi sul mercato del lavoro è più che raddoppiato negli ultimi dieci anni. Il Regno Unito si attesta nel 1995 su valori intorno al 25%, mentre la Francia e i paesi scandinavi si attestano intorno al 30% del PIL. Per quanto riguarda la spesa sanitaria totale (spesa per assistenza sanitaria e altre spese del settore quali amministrazione, investimenti, ecc.) la Francia è il paese che assegna la quota più elevata del PIL alla spesa sanitaria totale (il 9,6% nel 1996). La Germania e l’Italia invece dopo una fase di maggiore accrescimento (l’Italia è arrivata a valori dell’8,6% nel 1993 e la Germania a valori del 9,3% nel 1992) si sono attestate su valori molto più bassi rispetto alla Francia (rispettivamente il 7,5% per la Germania e il 7,6% per l’Italia nel 1996). L’Austria e i Paesi Bassi superano la media europea (che è del 7,62%) con valori pari all’8,2% nel 1996 per l’Austria e pari all’8,8% per i Paesi Bassi nel 1995. La Grecia e la Danimarca invece presentano valori inferiori alla media (rispettivamente nel 1996 il 5,9% e il 6,4%). A conferma della mancanza di una corretta e coerente politica sociale che colloca l’Italia come fanalino di coda rispetto a paesi come Francia, Germania, Regno Unito per non parlare dei paesi del Nord Europa, basta considerare che nel nostro Paese le tre maggiori voci della sicurezza sociale, la previdenza (pensioni), l’assistenza (famiglia, lavoro, servizi sociali) e la sanità (ospedali, assistenza sanitaria) hanno rappresentato nel 1997 il 24% del PIL (valori a prezzi correnti); valore che risulta essere in termini assoluti il più basso almeno dal 1990 ad oggi e che evidenzia la tendenza alla forte compressione. A ciò si aggiunge che, a differenza di altri paesi dell’Unione Europea in Italia non è previsto alcun sistema diretto alla disoccupazione e all’inserimento al lavoro di “reddito sociale garantito” per chi non ha lavoro e vive in condizioni di estrema povertà, non potendo essere annoverato tra queste forme di sussidio il cosiddetto “Minimo vitale” attualmente in via di sperimentazione. Nel nostro Paese tra i cosiddetti “ammortizzatori sociali” stabiliti per tutelare la sospensione del rapporto di lavoro, il licenziamento collettivo od individuale, è previsto il sussidio ordinario di disoccupazione dovuto ai lavoratori licenziati (non iscritti alle liste di mobilità) che abbiano operato nei due anni precedenti il licenziamento per almeno un anno e che possiedano almeno due anni di anzianità contributiva. Il valore di questo sussidio corrisponde oggi a circa il 30% dell’ultimo salario percepito, ha una durata massima di sei mesi per i lavoratori licenziati e di tre mesi per i lavoratori al nero o che abbiano lasciato il lavoro di propria volontà. La legge Finanziaria del 1996 ha stabilito delle misure di sostegno per i lavoratori in alcuni settori soggetti a privatizzazione (banche, trasporto pubblico) demandando alla contrattazione collettiva la definizione dei criteri di assegnazione di questi sussidi. Si tratta comunque di tipologie di sostegno ai disoccupati legate a situazioni specifiche e non possono essere quindi in alcun modo confrontate con quelle esistenti negli altri Paesi europei. Si rileva nel nostro Paese, in sostanza, la totale mancanza di assistenza finale oltre il primo intervento per la perdita del lavoro (ed anche per questo “primo intervento” i tassi medi di copertura sono molto bassi e non omogenei tra i vari settori). I risultati di un’inchiesta svolta tra i paesi dell’U.E. dalla OECD Employment Outlook nel 1996, rilevano che in Italia (includendo la Cassa Integrazione Guadagni e il prepensionamento) circa l’80% dei disoccupati non riceve alcuna forma di sussidio economico. E’ interessante osservare che la Spagna, paese con il maggiore tasso di disoccupazione giovanile all’interno della Comunità Europea, presenta sussidi alla disoccupazione complessivamente tre volte superiori a quelli del nostro Paese. La discriminazione esistente tra i lavoratori delle grandi imprese industriali (che hanno garantito l’accesso ai sussidi ) rispetto agli altri lavoratori è evidente se si pensa che nel 1996 in Italia circa 100.000 lavoratori risultavano essere in Cassa Integrazione straordinaria a zero ore, 300.000 erano in liste di mobilità e vi erano circa 6 milioni di iscritti al collocamento. Nel 1996 gli interventi sul mercato del lavoro hanno rappresentato per il nostro Paese l’1,8% circa del PIL, a fronte del 3,8% della Germania, del 3,3% della Francia, del 3.6% della Spagna e del 2,2% del Regno Unito. Sempre in Italia nel 1997 si sono ridotte le spese per gli ammortizzatori sociali : rispettivamente del 4,6% per l’indennità ordinaria di disoccupazione e del 2,5% per la Cassa Integrazione Guadagni. Anche per quanto riguarda gli oneri sociali si è accentuata in questi ultimi anni la quota a carico dei lavoratori per il finanziamento della sicurezza sociale. Le prestazioni sociali a favore delle famiglie disagiate per consentire loro di far fronte a determinati eventi associati alla malattia, alla vecchiaia, alla maternità, all’invalidità, alla disoccupazione ecc. rappresentano quindi un elemento fondamentale nella politica economica ed è importante analizzare e confrontare l’atteggiamento dei diversi paesi. Va rilevato che anche se l’Europa spende una quota superiore al Giappone e agli Stati Uniti per la sicurezza sociale, vi sono al suo interno differenze sostanziali tra i vari Paesi. Mentre fino al 1991 la quota dei contributi sociali è pressoché costante nei paesi dell’UE (ad eccezione del Regno Unito nel quale sono decrescenti), si nota un aumento dei valori fino al 1994, anno in cui la tendenza cambia e si registra una notevole flessione. Lo stesso andamento si rileva per le spese inerenti le prestazioni di protezione sociale e le spese sanitarie (dal 1995 in poi si registra una notevole riduzione di queste prestazioni in tutti i paesi dell’U.E.). Per quanto riguarda gli assegni familiari i dati testimoniano che paesi come il Lussemburgo, la Finlandia, Il Belgio contribuiscono maggiormente nelle indennità; invece tra i paesi che contribuiscono in misura inferiore troviamo la Spagna, la Grecia, Il Portogallo. Ad esempio il valore degli assegni familiari segue una tendenza che cresce fino al 1993 per poi diminuire nel 1994; l’Italia con l’Olanda è tra i paesi che registra quote di spesa più bassa fra i paesi dell’UE. Per la spesa sanitaria si registrano i valori più bassi dell’area comunitaria europea in Grecia ed in Irlanda mentre le quote più alte sono da imputarsi alla Francia e la Germania; l’Italia che ha evidenziato valori crescenti dal 1986 al 1994 ha registrato nel 1995 e 1996 una consistente diminuzione (si passa da una percentuale dell’8,4% nel 1994 al 7,6% nel 1996). Nella Tab.6, il Graf. 27 e il Graf.28 sono rappresentati gli andamenti dell’ammontare delle prestazioni sociali a favore dei disoccupati che evidenziano differenze sostanziali tra i vari paesi; ad esempio in Italia e nel Regno Unito si è avuta nel periodo 1984-1989 una diminuzione elevata delle spese sociali (per l’Italia del 40% e per il Regno Unito del 60%), in altri paesi come la Francia si registra una tendenza all’aumento. Se poi ci si sofferma ad analizzare la spesa a favore dei disoccupati in termini di percentuale del PIL (prendendo come esempio i dati dell’anno 1992) ci si accorge che l’Italia risulta essere il paese che ha speso meno dell’0,5% del PIL per le prestazioni sociali a favore dei disoccupati, anche se il tasso di disoccupazione è stato superiore alla media europea. La Danimarca, l’Olanda e il Belgio invece sono i paesi che hanno impiegato la percentuale più elevata del PIL per la disoccupazione (rispettivamente il 3,7%, il 2,7% e il 2,6%).
7. Le politiche salariali
I paesi dell’Unione Europea affrontano in modo diverso le dinamiche legate all’andamento salariale: in Germania la presenza dei sindacati e dei Consigli di fabbrica porta a contrattazioni tendenti a ridurre differenze salariali tra i vari settori ma anche al rinnovo annuale dei contratti essendo vietata qualsiasi forma di indicizzazione. In Francia le leggi impongono agli imprenditori la contrattazione annuale dei salari effettivi, dell’organizzazione e degli orari di lavoro, mentre nel Regno Unito sono state emanate leggi che tendono ad eliminare dal mercato qualsiasi tipo di influenza e soprattutto il peso dei sindacati, demandando tutto alla “divinità e saggezza” del mercato. La Svezia invece si contraddistingue per il fatto che la dinamica dei salari è legata alla produttività settoriale attraverso anche forme concertative autoregolamentate dai sindacati. Il Graf.29 analizza le retribuzioni orarie medie lorde (si intendono retribuzioni lorde le remunerazioni a carico del datore di lavoro prima della detrazione delle imposte, le ammende e i contributi di previdenza sociale a carico dei lavoratori) degli operai nell’industria; va ricordato che per operai si intendono i lavoratori manuali legati all’impresa da un contratto di lavoro (sono esclusi i capisquadra, i lavoratori a domicilio, i coadiuvanti familiari e gli apprendisti). Il grafico mostra una generale tendenza alla crescita di salari reali nei vari paesi in particolare in Germania e in Lussemburgo, ma come si vedrà nel prossimo numero di PROTEO, in tutti i paesi tale crescita non ha mai realizzato una pari ed equa redistribuzione al lavoro degli incrementi di produttività, sia totale ma anche del solo lavoro, realizzata nello stesso periodo.
In Italia, nel dopoguerra si è avuta una fase di contrattazione centralizzata che definiva le differenziazioni e i livelli salariali e si deve arrivare agli anni ‘70 (periodo di grande conflittualità sociale) per avere una regolamentazione dell’orario di lavoro, delle assunzioni e dei licenziamenti. La crisi economica che ha investito il nostro Paese dalla metà degli anni ‘70 alla fine degli anni ‘80, ha portato a gestire di nuovo a livello centrale il sistema di contrattazione. Lo sviluppo della concertazione triangolare (sindacato, impresa, governo) ha portato alla nascita della cosiddetta “politica dei redditi”. Nel 1993 l’accordo sul lavoro ha eliminato i meccanismi automatici di adeguamento dei salari all’inflazione (la cosiddetta scala mobile) e ha stabilito la determinazione degli aumenti salariali nazionali e la non specificità o sovrapposizione dei livelli contrattuali per consentire che i livelli di contrattazione (nazionali per categoria e aziendali) siano coordinati e complementari l’uno all’altro. Questa politica ha evidenziato la necessità di fissare più chiaramente la redistribuzione di riferimento, ossia la parte di salario reale che dovrebbe essere salvaguardata dall’inflazione.
|