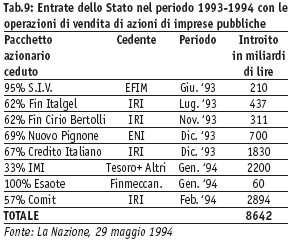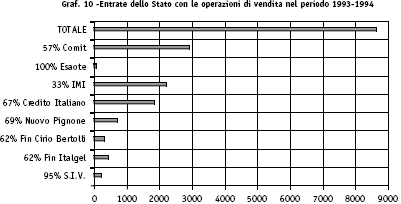![]()
Rubrica
L’analisi-inchiesta
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Luciano Vasapollo Docente di Economia Aziendale, Fac. di Scienze Statistiche, Università’ “La Sapienza”, Roma; Direttore Responsabile Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali (CESTES) - Proteo.
I diversi modelli del capitalismo internazionale si confrontano sulle strategie di privatizzazione Le diverse forme di privatizzazione Privatizzazioni e mercati finanziari La via alle privatizzazioni nel modello capitalistico italiano. Un’indagine statistico-aziendale
Tutti gli articoli della rubrica: analisi-inchiesta(in tutti i numeri di Proteo)
|
In questo ambito è utile anche fornire un quadro esemplificativo delle entrate che lo Stato ha già incassato nella fase di privatizzazioni che si è avuta nell’arco di tempo 1993 - inizio 1994 (Cfr. Tab.9 e Graf.10).
Abbandonata, poichè palesemente non credibile, la pista dell’aggancio formale alla riduzione del debito pubblico, il Governo ha definito altrimenti gli obiettivi da privilegiare nel programma di dismissioni. Tra questi, ha assunto un certo peso la creazione di un azionariato diffuso, soprattutto con riguardo alle aziende finanziarie e a quelle di pubblici servizi. Più che di un obiettivo in se, tuttavia, la diffusione dell’azionariato sembra essere per il debole modello del capitalimso finanziario italiano lo strumento essenziale per favorire l’ispessimento dei mercati finanziari. Non a caso, il decreto Ciampi, che pure “inneggiava” alla tutela dell’azionariato diffuso tramite la previsione di limiti massimi al possesso delle azioni (articolo 4) e la garanzia della rappresentanza degli interessi delle minoranze (articolo 5), non ha incluso misure specifiche volte a promuovere e difendere la natura “popolare” della proprietà. Non sembra cioè, almeno in linea di principio, che alla diffusione dell’azionariato si attribuisca anche una valenza strettamente politica, simile a quella implicita nelle privatizzazioni britanniche, miranti tra l’altro a consolidare per questa via il consenso alla politica liberista del governo. Anche il riconoscimento della strategicità dei pubblici servizi non è tuttavia da intendersi come interesse collettivo al potenziamento delle relative aziende, tramite una regolamentazione in grado di garantire la massimizzazione dell’efficienza, in condizioni di monopolio naturale e di realizzazione di rilevanti investimenti a redditività differita. Questa concezione della natura strategica dei servizi pubblici sembra esser stata abbandonata in favore di un’impostazione difensiva, che risolve nella conservazione della missione aziendale (e nella modifica in senso concorrenziale della regolamentazione) la giustificazione della partecipazione pubblica al capitale. Resta irrisolto il problema relativo alle politiche che verranno adottate alla scadenza dei poteri speciali garantiti dall’azione specifica, la cui durata è limitata a cinque anni. Dall’altra il Governo considera le privatizzazioni un’opportunità non trascurabile per procedere al rafforzamento della grande industria, che deve essere messa in condizione di affrontare e sostenere la competizione internazionale e di consolidare gli assetti produttivi e occupazionali nazionali. Per questo, si ritiene indispensabile il ricorso ad acquirenti privati che presentino requisiti adeguati di vocazione imprenditoriale e solidità industriale e che siano in grado di predisporre e realizzare programmi di rafforzamento credibili; ciò si traduce in un forte intervento del capitale, industriale e soprattutto finanziario, internazionale. Anche per quanto riguarda l’obiettivo di potenziamento dell’industria nazionale, la posizione del Governo Ciampi si differenzia significativamente da quella contenuta nel Piano Amato, che configurava la creazione di alcuni gruppi a maggioranza pubblica in comparti particolarmente significativi, il rafforzamento di questi gruppi avrebbe dovuto consentire di impostare e finanziare successivi disegni di politica industriale. L’intento dell’Esecutivo Ciampi è stato, invece, quello di procedere alla formazione di nuove realtà industriali mediante la privatizzazione integrale e quindi la rinuncia alla partecipazione pubblica nel capitale. Non viene perciò negata l’importanza strategica di alcuni comparti, ma lo strumento per garantirne il potenziamento è identificato nella capacità del Governo di decidere la cessione “sulla base di una attenta ponderazione delle diverse alternative, inclusa la possibilità di alleanze sia nazionali sia internazionali”. Verranno considerate strategiche quelle aziende che condizionano, per dimensioni o rilevanza settoriale, la sopravvivenza o le possibilità di sviluppo dell’intero comparto cui appartengono. Inoltre, secondo quanto dichiarato da Ministero dell’industria durante l’audizione presso la Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati svoltasi il 9 novembre 1993, il Governo ha considerato prioritario il mantenimento in Italia dei centri decisionali delle aziende privatizzate, privilegiando la cessione del pacchetto di maggioranza ad investitori italiani. Anche questo si è rivelato un “bluff”, poichè nella realtà non si sono voluti assolutamente privilegiare i compratori italiani rispetto ai potenziali concorrenti esteri. Eventuali misure orientate a favorire gli investitori nazionali sarebbero state infatti inammissibili alla luce delle politiche comunitarie di difesa e incremento della concorrenza. Per meglio affrontare il fenomeno privatizzazioni, il mercato finanziario mondiale, o meglioil capitale a spiccato connotato finanziario, si è attrezzato; sono nati “fondi chiusi”, i fondi pensione, i fondi immobiliari ecc., tutti specializzati nel trattare titoli di imprese in via di privatizzazione.
3. Alcuni “casi-studio”Nel prossimo numero di PROTEO, come già precedentemente scritto, continuerà l’analisi-inchiesta sulle privatizzazioni, con approfondimenti e casi-studio trattati in un articolo della dott.ssa Rita Martufi. Di seguito si affronteranno dei casi-studio più significativi semplicemente al fine di introdurre il lettore nelle realtà aziendali che per prime hanno dato l’avvio al processo di privatizzazione nel nostro Paese.
Il caso SME
Dopo i tentativi falliti di vendere il gruppo SME negli anni ’80, l’IRI, nell’ambito del nuovo programma di privatizzazione, ha mostrato la ferma volontà di attuare la completa dismissione di questo gruppo industriale. Va ricordato che nelle operazioni di vendita si è scelto di procedere attraverso delle trattative private anziché costituire una public companies; ciò principalmente per due motivi: da un lato l’esigenza dell’IRI di massimizzare i ricavi (considerato il fatto che il gruppo SME era in buone condizioni finanziarie), in secondo luogo perché ormai da qualche anno rappresentava un’attività marginale per l’IRI. Il gruppo SME è stato quindi scisso in tre società per le quali sono state adottate tecniche di dismissione diverse. La prima società, l’Italgel S.p.A, è stata messa in vendita attraverso un’asta competitiva, che ha assegnato il 62% di questa società alla Nestlè. L’intento della Nestlè era chiaramente quello di rafforzare la propria posizione in Italia nei settori dei prodotti surgelati e dei gelati. Anche il secondo gruppo di imprese, rispettivamente la Cirio, la Bertolli e la De Rica è stato venduto attraverso una trattativa privata. A differenza della vendita dell’Italgel però sono sorte delle complicazioni e delle polemiche dovute principalmente al fatto che la società acquirente la Fisvi era una piccola finanziaria agroalimentare che non presentava sufficienti garanzie economiche (al momento della vendita la Fisvi possedeva un capitale di 53 miliardi, contro i 310 che avrebbe dovuto pagare alla SME). Per il terzo gruppo, GS-Autogrill, sono ancora in corso alcune operazioni relative alla sua completa vendita.
Nuovo Pignone
La dismissione del Nuovo Pignone si è perfezionata nel 1993 con la vendita del pacchetto azionario della società ad una impresa multinazionale americana, la General Electric, che aveva concorso con altri tre competitori : la Gec Alsthom (franco-inglese), l’ABB (svizzera-svedese) e la Dresser-Gersoll (americana). Va rilevato che la General Electric si è impegnata a rispettare la piena autonomia gestionale e l’integrità produttiva dell’azienda. L’ENI ha venduto solo il 70% della Nuova Pignone, e non l’intera quota azionaria, con l’intenzione di mantenere i legami di carattere tecnologico e commerciale esistenti tra questa impresa e i settori strategici dell’ENI.
ENI
L’ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) è stato istituito nel 1953 come Ente di diritto pubblico che agisce nei settori del petrolio e del gas naturale. Rappresenta una delle più grandi compagnie integrate nelle attività di ricerca e produzione di idrocarburi, di produzione e vendita di prodotti petrolchimici, di ingegneria e servizi, di approvvigionamento, trasporto e distribuzione di gas naturale di raffinazione e distribuzione di prodotti petroliferi. Le attività dell’ENI sono svolte attraverso sei grandi società : Agip, Snam, Agip Petroli, Saipem, Snam progetti ed Enichem, in 84 paesi. L’attività di ricerca e produzione di idrocarburi svolta attraverso l’Agip è sviluppata in Italia, in Africa (settentrionale ed occidentale), nel Mare del Nord, in Cina, negli USA e nei paesi dell’Ex Unione Sovietica; nel 1996 risultava essere al settimo posto (in termini di riserve) tra le imprese operanti nel settore del petrolio e del gas naturale. L’ENI è, attraverso la Snam, il primo fornitore di gas naturale in Italia e il secondo in Europa (in termini di volumi venduti sul mercato nazionale); detiene inoltre il 41% della Italgas (distribuzione ai consumatori finali di gas naturale) e nel 1995 ha acquisito il pacchetto di maggioranza della Tigaz, la maggiore società regionale di distribuzione del gas ungherese. Con l’Enichem, inoltre l’Eni è ai vertici europei nella produzione di etilene e di gomme stirene butadiene; l’attività di raffinazione e commercializzazione di prodotti petroliferi è svolta attraverso l’Agip Petroli. Nel 1996 l’ENI ha acquisito una quota del 16.3% della società Ceska Rafinerska A.S. (repubblica Ceca); l’Agip Petroli opera anche in Africa ed in Estremo Oriente. Con la Saipem l’ENI si colloca tra i maggiori operatori a livello mondiale nei settori di offshore, installazione di piattaforme e condotte sottomarine, mentre attraverso la Snam progetti si è specializzata nella fornitura di servizi all’industria petrolifera e chimica.
|