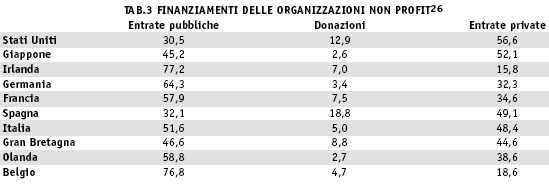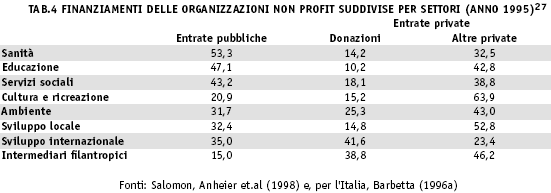![]()
Rubrica
L’analisi-inchiesta
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Luciano Vasapollo Docente di Economia Aziendale, Fac. di Scienze Statistiche, Università’ “La Sapienza”, Roma; Direttore Responsabile Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali (CESTES) - Proteo. Rita Martufi Consulente ricercatrice socio-economica; membro del Comitato Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico Sociali (CESTES) - PROTEO
“The Federal Business Revolution”
Tutti gli articoli della rubrica: analisi-inchiesta(in tutti i numeri di Proteo)
|
Vi sono poi le cooperative sociali (legge 381/91) che hanno come scopo "il perseguimento di un fine che è esterno al gruppo sociale che le costituisce, ossia l’interesse sociale alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, diversamente dal perseguimento degli interessi dei soci della cooperativa" [1]. Normalmente i settori che interessano queste cooperative sono quelli socio-sanitari e quelli relativi all’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati. In queste cooperative vi sono soci volontari (che prendono solo il rimborso spese), soci prestatori (retribuiti) e soci fruitori (i diretti beneficiari dell’azione della cooperativa. Anche queste cooperative godono di benefici fiscali. Le organizzazioni non-profit hanno assunto un ruolo fondamentale anche nei paesi del Terzo Mondo; sono decine di migliaia le associazioni che si occupano di interventi nei paesi in via di sviluppo e riguardano i settori più disparati: dalla sanità, alla lotta alla fame, allo sviluppo rurale, alla assistenza e pianificazione familiare, alla promozione dello sviluppo economico. Se si analizza più da vicino il settore non profit negli Stati Uniti va ricordato che in questo paese vi sono delle differenze tra gli enti che agiscono per fini caritatevoli o pubblici (public benefit corporations), enti che rappresentano gruppi o categorie (trade associations, fraternal orders, mutual benefit societes) ed infine enti che agiscono con scopi prettamente religiosi (religious corporations); di queste solo le prime e quelle religiose possono godere dei privilegi di esenzione fiscale. Il grant system è il sistema di contribuzioni pubbliche al settore non profit; vi sono le agenzie (agencies) che sono intermediarie fra il pubblico e il privato e che presentano le "proposte pubbliche"; gli enti e le associazioni espongono le loro offerte che vengono analizzate da queste agenzie che decidono poi a chi dare le sovvenzioni. Vi è poi il sistema del contracting out; in questo caso le agenzie ricorrono a istituzioni private per raggiungere un determinato obiettivo con maggiore facilità (ad esempio quando si tratta di trattamento di tossicodipendenze, di alcolisti, per l’assistenza alla terza età, ecc.) Se ci si riferisce a dati del 1995 si rileva che le organizzazioni non profit occupavano quasi 19 milioni di persone (retribuiti) ai quali si aggiungono le quasi dieci milioni di persone che prestavano servizio come volontari. È interessante notare che i paesi sviluppati impiegano più persone nelle organizzazioni non profit (il valore è del 6,9% dell’occupazione totale) rispetto ai paesi in via di sviluppo I valori vanno dall’1,6% al 2,2%); il settore non profit inoltre sembra essere in grado di generare nuova occupazione ad un tasso decisamente superiore (4%) rispetto agli altri settori dell’economia (1%). [2] Questi dati non devono però indurre a facili ottimismi in quanto è necessario ricordare che le organizzazioni del non profit sono concentrate solo sul settore dei servizi essendo del tutto assenti nella produzione di beni manifatturieri o nel settore agricolo; va inoltre rilevato che i servizi che queste associazioni offrono sono diretti alla persone o alle collettività ma mai alle imprese. Le associazioni non profit infatti si concentrano soprattutto nella sanità, nella cultura o ricreazione e nell’educazione. Queste associazioni sono finanziate prevalentemente da fonti pubbliche (39,3%) e private (48,2%) in quanto le donazioni sono molto esigue (12,5%) La tabella seguente mostra come in paesi quali gli Stati Uniti, il Giappone e la Spagna queste organizzazioni abbiano forti entrate di fonte privata mentre per gli altri paesi europei di solito è la fonte pubblica ad essere prevalente. (Cfr. Tab.3 [3]).
Ed ancora è interessante vedere quali sono i settori nei quali il finanziamento pubblico ha più rilevanza (Cfr. Tab.4 [4])
I dati evidenziano che le donazioni influiscono poco sulle dotazioni economiche di queste imprese mentre un ruolo predominante è assunto dal pubblico seguito dalle entrate provenienti dai privati. Solitamente lo Stato sostiene maggiormente le associazioni che operano nell’ambito della sanità, di servizi sociali e dell’educazione mentre i privati finanziano maggiormente le organizzazioni che agiscono nell’ambito dell’ambiente, della cultura e a livello locale. Le donazioni invece sono soprattutto rivolte ad organizzazioni che agiscono nell’ambito di aiuti internazionali ed operano in ambito umanitario. Ed ecco che si ritorna al sempre più attuale principio della sussidiarietà per il quale le fonti pubbliche con i loro finanziamenti devono far funzionare queste associazioni che hanno il compito di operare laddove lo Stato non riesce ad arrivare (non riesce o meglio si è deciso ormai il non intervento). Di solito infatti, i fondi pubblici vengono utilizzati per sostenere la somministrazione di servizi sanitari, sociali ed spesso diventano così importanti da sostituire la presenza dello Stato in questi servizi. Basti a questo proposito ricordare il caso ad esempio della sanità negli Stati Uniti, Paese in cui ogni forma di protezione sanitaria è affidata a organizzazioni ed assicurazioni private. Occorre quindi stare molto attenti ai facili ottimismi che lo sviluppo del non profit potrebbe produrre e ricordare che l’affermazione della sussidiarietà porta con sé la sostituzione del privato al pubblico con i pericoli e i rischi che questo può comportare. È per questo che lo Stato anche nel nostro Paese ricorre sempre più ai processi di privatizzazione delle imprese pubbliche o degli enti locali. È importante infatti sottolineare che anche le imprese del terzo settore, o non profit come le si voglia chiamare, nonostante il favore con il quale vengono viste da molti, molto spesso non sono altro che imprese come le altre che producono utili e hanno come scopo quello di espandere il loro capitale e la loro presenza sul mercato; anche i servizi o i beni che queste imprese producono sono di solito soggetti alle normali regole di compravendita nel mercato. Infatti "non sono rari i casi di imprese non profit che sono tali solo formalmente perché gli utili, pur dando luogo a dividendi, si traducono in vari tipi di guadagno per i dirigenti danno luogo comunque ad accumulazione di potere economico. Nel mondo non profit, anche in Italia, ci sono vere e proprie holding finanziarie. Per non parlare dei casi in cui la formula non profit è di fatto associata a regimi lavorativi e fiscali, sostanzialmente, se non formalmente, illegali e selvaggi: vi si annidano sacche di sfruttamento di lavoro sottopagato mascherato da volontariato". [5] In Italia comunque si è in presenza di una sempre più estesa tendenza a riformare il sistema di Stato sociale seguendo il principio della sussidiarietà; questo comporta il fatto che in settori quali assistenza e sanità, lo sviluppo occupazionale del terzo settore tende a sostituire il pubblico con il privato. In sostanza quindi il tanto decantato aumento di occupazione che porterebbe il settore non profit rischia di diventare una semplice sostituzione tra lavoratori pubblici e lavoratori occupati. Oltre a questo, visti i delicati settori che il non profit va a toccare (sanità, assistenza, cultura, educazione) lo sviluppo di imprese nel terzo settore implica la privatizzazione di ambiti da sempre appannaggio dello Stato e del pubblico in generale. Va ricordato che l’obiettivo delle aziende pubbliche non va ricercato nella massimizzazione del profitto ma in una diversa serie di traguardi che devono essere raggiunti in nome dell’interesse della collettività. È chiaro che pur dovendo queste aziende raggiungere dei risultati di gestione positivi, è comunque necessario tenere in seria considerazione tutti i fattori collegati all’economia nazionale e all’interesse economico e sociale generale. In questo senso si può dire che un’impresa pubblica ha tra i suoi obiettivi principali il raggiungimento dell’efficienza allocativa, redistributiva e sociale che permettano di rendere massima la soddisfazione dei consumatori, di assicurare la maggiore trasparenza possibile e di correggere i fallimenti del mercato. Va ora effettuato un attento esame delle privatizzazioni degli enti pubblici locali [6], fenomeno che nel nostro Paese sta ormai diventando sempre più attuale. La prima norma che ha regolato il passaggio della gestione dei servizi pubblici locali è sta la legge 142/90 che prevede, all’art. 22, 3° comma, lett. e, la possibilità di utilizzare la società per azioni a maggioranza pubblica del capitale. Tra i motivi che vengono addotti per giustificare il passaggio dal pubblico al privato vi è in primo luogo l’idea che in questo modo sia possibile migliorare il servizio e sviluppare diverse e nuove capacità organizzative. In questo senso il progetto di privatizzazione può avvenire sia a livello generale dell’ente, sia a livello di una singola funzione e infine a livello di singolo servizio. "Retrocede lo Stato amministratore dei servizi pubblici per via diretta o indiretta, cioè attraverso propri organismi strumentali. Avanza invece lo Stato regolatore. Questo è l’aspetto principale del processo di liberalizzazione dei servizi pubblici. Con tutti i problemi consequenziali che si pongono, naturalmente anche per i servizi pubblici locali, che assumono qui un rilievo particolare e forse una maggiore complessità [7]" [1] Cfr. CNEL, Rapporto su: Statualità, mercato..., op. cit., pag. 87. [2] Cfr. Barbetta G.P., Il settore non profit italiano, settembre 2000, il Mulino. [3] Cfr. Barbetta G.P., "Il settore non profit...", op. cit. [4] Cfr. Barbetta G.P., "Il settore non profit...", op. cit., pag. 60. [5] Cfr. Ota de Leonardis, "In un diverso...", op. cit. pag. 71. [6] "Da un punto di vista storico si può dire che il termine "privatizzazione" esprime innanzitutto la tendenza alla riduzione del ruolo dello Stato e degli enti pubblici nell’ambito dell’economia. Le esperienze finora citate, invece, hanno costituito e ancora costituiscono un filone importante del regime di economia mista che ha caratterizzato il rapporto fra Stato e mercato nel nostro e in altri Paesi per una lunga fase storica, dalla cui uscita il termine "privatizzazione" è divenuto praticamente il sinonimo. Nel caso dei servizi pubblici, al contrario, il termine "privatizzazione" ha acquistato una particolare enfasi dal momento che essa si riferisce ad attività tradizionalmente rientranti nei compiti dell’ente pubblico locale sulla base di una consolidata tradizione anche politica: si ricordi infatti quel "socialismo municipale" che in epoca ormai lontana diede segno di sé alle prime municipalizzazioni dei servizi pubblici locali anche se non deve essere dimenticato che, in epoca successiva, l’utilizzazione della S.p.A. come metodo di gestione dei servizi pubblici locali venne espressamente prevista dal Testo unico sulla finanza locale del 1934", in F. Cavazzuti: Privatizzazioni comunali, Impresa e Stato n. 42. [7] Cfr. Quadro Curzio A., Fortis M.," Le liberalizzazioni e le ...", pag. 104.
|