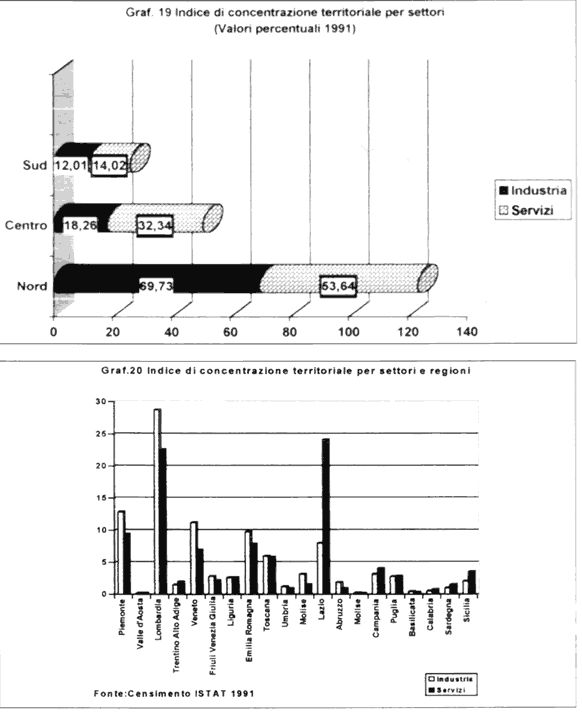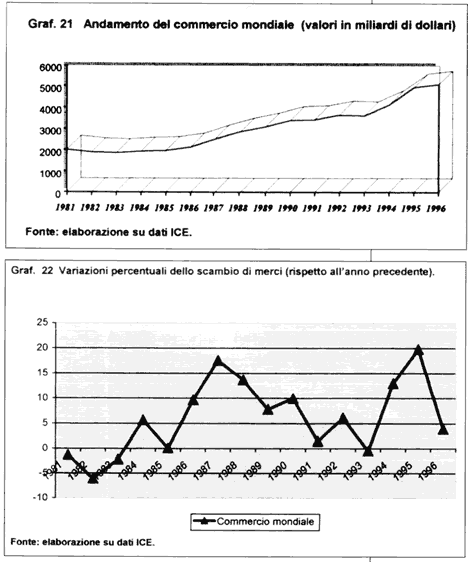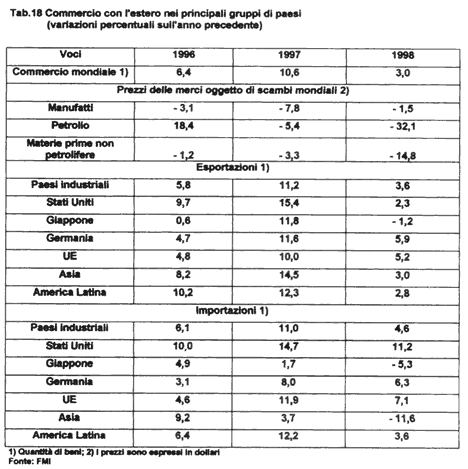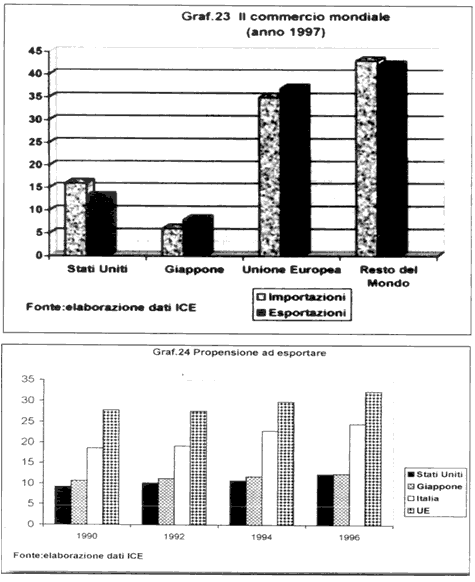![]()
Rubrica
L’analisi-inchiesta
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Luciano Vasapollo Docente di Economia Aziendale, Fac. di Scienze Statistiche, Università’ “La Sapienza”, Roma; Direttore Responsabile Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali (CESTES) - Proteo. Rita Martufi Consulente ricercatrice socio-economica; membro del Comitato Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico Sociali (CESTES) - PROTEO
Le Tendenze macroeconomiche del processo di ristrutturazione capitalistica
Tutti gli articoli della rubrica: analisi-inchiesta(in tutti i numeri di Proteo)
|
E’ da rilevare che questi dati sono in realtà sottostimati rispetto al numero reale delle “piccole multinazionali”, poiché molte iniziative minori non sono prese in considerazione dalle banche dati. Va comunque rilevato che le “piccole multinazionali” hanno privilegiato i paesi dell’Europa Centro ed Orientale, ed invece meno attrattivi risultano essere i paesi dell’Unione Europea. Costi di produzione più contenuti, in particolare basso costo del lavoro coniugato a molto buoni livelli di specializzazione della manodopera una migliore qualità del prodotto grazie ad un buon livello di conoscenza economico-produttiva e una appropriata competenza aziendale acquisita dalle imprese locali, sono tra i motivi principali che inducono le imprese italiane a privilegiare i paesi dell’Est europeo per avviare nuovi stabilimenti o per acquisirne di già esistenti. E’ interessante ora esaminare alcuni settori in modo dettagliato per comprenderne più significativamente l’evoluzione. Per il tessile, abbigliamento, cuoio e prodotti in cuoio si è avuto, dalla metà degli anni’80 un forte sviluppo del processo di industrializzazione; in poco meno di 10 anni il numero dei dipendenti delle partecipazioni italiane all’estero è passato da 12 mila a quasi 49 mila unità. L’area territoriale interessata da questo fenomeno include la Francia, la Germania, la Spagna e gli Stati Uniti; in Germania, ad esempio, vi sono state importanti acquisizioni a forte ricaduta sugli assetti produttivi globali. In questi ultimi anni, inoltre, si è avvertita la necessità di creare nuovi equilibri nel rapporto efficienza - costo delle risorse umane, attuando nuove strategie di delocalizzazione dei cicli produttivi caratterizzati da una mole maggiore di lavoro e da un forte impatto ambientale con la conquista di nuovi mercati locali. Per queste ragioni gli investimenti sono stati realizzati nell’Europa Orientale, dove, allo stesso tempo, esistevano salari reali più bassi, un discreto livello qualitativo di risorse umane e distanze chilometriche non troppo elevate. Il settore alimentari e bevande ha subito un elevato processo di espansione che ha portato ad incrementare di sei volte il numero degli addetti aderenti alle partecipazioni all’estero. La spinta di questo sviluppo, contrariamente a quanto è avvenuto per la moda italiana, è rappresentata dalla speranza soprattutto di conquistare i mercati locali. Per quanto riguarda l’estensione geografica, il fenomeno di internazionalizzazione ha coinvolto soprattutto l’Europa Occidentale; infatti nel 1996 si è registrato un numero di addetti pari al 63,2% del totale, questo risultato lo si deve agli investimenti effettuati soprattutto dalla Montedison, dalla San Carlo e dalla Ferrero. Contrariamente alla situazione appena descritta, nel Nord America si sono verificati fenomeni di contrazione del settore. Quello dei prodotti in gomma e in plastica è l’unico settore che in questi ultimi anni ha fatto registrare un calo assoluto del numero di addetti. La causa principale di questa diminuzione è la dismissione della Pirelli e la decisione di dedicare la sua attività alla creazione di cavi e pneumatici. L’estensione territoriale riguarda, in modo particolare, l’Europa Occidentale, l’America Latina e l’area del Pacifico. Nel 1992 si è avuto un forte sviluppo internazionale del settore dell’estrazione e lavorazione dei minerali non metalliferi grazie all’acquisizione da parte di Italcementi del gruppo Ciments Français. Sotto l’aspetto geografico, invece, agli inizi del 1996, la netta predominanza spetta all’Europa Occidentale con il 48% degli addetti, seguita dall’Europa Centrale e Orientale con il 24% e dal Nord America con il 16% del totale. Un ruolo marginale è rivestito dall’America Latina a causa dell’abbandono del gruppo Ferruzzi. In questi ultimi anni il settore chimico-farmaceutico si è indebolito a causa di alcuni importanti scorpori e scissioni. Un’azione di sostegno l’hanno svolta le piccole e medie imprese specialistiche che sono riuscite a crearsi un mercato di nicchia specializzato all’interno di quello mondiale. Per quanto riguarda l’aspetto geografico questo tipo di collaborazioni si sono sviluppate, in modo particolare, nell’Europa Occidentale e nel Nord America, penalizzando l’Asia e l’Africa. Il settore dell’automobile ha sempre svolto un ruolo importante soprattutto nel nostro Paese, infatti solo la produzione dei veicoli su gomma, nel 1996, impiegava 94 mila addetti in imprese estere; tutto questo grazie alla Fiat e all’Iveco. L’America Latina assorbe circa il 30% degli occupati, mentre l’Europa Orientale e Centrale ne accolgono il 19%. Infatti il Brasile e l’Europa Orientale sono i paesi verso cui si è orientato il processo di internazionalizzazione attuato dai nostri produttori, i quali non prediligono i mercati nord americani, principali obiettivi di imprese automobilistiche giapponesi e tedesche. Ma nel 2000 la situazione tenderà a modificarsi, poiché in molti paesi tra i quali l’Italia verranno aboliti gli ultimi ostacoli ancora esistenti per le importazioni automobilistiche nipponiche, e ciò tenderà ad inasprire ancora di più la concorrenza sul mercato nazionale ed europeo. Negli anni’80 circa l’85% degli addetti impiegati nelle industrie italiane all’estero nel settore dei cavi ed in genere dell’elettromeccanica e prodotti elettrici erano dipendenti della Pirelli e Fornara, e la maggior parte svolgevano la loro attività in America Latina: Brasile, Argentina, Messico e Perù presso l’Ansaldo e Bassani Ticino. Con il trascorrere degli anni questo settore si è esteso anche all’Europa attraverso le industrie di elettrodomestici e elettrosanitari, come Candy, Merloni Elettrodomestici e Merloni Eelettrosanitari. Durante la seconda metà degli anni’80, nei settori dell’ elettronica, telecomunicazioni, macchine per ufficio e strumentazione, si sono verificate un numero consistente di fusioni con un’espansione geografica che ha riguardato l’Europa Occidentale (54% degli addetti) e il Nord America (26% degli addetti). Questo processo ha subito una brusca frenata tra il 1990 e il 1996, infatti il numero degli occupati delle imprese italiane all’estero si è notevolmente ridotto in Europa Occidentale a causa dell’abbandono, da parte dell’Olivetti e della Stet.
1.4. Lo scontro tra i poli USA e UE
Tutti i fenomeni connessi alla mondializzazione finanziaria sono perni del progetto dell’Unione Europea così come si sta costruendo e l’attuale contesto della situazione economica e sociale a livello mondiale così come è fa crescere il dissenso statunitense all’UE. Si è ormai presa coscienza specialmente da parte degli USA e della Gran Bretagna, che è tempo di vedere un’Europa sempre più in crisi, poiché tale grande mercato può offrire prospettive di sviluppo neoliberiste in alternativa al polo imperialista anglosassone che nelle aree dell’Europa centro-orientale, dell’Africa mediterranea e di molti paesi dell’Asia centrale avrà sempre meno voce in capitolo. L’euro è inscritto in una logica mercantilistica, poiché mira a creare un blocco regionale europeo in grado di competere con Stati Uniti, Giappone e Asia anche se apparentemente la globalizzazione invece significa apertura dei mercati e delle frontiere. Basta guardare, ad esempio, al vertice di Rio, conclusosi dopo la guerra NATO alla Jugoslavia, in cui l’UE ha posto le basi per la creazione di un’area transatlantica di libero scambio con l’America Latina, in assenza degli USA, anzi in aperto contrasto con l’Alca, il concorrente interamericano. Il vertice di Rio ha avuto il dichiarato scopo di contrastare a livello economico internazionale l’egemonia dell’imperialismo statunitense nell’area dell’America Latina in un’area in cui l’export USA è tre volte maggiore di quello UE (per non parlare dei movimenti di capitale), ma dove tale supremazia non è più incontrastata né sul piano commerciale né su quello degli investimenti. Si pensi che nel ’90 gli IDE (investimenti diretti esteri) verso l’America Latina degli USA erano di 3 miliardi di dollari contro 1,5 dell’Europa; nel 1995 erano 15 miliardi di dollari degli USA contro i 5 europei, nel 1997 di 24 miliardi USA contro 19 e l’Unctad prevede per il 1999 nell’area latino americana il sorpasso degli IDE europei rispetto a quelli statunitensi. Le esportazioni europee verso l’America Latina in pochi anni sono più che raddoppiate; nel 1997 hanno toccato quasi i 53 miliardi di dollari e le importazioni da quell’area hanno superato i 38 miliardi di dollari. Questi sono solo alcuni risultati della guerra di egemonia economica che si fa sempre più frontale in tutte le aree del pianeta fra il polo imperialista USA e quello dell’UE. E lo scontro diventerà ancora più duro e favorevole all’UE se l’euro avrà il tempo e l’opportunità di rafforzarsi. L’impatto dell’euro sulle relazioni internazionali può avere effetti dirompenti rispetto agli assetti e agli equilibri internazionali attuali, nonostante le ambiguità e i limiti più a carattere interno all’UE. Cominciamo a vedere il contesto attuativo dell’Unione Europea. A dar luogo all’Europa è l’economia finanziaria globalizzata in cui è la moneta e i movimenti dei soli capitali a scandire il fenomeno imperialista europeo, in un contesto di apparente globalizzazione totale in cui invece ogni polo imperialista si erge a fortezza internazionalizzata in cui i mercati interni o di area di influenza devono rimanere assolutamente prioritari e prevalenti. Risulta sempre più evidente che il Trattato di Maastricht e quello di Amsterdam hanno carattere geopolitico soprattutto per quanto riguarda la Germania nel contesto Unione europea. Il Trattato di Maastricht presentava in sé già molte ambiguità. Tanto per cominciare, la struttura di Maastricht si doveva basare su tre elementi: la moneta unica, la politica estera e di sicurezza comune, la lotta alla criminalità. Moneta unica e integrazione politica dovevano reggersi reciprocamente. Cosa succede invece? Il vincolo dei criteri di convergenza imposto a Maastricht ha un significato geopolitico e geoeconomico: divide gli stabili e affidabili paesi dell’area del marco dai paesi mediterranei, creando problemi alle stesse multinazionali europee. Il cuore del Trattato sull’Unione europea, varato a Maastricht l’11 dicembre 1991, firmato ufficialmente il 7 febbraio 1992 e vigente dal 1° novembre 1993, è al momento semplicemente e solamente la moneta unica, inaugurata il 1° gennaio 1999. Dopo l’Atto unico del dicembre 1985, con il quale venivano poste premesse della libera circolazione di persone, merci e capitali nello spazio comunitario, l’unificazione della moneta è considerata dai suoi ideatori come la premessa indispensabile di una più profonda integrazione europea, e ciò è finalizzato alla creazione del più grande mercato finanziario del mondo. Con questo evento si impone fittiziamente una confederazione le cui finalità di controllo travalicano l’Europa occidentale per imporre il dominio sui paesi dell’Est (ex satelliti di Mosca), superando così in una logica di polo imperiale gli aspetti ambigui e le incongruenze derivanti da una non voluta soluzione dei mali sociali dell’Europa occidentale a vantaggio di tutti i nuovi soggetti finanziari europei, investitori istituzionali e non. L’euro appare come un tentativo di dare all’Europa una sola moneta, una nuova moneta forte nelle transazioni internazionali di riferimento fondamentale per l’est europeo e per l’Africa mediterranea; mentre di fatto si presenta come un progetto ambiguo che caratterizza un’élite di “eurovirtuosi” e manda alla deriva tutti gli altri, anche paesi importanti all’interno dell’UE. E’ implicito nello stesso trattato di Maastricht la legittimità del principio dell’Europa a diverse velocità, tale principio indica che nella comunità, formalmente di eguali c’è chi è più eguale degli altri; sotto questo profilo Maastricht non è la continuazione dell’Europa del trattato di Roma ma è l’esplicitazione contraddittoria del polo imperialistico europeo. L’Europa, infatti, dà via libera alla Germania per la riunificazione in tempi rapidi, ottenendo come contropartita l’europeizzazione del marco. Dunque è un riflesso germanofobo a muovere i leader europei poiché si presume che la Germania unita con i suoi oltre 85 milioni di abitanti, la forza della sua economia e della sua moneta, rischi di sbilanciare la polarizzazione imperialista; infatti gli Stati Uniti riconoscono alla nuova Germania lo status di super potenza ed esprimono la necessità di contenerla. La Germania ha bisogno dell’Europa per difendere i suoi interessi internazionali più della Francia e dell’Italia, e allo stesso tempo mantiene il proprio nazionalismo economico, ma Maastricht costringe la Germania a cedere il marco, per limitarne la potenza e incardinarla in un’Europa alternativa agli interessi USA. C’è da tener presente che gli obiettivi originari della Germania rispetto a quelli di Francia e Italia erano opposti. A Francia e Italia interessava togliere il marco ai tedeschi, mentre ai tedeschi interessava germanizzare le politiche economiche e finanziarie dei partner, adeguarle ai criteri di stabilità su cui hanno costruito il “miracolo” del secondo dopoguerra. Inoltre, attraverso una calibrata manovra dei tassi di interesse gestita dalla Bundesbank, intendevano garantirsi un forte flusso di capitali europei verso la Germania, necessari a riempire la voragine dell’ex RDT. Nella Germania prevale un’impreparazione ad affrontare le responsabilità interne e internazionali che le derivano dal suo nuovo status e dalla scomparsa della supremazia sovietica, che le ha aperto uno sterminato campo di influenza, ma anche di problemi e di responsabilità. Per ora sembra solo che la preoccupazione maggiore dei governi sia stata quella di scegliersi l’alleato ideale nella lotta alla supremazia economica e politica, in contrapposizione più o meno marcata rispetto al polo imperialista statunitense, imponendo una maggiore centralità del mercato UE non solo per le multinazionali europee ma anche per quelle esterne. La sorte dell’euro è fortemente condizionata dal contesto esterno, che siano i mercati finanziari nel mondo o la politica monetaria degli Stati Uniti. L’ipotesi euro continua a prendere consistenza e profilarsi come strumento di guerra commerciale, pertanto gli Usa stanno facendo il possibile per soffocarla. Per gli americani la migliore Europa possibile deve essere sufficientemente unita ma sotto il dominio USA e, quindi, agiscono per renderla sufficientemente divisa per impedirne l’affermazione come superpotenza concorrente. Gli Usa, dunque, temono oggi più di ieri una moneta destinata a favorire nel tempo le esportazioni europee e nel tempo, a minacciare il rango del biglietto verde come valuta di riserva mondiale. La subordinazione UE agli USA è chiara anche durante e dopo la guerra NATO in Jugoslavia, basta vedere come l’euro ha perso in quel periodo sul dollaro (circa il 12%) e come la guerra ha inciso in modo decisamente negativo sull’economia dell’Europa dei 15, mentre la crescita in USA nel periodo bellico è del 4,5% seguendo un forte andamento di crescita già avuto negli ultimi mesi del 1998 in cui l’economia americana si preparava ai nuovi conflitti in Iraq e in Jugoslavia. A prescindere dai conflitti di interessi l’Europa dell’euro è una scelta nell’ambito della logica spartitoria imperialista diretta dai principi della globalizzazione finanziaria. Ed è proprio per questo che nonostante le apparenze si tratta di un’ideologia molto fungibile e ancora carica di indeterminatezza sulle aree di influenza da aggredire. La teoria dell’Europa unita è ancora troppo debole nei confronti del polo USA per poter servire progetti differenti, se non opposti: dallo stretto dominio sociale a carattere finanziario ed economico all’interno degli attuali confini statali e comunitari, fino allo stravolgimento della carta geopolitica mondiale mascherato da criteri “etnici” o socio-economici ma determinato, nella realtà, anche nel Terzo Mondo, da logiche di polarizzazione imperialista. In questo ambito assumono rilevanza fondamentale la funzione svolta dagli USA e dagli organismi internazionali a carattere finanziario. Infatti i crediti concessi ai paesi in via di sviluppo hanno creato il meccanismo di trasferimento di ricchezza su vasta scala del periodo contemporaneo. Il riciclaggio dei “petroldollari” ha fatto crescere questo eccessivo debito dei paesi del Terzo Mondo. La formazione dei mercati obbligazionari, la trasformazione in titoli del debito pubblico e la crescita sempre più rapida di quella parte del budget dei paesi dell’Ocse che si pone al servizio del debito, stanno a dimostrare che il meccanismo di captazione e di trasferimento più importante è sempre quello di una globalizzazione a vantaggio del grande capitale finanziario. Comunque la mondializzazione capitalistica e l’intento del capitale finanziario di dominare il movimento di capitale nella sua totalità, non solo tendono a cancellare l’esistenza degli stati nazionali, ma immediatamente tali processi accentuano i fattori di gerachizzazione tra i paesi e ne ridimensionano la configurazione accentuando i conflitti imperialistici per il controllo su quelle aree a maggiore interesse di spartizione geopolitica e geoeconomica. La liberalizzazione degli scambi insieme alla deregolamentazione e allo smantellamento della legislazione a tutela dei salari, ha permesso ai gruppi delle multinazionali, in particolare americane, di sfruttare simultaneamente i vantaggi della libera circolazione delle merci e delle forti disparità tra i paesi, le regioni o i luoghi situati anche all’interno della stesso mercato unico europeo. Il grande mercato continentale assicura contemporaneamente ai gruppi economico-finanziari delle multinazionali totale libertà di scelta dei differenti elementi costitutivi di una produzione integrata a livello internazionale, rispondendo anche alle esigenze delle strategie di differenziazione dell’offerta e della fedeltà della clientela, esigenze che sono proprie alla concorrenza oligopolistica. E’ con tali premesse che gli USA passano nei confronti dell’UE dalla guerra economica anche alla guerra guerreggiata, vedi la guerra in Jugoslavia, sfruttando il fatto che in Europa va avanti la centralizzazione economica ma manca del tutto quella politica, e quindi, militare, contando su questi temi anche sul ruolo di "guastatore europeo" della Gran Bretagna. Infatti, la guerra della NATO contro la Jugoslavia rappresenta un punto di svolta tra il modello politico ed economico dell’imperialismo americano e quello del polo imperialista europeo. Quest’ultimo è ormai in forte competizione con quello USA sia per quanto riguarda l’imposizione del nuovo ordine mondiale, sia per la spartizione del mercato mondiale sia, infine, per il controllo delle mire espansionistiche imperialiste del polo asiatico da parte ancora del Giappone o dell’eventuale costituendo asse russo-cinese-indiano.
2. Le diverse forme di internazionalizzazione economico-produttiva2.1. Delocalizzazione produttiva e filiere internazionali
Il processo di trasformazione che ha interessato i mercati internazionali in questi ultimi anni ha avuto, inoltre, tra le sue più dirette conseguenze anche un mutamento fondamentale nelle modalità del processo produttivo. Le imprese più piccole si sono dovute combinare fra loro per consentire il cambiamento avvenuto da ” local for global”, ossia prodotti nazionali, produzione nazionale, mercati internazionali, a “global for global”, ossia prodotti multilocali, produzione multilocale, mercati globali. Si è avuta così la nascita di “aziende virtuali”, ossia gruppi di imprese che temporaneamente agiscono come se fossero un’unica azienda. Si genera così una situazione di “reti integrate a diversi livelli lungo una stessa catena di business costituite da nuclei interattivi, articoli in gruppi e sottogruppi, che condizionano alcune infrastrutture (sistemi informativi, sistemi gestionali, valori) e sono in grado di rispondere creativamente ai continui cambiamenti di scenario e di mercato. Questo tipo di “rete” viene definito “sistema alonico” ove a circolare sono le informazioni piuttosto che i beni fisici” [1]. Le nuove forme di internazionalizzazione possono, comunque, essere classificate in diverse categorie che prevedono accordi di natura tecnologica (joint venture, alleanze di vario tipo, cessioni di licenze, ecc.), accordi di natura produttiva per la realizzazione di opere complesse o determinati prodotti (subappalti, co-produzione e subforniture) ed accordi di marketing, assistenza e distribuzione (contratti di distribuzione, franchising). Spesso i dirigenti delle imprese che non riescono a detenere la totalità o la quota di maggioranza di una società estera costituiscono delle joint venture per ottenere degli utili più elevati: “Una joint venture è la partecipazione di due aziende alla proprietà, direzione e controllo di una terza creata per portare benefici a tutte e due” [2]. In sostanza si tratta di una collaborazione fra imprese diverse a livello internazionale per svolgere un determinato affare o portare a compimento una determinata opera, per un periodo di tempo variabile [3] . Se si vuole parlare di joint venture occorre analizzare la situazione del Giappone, in quanto questo paese si è fortemente contraddistinto per la creazione e lo sviluppo di tale tipo di imprese. Basti pensare a questo proposito che, infatti, 64 su 100 delle società estere più importanti nel mercato nipponico sono state originate tramite joint venture, le quali, inoltre, rappresentano un terzo dell’industria petrolifera. La creazione di queste imprese è iniziata in Giappone negli anni’70, periodo in cui le joint venture rappresentavano lo strumento migliore per superare le barriere di tipo legale e diretto che ostacolavano l’entrata nel mercato giapponese. Dopo qualche anno però si ebbe una drastica riduzione del loro numero. Nel 1989 poi lo scoppio “dell’economia della bolla finanziaria” provocato dalla repentina e improvvisa discesa del mercato azionario e immobiliare ha indotto le banche e le imprese nipponiche ad evitare gli investimenti. Comunque le alleanze dovute alla creazione di joint venture generalmente hanno una vita molto lunga (15-20 anni) soprattutto a causa degli elevati costi da sostenere nel caso di un suo scioglimento. Fino a pochi hanno fa, inoltre, il ruolo delle aziende occidentali consisteva nell’apporto di prodotti o tecnologie all’avanguardia in cambio della possibilità di entrare nel mercato giapponese, oggi invece le aziende nipponiche hanno imparato a costruirsi da sole queste tecnologie. Anche i paesi europei, soprattutto i paesi dell’Unione Europea, hanno realizzato in questi ultimi anni molti programmi tendenti a realizzare la nascita di joint venture. Va ricordato per primo l’ECIP (European Community Investment Partners) creato dall’Unione Europea nel 1988: si compone di quattro “facilities” ideate per finanziare lo studio, l’investimento e l’assistenza tecnica di joint venture tra imprenditori comunitari ed operatori di alcuni paesi dell’Asia, America Latina, Area Mediterranea e della Repubblica Sudafricana. Vi è poi Il programma JOPP - Joint Venture Phare Programme attualmente tramutato in JOP -Joint Venture Programme in quanto la sua operatività non è più limitata ai Paesi aderenti al programme Phare ma dal 1995 è compresa anche la Federazione Russa e dal 1997 i Paesi CIS-Comunità degli Stati Indipendenti e la Mongolia. Il JOP fu creato nel 1991 per favorire l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese attraverso la realizzazione di investimenti produttivi sotto forma di imprese miste, tra imprenditori comunitari ed operatori dei Paesi suddetti. I progetti finanziabili dal programma JOP devono prevedere un incremento dell’occupazione nel mercato del lavoro locale, uno sviluppo della tecnologia, un miglioramento della bilancia valutaria e la tutela dell’ambiente. Il programma offre, sulla falsariga dell’ECIP, diverse tipologie di interventi suddivise in “facilities” correlate alle varie fasi del processo di creazione o ampliamento di una impresa. Infine si ha il JEV (Joint European Venture) destinato a sostenere la costituzione di imprese comuni transnazionali all’interno dell’Unione “Modellato” sulle esperienze dei due programmi precedenti. il JEV si prefigge l’obiettivo di creare nuove attività economiche che stimolino, attraverso un investimento, la creazione di posti di lavoro all’interno dei paesi membri dell’UE e più precisamente incentivare la nascita di partnership tra aziende situate all’interno dell’ U.E. mediante consorzi, partecipazioni o joint venture nei settori dell’industria, servizi, commercio e artigianato. Sempre nell’ambito degli accordi di natura tecnologica si hanno anche i contratti di cessione di licenza (licensing) che avvengono dietro pagamento di un corrispettivo e sono in sostanza concessioni di sfruttamento temporaneo dei diritti su brevetti o marchi, ecc. Tra gli accordi di natura produttiva si possono citare la subfornitura, i subappalti e la co-produzione; nel primo caso si tratta di un accordo nel quale un’impresa affida ad un’altra l’esecuzione di una parte del proprio processo produttivo per consentire lo sfruttamento delle condizioni più favorevoli. Anche il subappalto e la coproduzione sono accordi tra imprese, contratti che garantiscono lo sfruttamento delle migliori condizioni produttive. Negli accordi di marketing si ricorda il franchising ossia quella collaborazione continuativa tra due parti nella quale una (l’affiliante) concede all’altra (l’affiliato) giuridicamente ed economicamente indipendente di utilizzare la propria formula commerciale (Immagine) nell’interesse reciproco delle parti. Il franchising internazionale può essere di prodotto, di servizi, di marchio commerciale. La conseguenza più evidente di questo scenario è che da qualche anno, l’economia mondiale è sottoposta ad un processo di globalizzazione dei mercati e della concorrenza a carattere delocalizzativo tramite imprese rete multinazionali e filiere produttive internazionali e contemporaneamente si assiste a forti e continui processi di concentrazione della proprietà d’impresa il tutto in un contesto di speculazione finanziaria.
L’alto livello di conoscenza tecnologica e scientifica rende indispensabile ormai un legame sempre più stretto tra i vari settori delle imprese di ogni paese; lo sviluppo dei mezzi di comunicazione e di trasporto, inoltre, annullando di fatto le distanze tra i diversi paesi fanno si che le imprese si trovino a considerare il mercato internazionale nella sua globalità. Se a ciò si aggiunge la riduzione di tutti i dazi doganali che incentivano lo scambio di beni tra i vari paesi e la notevole trasformazione dei processi produttivi che ha portato alla necessita di passare da una produzione con elevato uso di manodopera (labour-intensive) a un modello industriale basato sui capitali materiali (cioè impianti e attrezzature, capital-intensive) e con un elevato aumento dei costi destinati al capitale immateriale, come l’informazione, la ricerca e lo sviluppo, si comprende che per l’impresa capitalistica competere in un sistema globale significa sostenere costi fissi molto elevati, e trovare il modo per recuperarli, anche perché i costi variabili sono, ormai, economicamente superati. E’ allora indispensabile avere partners internazionali che possono contribuire ad ammortizzare i costi fissi e con i quali definire strategie che permettono di massimizzare la redditività d’impresa attraverso la compressione del costo del lavoro diretto e indiretto e la riduzione dell’imposizione fiscale e tributaria. L’innovazione tecnologica, l’omogeneizzazione mondiale dei bisogni dei consumatori, la diminuzione delle barriere doganali e la trasformazione produttiva sono senza dubbio tra le principali motivazioni di questo nuovo processo che sta ormai interessando il mercato mondiale. La verità è che l’imprenditore internazionale attraverso le multinazionali, il commercio estero, gli investimenti diretti esteri, è alla continua ricerca di sempre nuovi mercati di sbocco ma soprattutto di nuovi mercati di incetta a basso costo della risorsa umana, il lavoro, e delle materie prime garantendo il capitale nelle aree che si prestano ad isole felici e paradisi fiscali. La generalizzazione della produzione flessibile, con quelle che sono le sue esigenze nei termini di vicinanza tra coloro che fanno le ordinazioni e i fornitori di pezzi, di semiprodotti e di servizi, ha lo stesso peso sulla scelta della localizzazione a scapito dei paesi a medio sviluppo, in particolare, ad esempio, di quelle industrie dei Balcani e dell’Est Europeo in cui il basso costo del lavoro si associa a livelli medio-alti di specializzazione della manodopera, ivi comprese certe industrie a impiego intensivo di manodopera. Questi stessi fattori spiegano la marginalizzazione non solo di gran parte dei paesi in via di sviluppo ma dei paesi soprattutto dell’Europa centro-orientale, poi dell’Africa mediterranea. Le opportunità di delocalizzazione della produzione in direzione dei paesi a salario molto basso, rese possibili dalla liberalizzazione degli scambi pressoché completa, si tramutano per molti paesi dell’Europa dell’Est o anche parti di interi continenti (essenzialmente l’Africa) soltanto in assoluto movimento di mondializzazione del capitale, provocando un nuovo colonialismo nella forma di marginalizzazione anche degli stessi processi finanziari. Il processo di internazionalizzazione fondato inizialmente sulle sole esportazioni si è ampliato negli anni fino a diventare un’insieme di attività organizzate, quali la progettazione del prodotto, la localizzazione delle produzioni, il marketing e la commercializzazione. Infatti “mentre una volta chiamavano esportazione una cosa che altro non era che la vendita in un mercato più ampio, ma in genere ignorando quasi del tutto i bisogni di questi altri consumatori e non localizzando, se non in superficie, i nostri prodotti, oggi si chiama esportazione un insieme di operazioni che partono dalla conoscenza dei bisogni, passano per un’analisi dei costi di prodotto, di struttura ed accessori e si concludono con un bene/servizio che ottimizza tutti i fattori....” L’internazionalizzazione è definita “l’insieme delle operazioni che un’azienda fa per internazionalizzarsi, ma per quanto ci riguarda internazionalizzazione vuol dire considerare di avere fattori e clienti nei posti migliori in tutto il mondo, non solamente nella nostra nicchia” [4] . Si tratta in sostanza di una delocalizzazione del processo produttivo. E’ chiaro che quando un’impresa intraprende un processo di internazionalizzazione subirà la pressione dei concorrenti non solo del mercato interno ma anche di quello estero. Occorre, quindi, tenere presente che “il paese che ci interessa ha: un ampio mercato, l’accesso ad un mercato regionale, un basso costo del lavoro, una manodopera esperta, fattori produttivi eccellenti (costo delle materie prime, affitti, elettricità, altri fattori produttivi), basse tasse e la possibilità di usufruire di incentivi governativi. Tutti questi punti potranno fornirci indicazioni sia sul dove investire che sul come ottenere il profitto che l’azienda si aspetta dall’investimento” [5] . In questo senso “la risposta teorica di una parte della dottrina economica ed economico-aziendale asserisce che, date alcune condizioni economiche, sociali e tecniche, esiste, per quella determinata unità produttiva, una localizzazione “ottimale” o quanto meno “più soddisfacente” delle altre, anche se essa è di difficile individuazione. Esiste una seconda tradizione delle teorie di localizzazione il cui fondamento sta nell’esplicita considerazione dei costi di trasporto” [6]. Si deve considerare, però, che vi sono altri fattori che incidono sulla decisione della localizzazione ottimale: si intende parlare delle infrastrutture industriali, generiche e specifiche, degli inputs di produzione, del lavoro e della popolazione, i servizi di interesse industriale, i fattori riguardanti il mercato misurati dall’estensione del mercato locale e regionale e dal livello della sua concorrenza ed infine dalle condizioni di insediamento per la popolazione. Si arriva così alla realizzazione dell’”impresa globale” che considera il mercato globale nel suo intero; la differenza tra questo nuovo tipo di impresa globale e l’impresa multinazionale consiste soprattutto nel fatto che mentre la prima valuta il mercato internazionale come composto da tutti i mercati degli altri paesi senza distinzione, l’impresa multinazionale invece tende a mantenerli separati. Il processo di internazionalizzazione produttiva comporta, quindi, una significativa revisione delle scelte di localizzazione dell’impresa e quindi anche un cambiamento nello scambio delle merci. Ma è allora lecito chiedersi se gli investimenti all’estero favoriscono o meno il commercio. Dagli studi delle realtà produttive dei vari paesi è risultato evidente che gli investimenti diretti esteri crescono di fatto con il commercio internazionale e che in sostanza i due fenomeni sono intrecciati fra loro. La crescita delle imprese multinazionali all’estero infatti contribuiscono alla conoscenza dei mercati ed accelerano quei processi che solo con il commercio internazionale sarebbero stati molto più lenti.
2.2. Le forme di concentrazione
Negli ultimi mesi si è assistito al moltiplicarsi di concentrazioni industriali, bancarie e commerciali in tutti i paesi a capitalismo avanzato. In sostanza si è reso necessario attuare delle alleanze tra le imprese che hanno portato a sempre maggiori concentrazioni delle stesse [7]. Inoltre, la concentrazione può essere intesa sotto vari punti di vista [i] . A fronte dei processi di internazionalizzazione economica e ai processi di delocalizzazione produttiva, si assiste nei più importanti poli capitalistici a continue fusioni, acquisizioni e concentrazioni finanziarie ed industriali che spesso assumono la forma di processi a carattere nazional-capitalistico alla ricerca di spazi concorrenziali. Nella quasi totalità dei casi di concentrazione della proprietà si invoca l’efficienza e la competitività che si traduce in drastiche riduzioni del personale, in esternalizzazioni di fasi del ciclo che producono lavoro nero, precario e flessibile, in condizioni vessatorie per i fornitori ed in genere in forme di redistribuzione tutte favorevoli al profitto. Se attraverso il coefficiente di concentrazione territoriale si analizza il livello di concentrazione territoriale del sistema imprenditoriale italiano, si evince dal Graf. 19 come la concentrazione [8] di imprese al Nord sia più elevata soprattutto nel settore industriale, mentre, invece al Centro e al Sud pur risultando inferiore al Nord è maggiormente evidenziabile una concentrazione del settore terziario rispetto a quello industriale.
Il Graf.20 invece mostra chiaramente la forte concetrazione di addetti nel settore industriale soprattutto nelle regioni del Nord Italia; infatti i valori più elevati si riscontrano in Lombardia (28,74), in Veneto (11,21) ed in Piemonte (12,9); le regioni del Centro-Sud evidenziano maggiori livelli di concentrazione territoriale per i servizi, con un indice di concetrazione per il terziairo molto alto nel Lazio (vicino al 25%). Se si analizza più in generale la situazione europea, si nota che le imprese sono più propense a fondersi o ad acquisire imprese al di fuori dei confini dell’Unione Europea, anche se le regole e i metodi per effettuare queste operazioni variano da paese a paese. Ad esempio la Francia è risultata negli ultimi anni il principale compratore di acquisizioni di imprese, in termini di controlli di compartecipazioni estere, con un saldo attivo di 22 miliardi di dollari tra il 1990 e il 1991: anche la Svezia, la Svizzera, la Germania e i Paesi Bassi hanno adottato la stessa politica delle aziende francesi; la Gran Bretagna invece è il mercato europeo più semplice da conquistare. Ad esempio la Nissan ha trasferito il suo impianto di assemblaggio nel Regno Unito, mentre l’ICL è stata acquisita dalla Fujitsu con lo scopo di incrementare la sua quota di mercato dei computer, anche le alleanze tra la Rover e la Honda e tra la Volkswagen e la Suzuki sono nate con l’obiettivo di migliorare le performance reddituali e produttive in cambio dell’accesso al mercato britannico e a quello tedesco. L’apertura dei mercati dell’Europa dell’Est ha fortemente condizionato le politiche adottate dalle imprese europee. Va ricordato che i paesi maggiormente coinvolti sono: la Cecoslovacchia, la Polonia, l’Ungheria e l’Ex Unione Sovietica. Infatti le stesse fonti imprenditoriali evidenziano che “l’Europa la sentiamo ogni giorno più vicina non tanto per la sensazione di sentirsi nella casa comune o ancora per il progetto politico di unità culturale, ma per il fatto di riconoscere le stesse strutture economiche e finanziarie in Francia come in Germania e in Spagna e fra poco anche in Ungheria, Polonia e nei paesi ex-Comunisti, disposti ad accogliere velocemente i concetti del mercato libero e ad attrarre capitali stranieri” [9] . La notevole concentrazione delle grandi imprese statunitensi è dovuta, nella maggior parte dei casi, ad intensi processi di fusioni e alle acquisizioni. Dall’inizio del secolo si sono avuti tre picchi nei suddetti processi. Il primo si è avuto tra il 1897 e il 1905: ogni anno 352 aziende scomparvero a causa di processi di fusione, raggiungendo il limite massimo nel 1898, quando furono assorbite 1.208 imprese; nella seconda metà degli anni’20 si registrò il secondo picco, tra il 1925 e il 1929 si accorparono quasi 4.500 imprese [10]. Il terzo picco si ebbe tra il 1955 e il 1968; in questi anni 1.114 imprese furono assorbite e sempre più aziende preferirono acquistarne di già esistenti piuttosto che crearne di nuove. Il processo di fusione subì una battuta di arresto dopo le crisi petrolifere del 1974 e del 1979; a metà degli anni’80 venne effettuato un numero crescente di fusioni anche tra aziende di grandi dimensioni; questi ultimi anni sono fortemente caratterizzati da numerose acquisizioni estere causate dalla maggiore internazionalizzazione delle attività di impresa. Tale fenomeno è comune sia alla realtà statunitense sia alle realtà imprenditoriali europee e asiatiche e come si vedrà in particolare nel prossimo numero della rivista Proteo dove questa analisi-inchiesta alla sua Quarta Parte toccherà in maniera approfondita questi temi, i processi di concentrazione accelerata che stanno attraversando tutti i maggiori poli capitalisti significano un’economia mondiale sempre più nelle mani di poche multinazionali che dispongono di un dominio illimitato capace di controllare il mondo, alla faccia della tanto decantata democrazia economica.
2.3. Il commercio internazionale
Già a partire dall’osservazione del Graf.21 è evidente che negli ultimi quindici anni il commercio mondiale è più che raddoppiato, passando da circa 2.000 miliardi di dollari nel 1981 a oltre 5.000 miliardi nel 1996. Anche lo scambio di merci registra una forte crescita a partire dal 1986 , pur se nei primi anni ’90 si registra una diminuzione che diventerà variazione negativa nel 1993 dello 0,5% (cfr. Graf.22).
Dalla Tab.18 si può notare il calo accentuato, negli ultimi anni del prezzo delle materie prime, in particolare del petrolio; inoltre nel 1998 si hanno variazioni dell’import e dell’export dei paesi industrializzati molto più contenute rispetto a quelle dell’anno precedente; la crisi asiatica dell’ultimo anno è particolarmente evidente anche dall’analisi del commercio con l’estero che mostra un serio calo dell’esportazione dell’area asiatica, ma in particolare un vero tracollo delle importazioni.
L’internazionalizzazione dell’economia e l’apertura dei mercati fanno sì che nella maggior parte dei casi l’impresa entra a far parte di un mercato posto a migliaia di km dal suo sito, ma questa situazione ha però accentuato la posizione critica dei paesi più poveri, che si vedono costretti a sottostare a condizioni di cambio e di scambio vessatorie, incrementando ulteriormente il divario esistente con i paesi più ricchi. I processi di internazionalizzazione hanno così creato uno scenario internazionale fortemente condizionato da tre grandi poli industriali: l’UE dell’euro, gli USA con lo spazio NAFTA (North America Free Trade Agreement) o area del dollaro, ed infine l’Asia, il Giappone e area dello Yen. I paesi principali che sono coinvolti anche nello scambio internazionale risultano quindi sempre essere gli Stati Uniti, il Giappone e l’Unione Europea; infatti come si può osservare dal Graf. 23 riferito al 1997, queste tre aree da sole assorbono quasi i 3/5 delle importazioni e delle esportazioni mondiali.
[1] C. Saccani, I supporti alle imprese di fronte al cambiamento, Impresa & Stato N.31 Rivista della camera di commercio milanese, pag.3. [2] G. Biscrini, Principi e tecnniche di internalizzazione, Nuova serie: n. 1/96, pag. 97. [3] La joint venture può essere contrattuale e societaria; nel primo caso le imprese interessata, che mantengono una propria a utonomia economica egiuridica, firmano un contratto di collaborazione con limitazione di tempi e di spazi; nel caso della joint venture societaria invece si costituisce una nuova società di capitali con resonsabilità limitata. Si possono avere allora joint venture con acquisizione di partecipanti internazionali, con creazione di un’impresa in un paese terzo, con crezione di una società mista con partner locale pubblico o con creazione di una join venture aperta a partner e azionisti privati. [4] G. Biscarini, Principi e tecniche di internazionalizzazione, Nuova serie: N°1/96 I quaderni della formazione. ICE, pag. 6 e 7. [5] G. Biscarini, Principi e tecniche di internazionalizzazione, op.cit., pag.105, 106. [6] G. Panati, G. M. Golinelli, Tecnica Economica Industriale e Commerciale, Volume I. Nis. Roma 1995. Pag. 296. [7] “In termini economici la concentrazione viene definita come un processo di diffusione del controllo di tutta o di una quota rilevante dell’attività di un settore o di un intero comparto di attività da parte di un numero ristretto di imprese.”, R. Guarini, F. Tassinari, Statistica Economica, Il Mulino, Bologna 1993. Pag.279. [i] Concentrazione tecnica che “indica il grado di disparità dimensionale esistente tra gli impianti di un determinato settore, quindi esprime la misura in cui gli impianti di maggiori dimensioni prevalgono, in termini di peso occupazionale, sulla massa di unità produttiva di ampiezza ridotta; come concentrazione economica rappresenta “il nesso che lega il numero di imprese e il numero di unità locali; il rapporto tra queste variabili, può essere assunto come misura approssimata del grado di dipendenza economica delle unità di produzione dai relativi centri decisionali”, concentrazione finanziaria “viene riferita alle imprese che producono beni similari o collegate da partecipazioni azionarie. Sotto questo aspetto la concentrazione esprime il grado di potere economico presente nel sistema, al di la delle convenzionali suddivisioni in classi di attività che interessano il contesto strutturale” ed infine come concentrazione territoriale che “esprime il grado di diffusione delle diverse attività sul territorio, quale risulta dall’interrelazione dei fattori che caratterizzano l’area dal punto di vista geofisico, infrastrutturale e più in generale economico". [8] Il Coefficiente di concentrazione territoriale, simile nella costruzione all’indice di localizzazione o specializzazione territoriale serve per confrontare la distribuzione relativa degli addetti alle unità locali in un determinato ramo o classe di attività economica con la distribuzione relativa del totale degli addetti alle unità locali in una determinata regione. [9] Commercio Internazionale, n.3/97, pag.15. [10] "La grande crisi annunciata dal crollo di Wall Street del 1929 chiuse la seconda ondata di fusioni”, P. Dicken, P. Lloyd, Nuove prospettive su spazio e localizzazione, FrancoAngeli, Milano, 1993. Pag. 110.
|