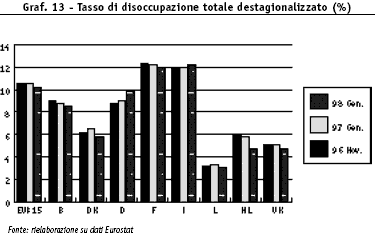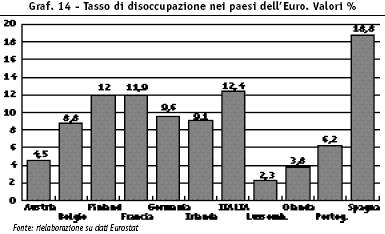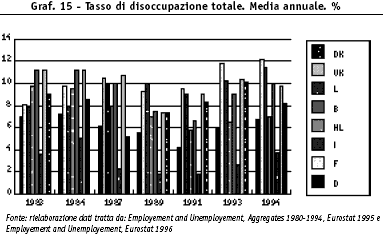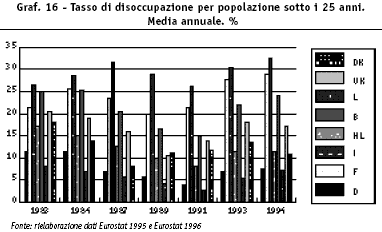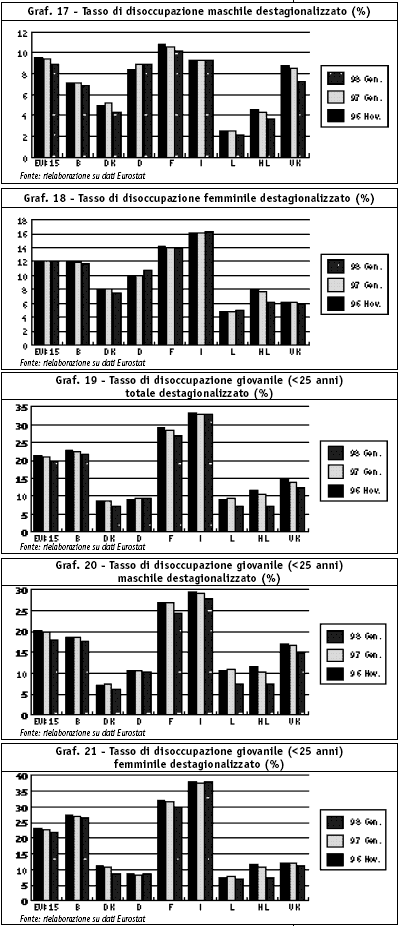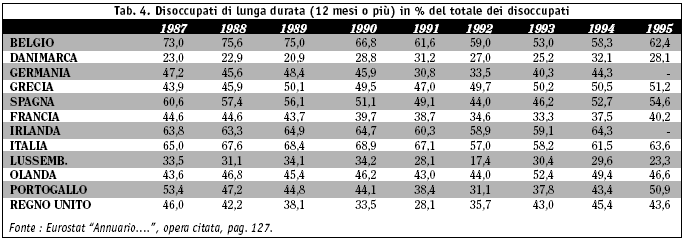![]()
Rubrica
L’analisi-inchiesta
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Luciano Vasapollo Docente di Economia Aziendale, Fac. di Scienze Statistiche, Università’ “La Sapienza”, Roma; Direttore Responsabile Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali (CESTES) - Proteo. Rita Martufi Consulente ricercatrice socio-economica; membro del Comitato Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico Sociali (CESTES) - PROTEO
Ristrutturazione capitalistica
Le tendenze macroeconomiche del processo di ristrutturazione capitalistica
Tutti gli articoli della rubrica: analisi-inchiesta(in tutti i numeri di Proteo)
|
In sostanza la cifra dei 19 milioni di disoccupati ufficiali si allontana molto dalla realtà. Considerato che la Germania, la Francia e l’Italia insieme registrano oltre 12 milioni di disoccupati “invisibili” appare chiaro come si arrivi per la Comunità Europea ad un numero di gran lunga superiore ai 32 milioni di persone in cerca di occupazione. 4. La disoccupazione
Innanzitutto occorre chiarire che per disoccupati si intendono tutti coloro che sono in cerca di occupazione (ossia sia chi è in cerca di una prima occupazione sia coloro che hanno perso il precedente posto di lavoro); secondo la classificazione Eurostat alle quali si attiene l’ISTAT le persone in cerca di occupazione sono coloro che oltre a non aver svolto ore di lavoro nella settimana di riferimento dell’indagine sono disponibili immediatamente a lavorare e hanno condotto una ricerca di lavoro nei 30 giorni precedenti l’intervista; quindi se la persona interpellata ha svolto un qualsiasi tipo di attività lavorativa e in qualsiasi modalità, anche precaria, è comunque classificata come occupata. Il tasso di disoccupazione (calcolato dividendo il numero dei disoccupati per la somma dei disoccupati più gli occupati per 100) complessivo destagionalizzato complessivo nell’Europa dei 15 è stato valutato nel gennaio 1998 intorno al 10,5%; si vedano i Graf.13 e Graf.14 per un confronto tra i maggiori paesi europei.
Ma già dagli anni ’70 con l’accentuarsi dei processi di mondializzazione dell’economia e la dura concorrenza tra le imprese (aumento della produttività riducendo i costi) ha portato i salari ed il sistema sociale nella sua totalità ad essere sempre più soggetti alle regole ferree del puro mercato e del profitto. Il fenomeno della disoccupazione, accentuatosi in Europa e nel mondo dopo lo shock petrolifero dei primi anni ‘70, è cresciuto da allora ad un ritmo rapidissimo nei periodi di recessione e non è diminuito durante le fasi di espansione economica (in Europa si è arrivati ad un tasso di disoccupazione sei volte superiore a quella registrata negli anni ‘60, in Italia 2,5 volte più elevata rispetto a quegli anni). Va comunque rilevato che la disoccupazione nei paesi dell’Unione Europea è attualmente uno dei problemi di maggiore drammaticità interessando circa 19 milioni di disoccupati ufficiali; e circa 32 milioni se si considerano anche gli “invisibili” alle statistiche ufficiali. Si noti che nell’U.E. negli ultimi 25 anni l’occupazione totale è aumentata di circa il 9% a fronte di un aumento del volume di ricchezza prodotta di oltre il 90%. Oltre ad una sempre maggiore precarietà del lavoro, alla diminuzione
dei salari reali si è aggiunto l’attacco sempre più aspro al Welfare, al servizio
sanitario , alla previdenza sociale, alla scuola. Pur in presenza di un elevato
incremento di produttività non si è realizzata di pari passo una diminuzione
del tasso di disoccupazione, come si può osservare dal Graf.15 per i
più importanti paesi europei. L’andamento del tasso di disoccupazione si può schematizzare in tre fasi: la prima dagli anni 1983-1986 nella quale si registra una crescita generale del tasso di disoccupazione; la seconda che comprende gli anni che vanno dal 1986 al 1990 nei quali si è avuta una leggera diminuzione della disoccupazione; ed infine la terza fase che va dal 1990 ad oggi nella quale si è avuta una nuova crescita del tasso di disoccupazione. Oggi la disoccupazione è espressione dell’incapacità della nuova fase di sviluppo capitalistico di perseguire il pieno impiego, è espressione di una scelta politica e sociale di mantenere la disoccupazione per poter determinante attraverso questa il controllo delle dinamiche salariali e della forza lavoro. Il fatto che salario e produttività non siano più collegati tra loro implica che la distribuzione del reddito a livello nazionale e di conseguenza la domanda nazionale di consumo non abbiano più rilevanza nel risolvere il processo di accumulazione. In tale situazione non esiste una modernizzazione del consumo. Questo modo di produzione capitalistico produce per una popolazione ridotta, per consumi ridotti e di un certo tipo, mentre stimola la competizione violenta e assoluta per conquistare spazi di mercato in una condizione in cui queste nicchie non sono più segnati dall’ascesa e dall’attesa di una crescita ininterrotta della produzione e dei consumi. La disoccupazione non è frutto di arretratezza, di una scelta
nello sviluppo di un nuovo processo capitalistico. Se si analizzano i dati riguardanti i giovani si assiste ad un fenomeno analogo a quello del tasso di disoccupazione totale; va rilevato però che i giovani risultano essere molto più penalizzati rispetto agli adulti come si evince dal Graf.16.
In Francia , in Lussemburgo e in Belgio il tasso di disoccupazione giovanile (sotto i 25 anni) è il doppio di quello degli adulti; in Olanda, In Danimarca e in Gran Bretagna i valori sono più elevati di una volta e mezzo, mentre in Italia i disoccupati sotto i 25 anni sono 2,5 volte più elevati degli adulti; unica eccezione la Germania nella quale i tassi di disoccupazione totale e giovanile sono meno distanti. E’ anche estremamente interessante ricordare che i tassi di disoccupazione variano molto all’interno dei paesi dell’Unione Europea (si passa dal 3% in Lussemburgo al 22% in Spagna nell’anno 1995). Se si analizzano i dati disaggregati per realtà regionali la situazione è ancora più allarmante: si passa dal 4% nelle regioni centrali del Portogallo a percentuali del 32% nelle regioni del sud della Spagna. Le regioni a bassa disoccupazione sono rimaste stabili negli ultimi dieci anni ma restano concentrate ad un numero ristretto di aree geografiche: il sud dell’Olanda, il sud della Germania, il nord dell’Italia le regioni del nord-est e del nord-ovest della Danimarca, il nord e il centro del Portogallo. Paesi come la Finlandia e la Francia (in particolare Parigi e dintorni) che erano sempre state a basso tasso di disoccupazione hanno avuto un aumento di disoccupati nei primi anni ‘90. Il Graf.17 evidenzia che per l’Europa dei 15 il tasso di disoccupazione complessivo maschile destagionalizzato è intorno al 9% nel gennaio 1998; la Spagna presenta un tasso molto superiore alla media ( 15,3%) mentre la Danimarca e il Lussemburgo si attestano su valori sensibilmente inferiori (rispettivamente 4,5 e 2,4%). La Francia e l’Italia presentano valori superiori alla media (rispettivamente 10,7% e 9,2% nell’ottobre 1997).
Il Graf.18 mostra che per il complesso dei paesi dell’Europa dei 15 il tasso di disoccupazione femminile destagionalizzato è del 12,4% (genn.1998); la Spagna anche in questo caso presenta valori molto alti rispetto alla media (27,8%) mentre il Lussemburgo registra valori molto inferiori (5,1%). La Francia e l’Italia mostrano valori superiori alla media ( rispettivamente 14,2% e 16,9% nel genn.1998), confermandosi come paesi con le più forti contraddizioni in termini di ricadute economico-sociali relativamente ai processi di ristrutturazione del capitale che stanno attraversando l’intera Europa. Analizzando i Graff.19, 20 e 21 è evidente come per l’Europa dei 15 il tasso di disoccupazione giovanile destagionalizzato complessivo sia molto alto (del 20,3%) nel gennaio 1998 ossia quasi il doppio del tasso di disoccupazione totale destagionalizzato (che è del 10,4%). Le donne registrano una differenza con il tasso totale complessivo pari al 9,9%, mentre gli uomini si attestano al 9,6%. Se si confronta poi il tasso complessivo degli uomini e quello delle donne al di sotto dei 25 anni si nota che il tasso di disoccupazione maschile è significativamente inferiore a quello complessivo, confermando che per le donne la situazione occupazionale nell’intera Europa dei 15 assume ancora percentuali drammatiche. La Tab.4 analizza il tasso di disoccupazione di lunga durata (ossia di disoccupati per oltre 12 mesi); dai dati emerge chiaramente che l’Italia si attesta sempre su valori più alti rispetto agli altri paesi (nel 1995 il valore è del 63,6%), mentre i paesi con valori più bassi sono la Danimarca e il Lussemburgo (con valori nel 1995 rispettivamente del 28,1% e del 23,3%). Il Belgio invece si avvicina a valori simili a quelli registrati nel nostro Paese(62,4% nel 1995).
Se si analizza da vicino il nostro Paese si evidenziano dati di alta drammaticità che minano alle basi la stessa convivenza sociale e sopravvivenza di larghi strati della popolazione. In Italia siamo di fronte ad un incremento della produttività fra i più alti degli ultimi anni, ma la disoccupazione non è stata sostanzialmente toccata e nel mezzogiorno raggiunge quote devastanti. Per risolvere il problema disoccupazione non serve, dunque, aumentare la produttività ed il profitto nazionale, anzi è evidente che tale processo ha portato la società moderna alla crisi occupazionale. Ad esempio alla fine del 1997 a fronte di 20.126.000 occupati e 2.486.000 disoccupati i giovani occupati erano 4.743.000 e i disoccupati 1.743.000; in sostanza quindi i giovani costituivano il 24% degli occupati ed il 61% dei disoccupati. Se si disaggregano ulteriormente i dati emerge chiaramente che esiste un forte divario territoriale fra i tassi di disoccupazione, in quanto al Sud c’è una percentuale doppia rispetto al Centro e al Nord d’Italia (a fronte di una percentuale inferiore al 20% al Nord per giovani in età compresa tra i 15 e i 24 anni, al Sud la percentuale si aggira intorno al 50% tra i giovani in età compresa tra i 15 e i 24 anni, ed arriva la 30% nella fascia di età 25-29 anni). Tendenza che si conferma in tutte le ripartizioni con il crescere dell’età, dal momento che mentre al Nord i tassi di disoccupazione si abbassano dopo i 20 anni (si arriva a circa il 10% nella fascia di età compresa tra i 20 e i 29 anni) e ciò non accade al Centro e soprattutto al Sud tra i giovani in età compresa tra i 20 e i 30 anni (i tassi rimangono introno al 40% fino ai 29 anni e superano il 60% tra le giovani donne). Ed ancora: mentre al Nord circa la metà dei giovani ha un lavoro ed un terzo studia nel Mezzogiorno invece solo il 20% è occupato. Si deve osservare che nelle regioni del Nord-Est d’Italia si studia meno che al sud in quanto la struttura produttiva basata sulla piccola e media impresa garantisce una possibilità maggiore di impiego in lavori manuali; la situazione è un po’ diversa nel Nord-Ovest in quanto essendo queste regioni caratterizzate dalla presenza di attività terziarie è richiesto per lavorare un livello di istruzione medio. L’area comunque nella quale si studia di più è il Centro Italia che ha un livello di disoccupazione intermedio; in questa regione, caratterizzata da un’alta presenza di lavoro impiegatizio e burocratico, è richiesto un livello di istruzione di più alto livello. Se si analizza il tasso di occupazione per titolo di studio e classe di età emerge chiaramente sempre nel 1997 che l’Italia risulta essere un paese con livelli di istruzione bassi rispetto agli altri paesi europei; la percentuale degli occupati in possesso di laurea è di circa l’11% e i lavoratori con un diploma sono circa il 29%; quasi il 38% degli occupati ha la licenza media ed il 15% ha una licenza elementare o nessun titolo di studio. Vi è un dato che merita di essere evidenziato: la maggiore istruzione delle donne rispetto agli uomini; a fronte di un 10% degli occupati laureati vi è quasi il 15% di donne laureate sempre della stessa fascia di età. Ed ancora il 29% dei maschi occupati è in possesso di un diploma di scuola media superiore contro un 37% di donne.
5. L’orario di lavoro
La disoccupazione è accompagnata da uno sfruttamento crescente dei salariati che restano in attività. L’intensificazione del lavoro porta allo stress nel lavoro e fuori dal lavoro. Il padronato fa del tempo di lavoro un elemento essenziale del supersfruttamento dei salari e della ridefinizione della società a partire dall’impresa. È un processo che ha avuto inizio con l’esplosione della precarietà, della flessibilità, della deregolamentazione, del supersfruttamento, sotto forme senza precedenti per i salariati in attività. Anche la riduzione dell’orario di lavoro può essere considerato uno dei modi per cercare di risolvere il problema dell’occupazione e di redistribuzione degli incrementi di produttività. Un altro obiettivo centrale della ristrutturazione capitalistica riguarda l’orario di lavoro, ed in particolare il problema della riduzione dell’orario di lavoro, che potrebbe essere, nelle condizioni esistenti un contributo importante per salvaguardare e creare posti di lavoro, puchè regolata da una politica contrattuale ad alto livello. Ma per far ciò sarebbe necessaria una politica economica alternativa, che sappia affrontare realmente i problemi occupazionali. Anche la domanda pubblica deve essere usata per questi obiettivi: deve diventare uno strumento per orientare gli investimenti verso la creazione di occupazione e il miglioramento della qualità della vita. Ci vorrebbe una politica che non solo rispetti le esigenze ecologiche, ma che metta al suo centro la riconversione ecologica e favorisca la produzione di prodotti socialmente utili. Ciò che avviene invece è la flessibilizzazione dell’orario di lavoro in funzione dei trend di domanda e dei processi di ristrutturazione d’impresa e della struttura capitalistica. In tal senso un fattore decisivo nella determinazione dell’orario di lavoro diventa sempre più l’orario straordinario: è chiaro infatti che una riduzione dell’orario di lavoro può generare la nascita di nuova occupazione solo se non vi è un incremento degli straordinari, anzi se il lavoro straordinario viene fortemente penalizzato. Nei paesi occidentali si sono avute tre fasi fondamentali. La prima legge che risale al 1833 (Factory Act) stabiliva l’orario massimo di otto ore giornaliere per lavoratori al di sotto dei 13 anni e 12 ore per quelli tra i 13 e i 18 anni; legge che ha poi fissato nel 1847 a dieci le ore lavorative per tutti. Vi è poi la seconda fase che, partendo dagli Stati Uniti si è poi estesa alla fine dell’800 a tutti i paesi industrializzati, durante la quale l’orario settimanale è diminuito da 66 a 54 ore per continuare la sua diminuzione dal 1930 al 1938. Infine vi è la terza fase, avvenuta nel secondo dopoguerra nella quale l’orario di lavoro si è attestato su 40 ore settimanali da ripartire in cinque giorni lavorativi. Il Graf.22 mostra che le ore medie settimanali lavorate nei paesi della Comunità Europea evidenziano una tendenza alla diminuzione (con l’eccezione del Regno Unito che nel periodo 1987-1991 ha registrato un lieve aumento). L’Italia e il Lussemburgo evidenziano una tendenza verso la stabilità dell’orario settimanale, mentre la Francia e il Belgio mostrano valori che segnalano una leggera diminuzione dell’orario. Danimarca, Olanda e Germania mostrano diminuzioni dell’orario di lavoro molto più evidenti rispetto agli altri paesi.
|