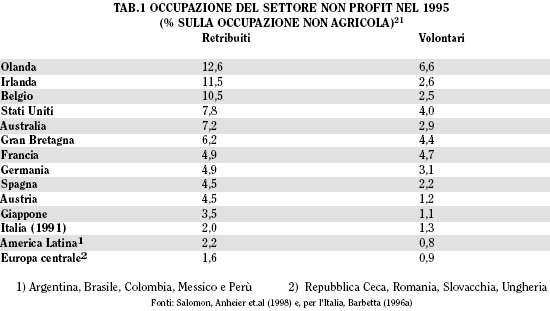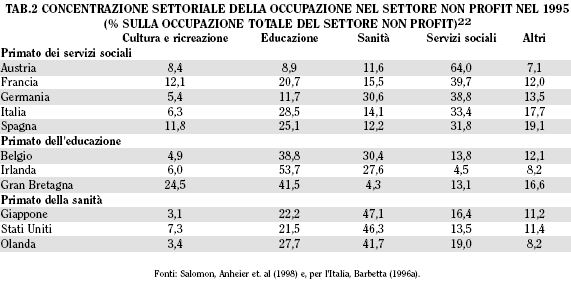![]()
Rubrica
L’analisi-inchiesta
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Luciano Vasapollo Docente di Economia Aziendale, Fac. di Scienze Statistiche, Università’ “La Sapienza”, Roma; Direttore Responsabile Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali (CESTES) - Proteo. Rita Martufi Consulente ricercatrice socio-economica; membro del Comitato Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico Sociali (CESTES) - PROTEO
“The Federal Business Revolution”
Tutti gli articoli della rubrica: analisi-inchiesta(in tutti i numeri di Proteo)
|
Aumenti della disoccupazione, bassi, se non negativi, incrementi occupazionali (e dove sono stati positivi si tratta di occupazione ad alto livello di precarietà), continui tagli allo Stato sociale, incrementi salariali sempre più bassi del tasso di inflazione reale, aumenti dei ritmi e degli straordinari, tutto ciò necessariamente porta a continui aumenti dell’indice di povertà dei più importanti paesi europei. A ciò si aggiunga il forte differenziale fra costo del lavoro e variazioni della produttività, ancora più alto negli anni ’90 rispetto agli anni ’80, andamento che evidenzia che i forti incrementi di produttività sono stati assorbiti solo dal profitto e comunque dal fattore capitale, non realizzando alcuna forma redistributiva al fattore lavoro né in termini di salario diretto, né in salario indiretto e differito.
2. Terzo Settore e privatizzazioni negli Enti Pubblici Locali: altre modalità di attuazione della Grande Riforma della P.A.
La crisi dei sistemi di Welfare esistenti ha portato alla nascita di nuove e più profonde conflittualità tra il pubblico e il privato; questo fatto ha determinato la nascita del concetto in base al quale la carenza dello Stato nelle politiche sociali possa essere colmata attraverso le organizzazioni filantropiche. In questo senso sono nati dei modelli di sviluppo dell’intreccio tra pubblico e terzo settore che meritano di essere ricordati. Si intende parlare del cosiddetto "terzo settore" ossia di quell’insieme d organizzazioni private non aventi scopo di lucro che erogano servizi utili alla collettività. In questo campo non vanno identificate solo le associazioni di volontariato ma ci si riferisce ad un vero e proprio ambito che produce sia beni sia servizi contraddistinto da una domanda e da un’offerta; va inoltre rilevato che il termine "terzo" sta a indicare il fatto che ci si riferisce ad una sfera distinta sia dallo Stato sia dal mercato. In primo luogo vi è il modello di Contract Welfare secondo il quale lo Stato ha il compito di cercare di sviluppare e favorire la nascita dei settori privati in grado di fornire in maniera più efficiente i servizi diretti di Welfare; si tratta di una riorganizzazione pubblica del terzo settore. Vi è poi il modello neocorporativo (attuato soprattutto in Italia e in Germania) secondo il quale "il coinvolgimento del terzo settore corrisponde allo sviluppo di pratiche concertative tra autorità pubbliche e grandi organizzazioni di interesse (tra cui anche organizzazioni non profit), attraverso cui vengono scambiate risorse finanziarie e consenso politico... il sostegno alle non profit avviene in assenza di una chiara regolamentazione... Il finanziamento pubblico assume una natura assistenziale, funzionale ad un utilizzo «deviato» e particolaristico delle organizzazioni non profit". [1] Nel caso del modello di Welfare universalistico, essendo lo Stato il principale garante delle politiche sociali, il terzo settore ha il compito di integrare il ruolo tenuto dall’operatore pubblico che svolge anche la funzione di controllo sulle attività non profit. Comunque, in sostanza, il ruolo del terzo settore è diverso a seconda delle impostazioni delle politiche pubbliche dei vari paesi e delle diverse relazioni tra settore privato e settore pubblico. Si cerca anche in questo modo di riformare il mercato del lavoro in una impostazione che nella realtà dei fatti si traduce, in un modo o in un altro, in progetti conformi alle dinamiche dell’accumulazione flessibile del neo-liberismo post-fordista; si tratta cioè di inserire modelli di precarizzazione e di un lavoro sottopagato flessibile e a scarso contenuto di diritti, attraverso la cosiddetta economia dell’impresa sociale, o economia del no-profit. Ecco che il terzo settore, oltre a servire per privatizzare il Welfare diventa il modo per precarizzare e flessibilizzare sempre più il mercato del lavoro. I presupposti per lo sviluppo di tale impostazione economica nascono, nelle intenzioni, dalla considerazione di uno stato diffuso di disagio sociale, da una disoccupazione che assume carattere strutturale, dall’incapacità dello Stato e dei privati di garantire una crescita sociale equilibrata della società. Tutto ciò ha portato alla nascita e allo sviluppo di un nuova tipologia di lavoro o meglio di fare impresa attraverso il cosiddetto terzo settore o settore no-profit, o le diverse forme di cooperazione ed imprenditorialità sociale. Vanno ricordati a questo punto i principali modi utilizzati per sostenere le attività private di fornitori di servizi storicamente pubblici; stiamo parlando del meccanismo del conctracting- out, dei vouchers o dei sussidi. Per quanto attiene al primo meccanismo si ricorda che con il contracting-out la parte pubblica non produce direttamente i beni e i servizi ma li affida a operatori privati attraverso delle selezioni; si tratta in sostanza di una delega al privato per la produzione di quei servizi che l’Amministrazione Pubblica non esercita più direttamente. Per quanto attiene al meccanismo dei vouchers invece si ricorda che:
"Attraverso i vouchers l’operatore pubblico distribuisce potere d’acquisto, sotto forma di «buoni» per l’acquisto di beni o servizi, ai cittadini ritenuti idonei ad ottenere la prestazione del servizio o la fornitura del bene. Si tratta di « buoni» (di valore prestabilito) che il cittadino può spendere sul mercato per procurarsi beni o servizi a cui ha diritto... La caratteristica fondamentale del voucher è quella di affidare al cittadino la scelta del fornitore privato che maggiormente soddisfa le sue esigenze" [2].
Vi è infine il meccanismo del sussidio alle organizzazioni
private che di loro volontà forniscono servizi ai cittadini; in questo caso
l’Amministrazione Pubblica finanzia determinate organizzazioni che per le loro
caratteristiche sono meritevoli di un aiuto finanziario. Le organizzazioni non profit comunque si caratterizzano per
il fatto di interessare soprattutto il settore dei servizi mentre sono quasi
del tutto assenti nella produzione industriale o nella produzione agricola;
inoltre la loro presenza è molto alta nei servizi alle persone e alle collettività
mentre sono assenti nel campo dei servizi alle imprese. Per analizzare più da vicino queste organizzazioni si ricorda
che negli Stati Uniti vi sono oltre 1,7 milioni di organizzazioni no-profit
che hanno come scopo principale l’offerta di servizi e che si mantengono attraverso
donazioni e solo in minima parte con finanziamento pubblico. In Germania il settore no-profit, molto legato alle organizzazioni
ecclesiastiche, rappresentava già a inizio anni ’90 il 3,9% dell’occupazione
totale del paese (le associazioni erano più di 350.000). Anche in Inghilterra
questo settore è molto strutturato in quanto si hanno circa 350.000 organizzazioni
di volontariato che presentano un fatturato pari a circa il 5% del PIL. In Francia
il 4,5% dell’occupazione totale è rappresentato da lavoratori del terzo settore;
in questo paese si riconosce uno stipendio a lavoratori disoccupati che si prestino
a svolgere attività di volontariato e nella Pubblica Amministrazione. Uno studio di alcuni ricercatori della John Hopkins University
di Baltimora ha analizzato dodici paesi per determinare l’impatto economico
del terzo settore sugli aggregati economici. Precisando che per questa ricerca
con il termine non profit si identifica un’organizzazione che: 1. "sia formalmente costituita 2. privata 3. non distribuisca profitti 4. sia autogovernata 5. sia volontaria, cioè non presupponga alcun meccanismo di
iscrizione obbligatoria". [3] È stato appurato che in sette paesi, il Regno Unito, la Francia,
gli USA, la Germania, l’Ungheria, l’Italia e il Giappone, nel 1990 il terzo
settore utilizzava l’equivalente di quasi 12 milioni di occupati a tempo pieno;
sempre nel 1990 il non profit è risultato essere il primo settore di nuova occupazione
in Germania, Francia e USA. Nel 1995 un altro studio della stessa Università rileva che
questo settore occupava circa 19 milioni di persone (ossia quasi il 5% dell’occupazione
totale non agricola dei 22 paesi considerati). La tabella che segue mostra chiaramente come il settore non
profit sia più esteso nei paesi a capitalismo avanzato che nei paesi in via
di sviluppo, come ad es. quelli dell’America Latina. È importante rilevare poi che gli USA, di solito ritenuto uno
dei paesi in cui questo settore è maggiormente sviluppato, in realtà evidenzino
percentuali più basse di molti paesi dell’Europa occidentale (Olanda, Irlanda,
Belgio). Altro dato interessante: in questo settore molto ampia è la
presenza di volontari, ossia di persone che lavorano ma non percepiscono alcun
reddito. La Tabella 2 [4]invece analizza la concentrazione dell’occupazione nei settori
più rappresentativi ed evidenzia per ogni paese quali sono i campi più diffusi:
si vede allora che mentre in paesi quali l’Austria, la Francia, la Germania,
l’Italia e la Spagna il primato va al settore dei servizi sociali, il primato
della sanità va a paesi come il Giappone, gli Stati Uniti e l’Olanda e quello
dell’educazione a Belgio, Irlanda e Gran Bretagna. Nel nostro Paese il settore non profit ha i suoi primi sviluppi
addirittura nel Medioevo con le grandi istituzioni caritatevoli, sanitarie ed
educative nate in quel periodo; nella seconda metà dell’Ottocento poi, il movimento
operaio e quello cattolico hanno sviluppato opere sociali di natura anche economica
e finanziaria. Una ricerca svolta dall’IRS (Istituto per la Ricerca Sociale
di Milano) rileva che nel nostro Paese (nel 1991) le organizzazioni non profit
offrivano l’1,8% degli occupati nazionali (va ricordato che a questo dato vanno
aggiunti i volontari che non percepiscono retribuzione); ed ancora uno studio
svolto dall’IREF (Istituto Ricerche Educative e Formative) rileva che sempre
nel 1991 il terzo settore rappresentava circa il 5% dell’occupazione. "Il terzo settore comprende organizzazioni rispondenti
ai seguenti cinque requisiti: essere formalmente costituite, essere private,
non distribuire profitti, essere auto-governate, implicare un certo grado di
partecipazione volontaria. Il volontariato è certamente una componente importante
del terzo settore, ma non l’unica. Si trovano fondazioni bancarie e di ricerca,
cooperative sociali e associazioni culturali, comunità per il recupero dei tossicodipendenti
e sindacati, associazioni imprenditoriali e ospedali gestiti da religiosi, club
archeologici, organismi non governativi e centri di formazione professionale..." [5] Ed ancora: nel 1993 vi erano 430.000 persone occupate in queste
associazioni ed il numero arriva a 470.000 se si includono gli occupati nelle
organizzazioni professionali, imprenditoriali e sindacali; vi sono poi da aggiungere
circa 290.000 volontari e oltre 15.000 obiettori di coscienza. I dati del rapporto IREF indicano che tra il 1983 e il 1994
si è avuta una crescita degli iscritti ad associazioni sociali (con una percentuale
del 23,2% della popolazione tra i 18 e i 74 anni per circa 9,5 milioni di persone). Un’indagine più recente dell’IREF (1998) ha rilevato come il
settore non profit abbia impiegato circa 690.000 persone occupate in varie organizzazioni
(180.000 in associazioni, 9.000 in organizzazioni di volontariato, 81.000 in
cooperative sociali e 420.000 in altre organizzazioni non profit). Va ricordato che le associazioni e le fondazioni (enti non
commerciali) usufruiscono di un particolare trattamento fiscale agevolato. Anche le associazioni di volontariato hanno dei benefici fiscali,
qualsiasi sia la loro forma giuridica; secondo la legge del 1991 n. 266 l’attività
di volontariato è quell’ "attività personale, spontanea, gratuita e senza
fini di lucro, con fini di solidarietà". [1] Cfr. C Ranci, A. Vanoli, "Beni pubblici e virtù private", Fondazione Adriano Olivetti, 1994, pag. 27. [2] Cfr. G.P.Barbetta, "Il settore non profit italiano", il Mulino, 2000, pag. 50, 51. [3] Cfr. G.P. Barbetta, "Il settore non...", op. cit., pag. 26. [4] Cfr. G.P. Barbetta, "Il settore non...", op. cit., pag. 56. [5] Cfr. CNEL, Rapporto su: Statualità, mercato..., op. cit., pag. 70.
|