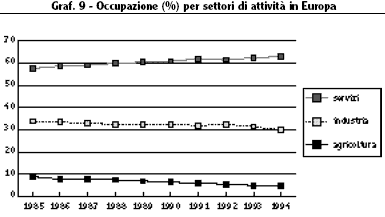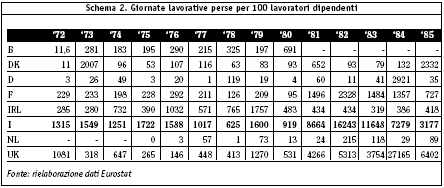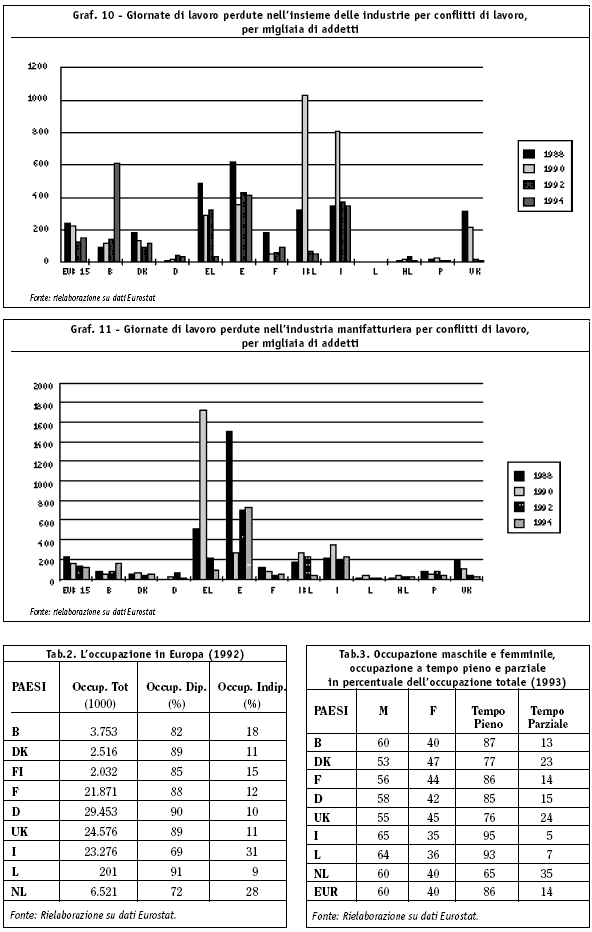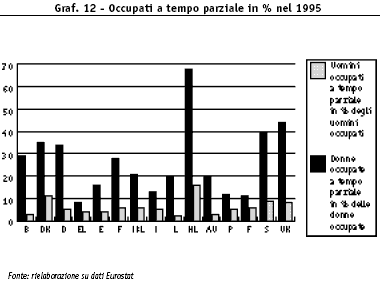![]()
Rubrica
L’analisi-inchiesta
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Luciano Vasapollo Docente di Economia Aziendale, Fac. di Scienze Statistiche, Università’ “La Sapienza”, Roma; Direttore Responsabile Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali (CESTES) - Proteo. Rita Martufi Consulente ricercatrice socio-economica; membro del Comitato Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico Sociali (CESTES) - PROTEO
Ristrutturazione capitalistica
Le tendenze macroeconomiche del processo di ristrutturazione capitalistica
Tutti gli articoli della rubrica: analisi-inchiesta(in tutti i numeri di Proteo)
|
3.L’occupazione
Tra i diritti fondamentali sanciti dai Trattati U.E. sono reputati decisivi quello all’occupazione, alla protezione sociale; si tratta dunque di impegnare gli Stati verso una politica di sviluppo durevole, grazie a strumenti d’azione, e di solidarietà. E’ interessante ricordare che l’articolo 2 del trattato sull’Unione Europea recita testualmente: “La Comunità ha il compito di promuovere ...uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell’insieme delle comunità, una crescita sostenibile, ...un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita... e la solidarietà tra gli Stati membri.” Gli obiettivi vengono descritti più minutamente nell’art.3: “Ai fini enunciati all’art.2, l’azione della Comunità comporta... l’abolizione, tra gli stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all’entrata e all’uscita delle merci ...una politica commerciale comune ...una politica comune nei settori dell’agricoltura e della pesca; una politica comune nel settore dei trasporti ...una politica nel settore sociale comprendente un Fondo Sociale Europeo; ...una politica nel settore dell’ambiente ...una politica nel settore della cooperazione allo sviluppo...”. Tali premesse sono rimaste solo buoni principi in quanto il processo mondiale di ristrutturazione capitalistica ha provocato anche in Europa turbolenze e instabilità che hanno determinato, nel conflitto aspro tra diverse economie capitalistiche, una crescita dell’inflazione e un aumento del debito pubblico che ha realizzato livelli patologici, a cui si è aggiunta la turbolenza di precari rapporti monetari. Oggi è il mercato a dettare le regole e la flessibilità e variabilità del mercato hanno operato una condizione che ha proposto una modificazione profonda dell’organizzazione del lavoro, della produzione e quindi dell’occupazione. Tutto questo in un periodo di crescita rallentata. Il potere di controllo sociale dei lavoratori è stato l’oggetto di uno scardinamento prodotto dalla ristrutturazione e dalla grande offensiva politica al cui centro c’è stato l’attacco al costo del lavoro, a tutte le forme di salario diretto e differito compresa la sua proiezione sullo stato sociale, attraverso la ristrutturazione del mercato del lavoro. Tutto ciò ha comportato per la nuova borghesia imprenditoriale una nuova forma di sviluppo capitalistico, che si è evidenziato negli ultimi venti anni anche attraverso trasformazioni profonde nell’ambito della società europea, trasformazioni che hanno generato la nascita di nuove esigenze e bisogni legati ai diversi modi di vita e alla mutata struttura economico-produttiva, (nel Graf.9 si evidenzia il crollo dell’occupazione agricola e il continuo aumento nel terziario).
E’ importante rilevare che in realtà queste nuove esigenze restano comunque insoddisfatte e i lavoratori hanno sempre dimostrato ciò in termini di conflitto contro i processi di ristrutturazione del capitale. Un dato interessante ci viene dall’analisi delle giornate lavorative perdute per conflitti di lavoro dall’inizio degli anni ’70 fino alla prima metà degli anni ’90 (Cfr. Schema 2 e i Graf.10 e 11). Risalta immediatamente che l’Italia, mostra sempre un andamento molto marcato dei valori a conferma di una forte sensibilità dei lavoratori ai problemi legati alla loro condizione. [1]
Anche la nuova ondata di progresso tecnologico in settori come l’elettronica, l’informatica e le telecomunicazioni, pur aumentando l’andamento già in crescita della produttività totale non è stata accompagnata da una corrispondente crescita dei livelli occupazionali. In effetti le risorse create non sono state riutilizzate e la relazione tra creazione e distruzione di lavoro non poteva essere positiva, né sono state create le condizioni per occupare la crescente forza lavoro e ridurre la disoccupazione. Per comprendere appieno la gravità del problema è sufficiente pensare al calo drammatico che si è avuto nei primi anni ‘90 nel tasso di occupazione industriale ed agricolo. Dal 1991 al 1996 l’occupazione nei servizi è aumentata di circa il 4% mentre nel settore industriale è diminuita del 3% e nel settore agricolo dell’1%. Nel 1996 risultavano essere occupati nell’industria il 30% dei lavoratori, nell’agricoltura il 5% ed il restante 65% nel settore dei servizi. Nel 1996 in Belgio, in Germania e in Grecia il settore occupazionale più rilevante risulta essere quello dei servizi (con valori rispettivamente intorno al 75%, al 65% e al 60%); anche in Spagna ed in Francia ed in Olanda il settore dei servizi impiega il maggior numero di occupati (rispettivamente circa il 65%, il 70% ed il 70%). Il Regno Unito conferma la tendenza degli altri stati (gli occupati nei servizi sono circa il 70%). Se è pur vero che l’occupazione nei servizi costituisce la principale porzione di lavoro nei paesi europei va ricordato che questo settore si caratterizza per la presenza di una maggiore frequenza di lavoro a tempo parziale (circa il 20% è rappresentato da lavori ad orario ridotto con una partecipazione molto elevata di personale femminile) e per una elevata proporzione di lavoratori autonomi e di piccole e medie imprese (circa il 15% del lavoro in servizi è svolto da prestatori d’opera, collaboratori domestici, lavoratori autonomi). La maggiore presenza di occupati nei servizi si accompagna, quindi, ad una rilevante partecipazione delle donne (circa il 49,4% degli occupati nei servizi è rappresentata dalle donne a fronte di una quota molto inferiore, il 28%, impiegata nell’industria). Considerato che, in rapporto all’occupazione totale, la media europea dell’occupazione dipendente è di circa l’80% a fronte di un valore del 20% di occupazione indipendente, dalla Tab.2 emerge chiaramente che il Lussemburgo, Regno Unito, Germania, Francia, Danimarca si discostano dalla media per una elevata presenza di occupazione dipendente (90%circa) rispetto a quella indipendente; il contrario si registra invece in Italia con valori di occupazione dipendente del 69% e indipendente del 31%, anche se c’è da considerare che il nostro Paese si caratterizza per una forte componente di “falso” lavoro autonomo (si tratta dell’enorme mondo delle “partite IVA” che spesso configurano forme di lavoro subordinato). E’ interessante rilevare che in Europa la media di occupazione maschile si attesta intorno al 60%, la Tab.3 mostra chiaramente che l’Italia è il paese che più si discosta dalla media europea con valori del 65% per l’occupazione maschile; la Danimarca, al contrario, registra differenze minori tra i due sessi con valori del 53% (occup. maschile) e del 47 % (occup. femminile); segue subito dopo il Regno Unito (55% e 45%) e la Francia (56% e 44%). Per quanto riguarda il regime di tempo di lavoro va rilevato che in Europa l’86% della popolazione lavora a tempo pieno a fronte di un restante 14% impiegato a tempo parziale. In Olanda la percentuale dei lavoratori a tempo parziale arriva la 35%, in Danimarca al 23% e nel Regno Unito al 24%; mentre Lussemburgo e Italia si attestano su valori molto bassi (rispettivamente il 7% e il 5% dei lavoratori è occupato a tempo parziale). E’ questo un dato particolarmente interessante: negli ultimi anni un numero sempre crescente di donne è entrato a far parte del mondo del lavoro (in Danimarca oltre il 50% della popolazione femminile è economicamente attiva, in Irlanda oltre il 21%, in Spagna circa il 20%) anche se questi dati apparentemente positivi ed incoraggianti devono essere valutati attentamente, poiché la presenza femminile nel mercato del lavoro è avvenuta senza alcuna specializzazione o con una specializzazione molto bassa, oltre che con salari inferiori a quelli degli uomini e con forte precarizzazione e flessibilità. Si nota, infatti, nel Graf.12 come in tutti i paesi europei le donne occupate a tempo parziale riferite al totale delle donne occupate siano sempre di gran lunga molto più alte delle percentuali maschili.
I settori nei quali la presenza femminile è più elevata restano quelli della sanità, dell’istruzione e dei servizi domestici mentre i lavori a livello dirigenziale e tecnico restano monopolio della popolazione maschile. Ad esempio nella Pubblica Amministrazione il 40% della forza lavoro è costituito da donne, ma solo il 10% di queste riveste funzioni manageriali e non sono quasi rappresentate a livelli superiori. Per quanto riguarda la retribuzione si ha una differenza di salario che va dal 15 al 35% e questa differenza si accentua tra le lavoratrici non manuali (si arriva al 40%) in quanto di solito le donne hanno soprattutto compiti impiegatizi mentre gli uomini più lavori a carattere dirigenziale. La mancanza di politiche per la qualificazione professionale delle donne le porta ad essere maggiormente esposte al problema della disoccupazione e del precariato; infatti ad eccezione della Svezia, del Regno Unito e della Finlandia in tutti gli altri Paesi dell’Unione Europea il tasso di disoccupazione femminile è molto più elevato di quello maschile. Inoltre le tendenze verso nuove e moderne possibilità occupazionali presentano una elevata concentrazione maschile di nuovi posti di lavoro di medio-alto livello formativo. Infatti negli anni 1994-1996 vi è stata una crescita del numero dei dirigenti, funzionari e tecnici mentre si è ridotto il numero dei lavoratori di posizioni di base. Ciò è dovuto soprattutto ai processi di innovazione tecnologica e alla voluta mancanza di adeguate politiche di formazione, soprattutto femminile; si pensi tra l’altro che nel 1996 circa il 35% dei disoccupati dei paesi della Comunità Europea di età superiore ai 25 anni non aveva alcun titolo di studio superiore all’istruzione di base. I motivi che hanno portato alla situazione odierna sono molteplici: ci troviamo al termine del ciclo taylorista-fordista-keynesiano caratterizzato da produzioni che si imponevano sul mercato e quindi permettevano un controllo sull’economia. Oggi è la divinità del mercato a dominare e la disoccupazione di massa, strutturale, si innesta in questo meccanismo come espressione di una scelta politica che consente di controllare i salari e la forza lavoro, provocando intensi processi di precarizzazione e flessibilità del lavoro e del salario. Il fenomeno della deregolamentazione del rapporto di lavoro, la parcellizzazione, la flessibilità e la variabilità dell’occupazione, conseguenza della fase di postfordismo che si sta vivendo, ha portato da un lato alla nascita di lavori che non permettono di soddisfare a chi li esercita i principali e basilari bisogni ed esigenze umane (con la conseguenza così di accrescere il numero di coloro che vivono al di sotto o al limite della soglia di povertà); dall’altro lato ci si trova di fronte alla nascita sempre più frequente di microimprese (sino ad arrivare ad imprese individuali gestite da lavoratori espulsi dal ciclo produttivo) che, oltre a non garantire alcuna stabilità, sono soggette più di altre al ricatto del grande capitale. L’aspetto che si evidenzia maggiormente è la precarizzazione del lavoro come elemento costitutivo della nuova divisione del lavoro. Ne sono un esempio il contratto di prestito delle forze-lavoro, la competizione mondiale tra i lavoratori, la svalutazione e svalorizzazione del lavoro dipendente salariato, la perdita di autonomia contrattuale del lavoratore dipendente. A tale processo si unisce un attacco al salario diretto, indiretto, differito e sociale; vengono messi in discussione il servizio sanitario nazionale con violenti processi di privatizzazione, la previdenza sociale, la scuola, l’assistenza e i servizi pubblici in genere. Negli anni 1975-1995 a fronte di una crescita di occupati (cioè lavoratori che hanno un qualsiasi tipo di occupazione) negli Stati Uniti di circa il 45%, in Europa si è avuto un incremento del 12,6% e in Italia il livello di occupazione nel 1995 è cresciuto di appena 400.000 unità rispetto a venti anni prima (nel 1997 si è avuto nell’industria in senso stretto un decremento dello 0,6%). A ciò occorre aggiungere il fatto che la disoccupazione è diversificata oltre che per categorie di persone anche per l’età e per la collocazione territoriale (In Italia tra il 1975 e il 1995 si è registrato un alto differenziale del tasso di disoccupazione tra Nord e Sud). Nello stesso periodo sia in Europa sia negli USA si è manifestato inoltre un crescente divario tra la cosiddetta “economia sommersa” e il lavoro “tutelato”; si ha anche uno sfasamento sempre più marcato tra produzione ed occupazione in quanto se la produzione diminuisce l’occupazione cala mentre non è vero il contrario: ossia ad un amento della produzione non si accompagna un pari aumento di occupazione. A conferma di ciò si ricorda che negli ultimi tre anni la crescita di prodotto nel terziario (nei servizi vendibili) è stata accompagnata da una notevole perdita di posti di lavoro, in particolare in Europa complessivamente. Anche l’elasticità nell’andamento della produzione, ossia la misura del prodotto interno lordo e andamento dell’occupazione che in passato era in rapporto tre a uno, (cioè ad un incremento pari al 3% del PIL corrispondeva un aumento dell’1% ) rimasta stabile per diversi anni è ora decrescente. Inoltre, nessun paese dell’Unione Europea è riuscito ad assorbire l’aumento di offerta di lavoro femminile e giovanile: in Italia il tasso di disoccupazione femminile è del 16% contro il 13% in Europa e il 5,5% negli USA; ed ancora in Italia un terzo della disoccupazione totale è rappresentato da giovani mentre in Europa i giovani senza lavoro sono un quinto e negli USA un ottavo del totale disoccupati. In questa situazione sono nati e proliferati i contratti atipici di lavoro quali il contratto di solidarietà, il contratto di formazione lavoro, i contratti di inserimento e il lavoro interinale, ossia il lavoro in affitto. I vantaggi per le imprese nell’assunzione dei lavoratori temporanei sono molteplici: oltre alla possibilità di corrispondere salari più bassi motivati dalla poca esperienza del lavoratore e alla totale assenza di costi di formazione, che sono di solito a carico dell’agenzia di lavoro interinale, si registra un aumento della flessibilità e una maggiore fluttuazione della domanda (le imprese possono svolgere attività legate a determinati periodi dell’anno). Vi è infine la possibilità di utilizzare dei lavoratori specializzati solo nel momento del bisogno e ad un costo inferiore. Una stima effettuata per cercare di quantificare il lavoro sommerso ha rilevato che in Europa nel 1996 il rapporto fra lavoratori sommersi e lavoratori in regola era di 1 a 4; attraverso il ricorso al lavoro nero in Europa, sempre nel 1996 si realizza oltre il 23,3% della produzione di beni e servizi. Va rilevato però che è molto difficile effettuare delle valutazioni scientifiche e quindi ad alta scientificità su questo tipo di lavoro in quanto i dati non sono disponibili per tutte le categorie e si rischia inoltre di non cogliere la reale dimensione del fenomeno; uno studio effettuato recentemente ha messo in risalto che il lavoro nero produce circa il 26% del PIL in Italia.
Se si guardano i dati relativi al tasso di disoccupazione europea ci si trova in una situazione paradossale: infatti a fronte di oltre 19 milioni di disoccupati ufficiali (oltre il 10% della popolazione attiva) a fine 1997, si hanno circa 13 milioni di disoccupati occulti o “invisibili”. Questa categoria di “non occupati” comprende i precari, i sottoccupati, le persone che hanno lavorato solo qualche ora in un mese, oltre ai disoccupati “scoraggiati” che non si iscrivono neppure più al collocamento. Ciò è dovuto anche al diverso modo di rilevazione statistica dei disoccupati. Infatti, in alcuni paesi europei, e anche negli stessi Stati Uniti, il solo fatto di lavorare poche ore a settimana o in un mese comporta la classificazione di occupati. Si arriva così a oltre 32 milioni di disoccupati nell’Unione Europea e tra questi non vengono contabilizzati i cosiddetti “lavoratori in nero” di cui difficilmente si può avere un riferimento quantitativo vicino alla realtà.
Qualche esempio: l’Employment policy institute dopo accurate indagini effettuate in Gran Bretagna conclude rilevando che il tasso di disoccupazione dichiarato ufficialmente del 5% è in realtà un dato molto “ottimista” essendo invece quello reale molto vicino al 15%. In Francia la situazione non è molto diversa: i dati ufficiali parlano di circa 3,5 milioni di disoccupati, in realtà i dati effettivi portano il numero di disoccupati a circa 8 milioni. L’istituto IAB in Germania calcolando le categorie a carico della previdenza sociale segnala oltre 8 milioni di disoccupati a fronte dei 4,5 milioni di disoccupazione ufficiale. L’Olanda che registra un tasso ufficiale di disoccupazione del 7,4%; la realtà però è molto diversa essendo il tasso reale di disoccupazione intorno al 20%. Anche il nostro Paese si trova in una situazione simile: a fronte di 3 milioni di disoccupati “ufficiali” si hanno in realtà oltre 7 milioni di disoccupati “reali” . [1] “Diversamente dai principali aggregati socioeconomici quali popolazione, occupazione, prodotto interno lordo, che presentano andamenti relativamente regolari, le serie statistiche che riguardano i conflitti di lavoro sono caratterizzate da brusche variazioni, in corrispondenza ad esempio di scioperi generali o scioperi settoriali di lunga durata. I conflitti di lavoro sono connessi a vertenze (contratti collettivi o questioni finanziarie o sociali) che in certi casi si protraggono a lungo e non consentono quindi confronti significativi tra gli anni”, cfr. Annuari Eurostat, vari anni.
|