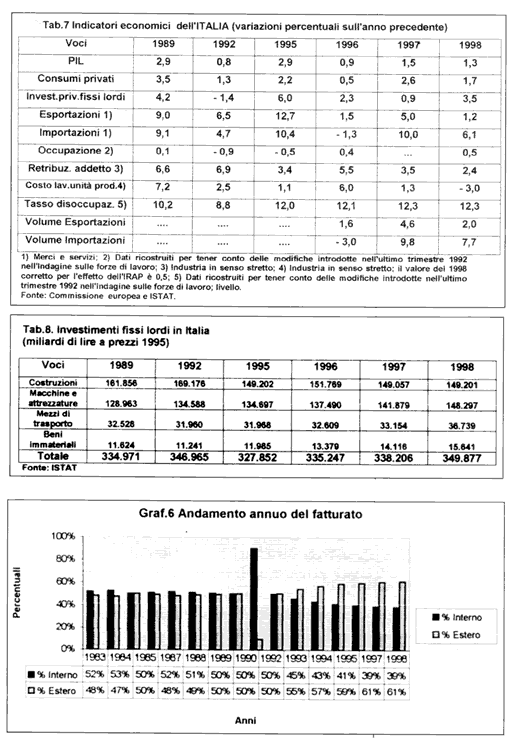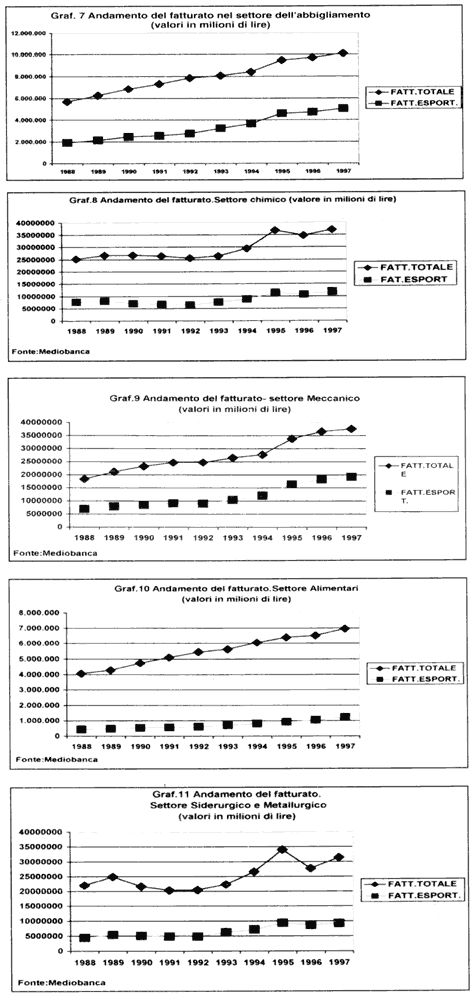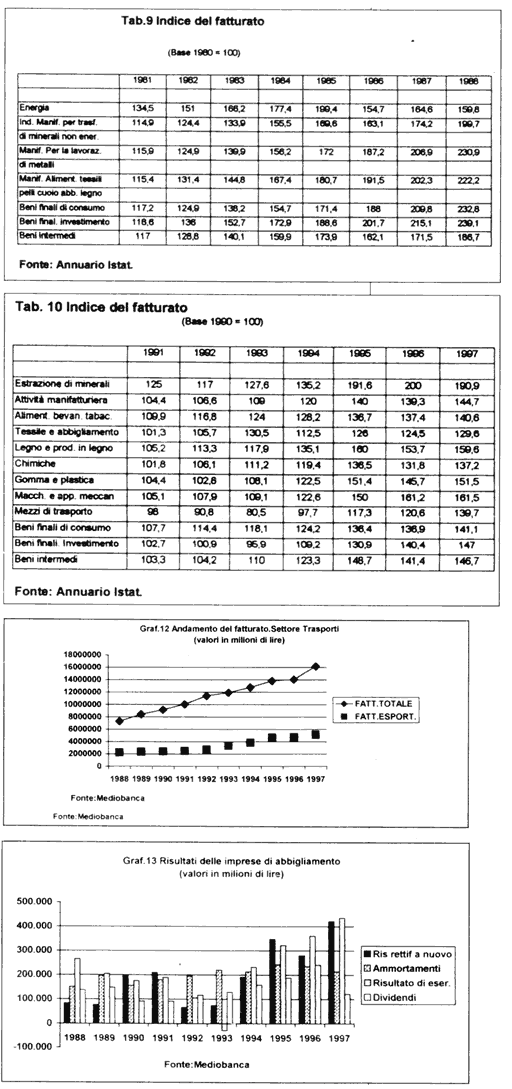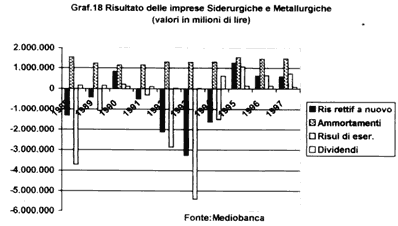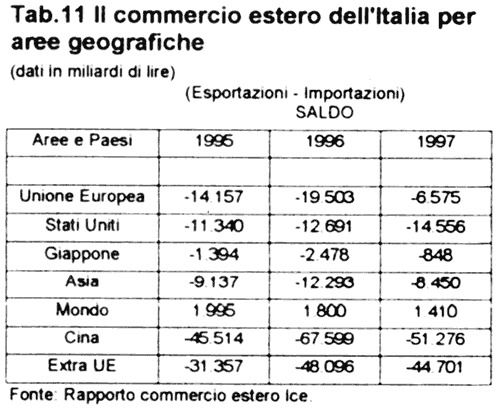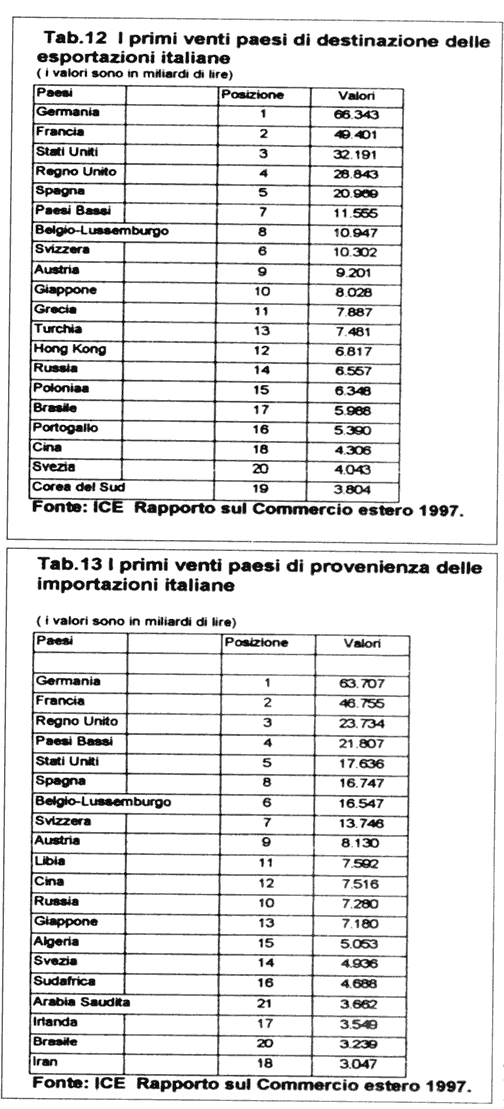![]()
Rubrica
L’analisi-inchiesta
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Luciano Vasapollo Docente di Economia Aziendale, Fac. di Scienze Statistiche, Università’ “La Sapienza”, Roma; Direttore Responsabile Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali (CESTES) - Proteo. Rita Martufi Consulente ricercatrice socio-economica; membro del Comitato Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico Sociali (CESTES) - PROTEO
Le Tendenze macroeconomiche del processo di ristrutturazione capitalistica
Tutti gli articoli della rubrica: analisi-inchiesta(in tutti i numeri di Proteo)
|
Si nota, invece, per il Giappone negli ultimi anni una situazione economica che continua a peggiorare, realizzando un calo del PIL di circa il 3%, e un crollo degli investimenti fissi con variazioni spesso negative, rispetto all’anno precedente; si tratta inoltre di crisi che ha colpito fortemente l’andamento occupazionale dei salari. Nonostante alcuni interventi sul mercato monetario che per favorire la domanda e gli investimenti hanno portato i tassi di interesse a brevissimo termine ad una percentuale molto vicina allo zero, è avvenuto che l’enorme liquidità così liberata è continuata ad affluire sui mercati internazionali e non sul mercato interno, accentuando la posizione netta sull’estero del Giappone. Ciò comporta alti rischi sul mercato internazionale di cambi visto che gli Stati Uniti registrano invece un disavanzo corrente per il 1998 di 80 miliardi di dollari e l’area dell’euro evidenzia una diminuzione di 20 miliardi dell’attivo. Sempre per il 1998 i paesi dell’area dell’euro hanno registrato un incremento del PIL del 2,9% contro l’aumento del 2,5% del 1997; tale performance è stata la più alta degli ultimi dieci anni, dovuta anche ad un buon andamento della domanda interna, anche se all’incremento del prodotto nell’Unione Europea non è però corrisposto un miglioramento dell’andamento del mercato del lavoro che segnala ancora circa un 11% medio del tasso di disoccupazione. Anche dai dati precedentemente analizzati si può evincere che il sistema mondiale riproduce su scala ampliata la contraddizione centro-periferia, (vedi ad esempio precedente Tab.2), tenendo ancorati, ad un luogo e ad una funzione determinanti per la propria produzione interna o per l’esportazione, i diversi paesi che ne fanno parte. Questa tendenza configura una struttura mondiale che permette ai paesi sviluppati di giocare un ruolo dominante nel settore industriale, agricolo, finanziario, militare e tecnologico, che può essere accresciuto attraverso la lotta economico-finanziaria e dei mercati del capitale soprattutto contro il Terzo Mondo. La “globalizzazione dell’economia” è voluta dal libero gioco delle leggi del mercato, ma bisogna valutare questo gioco di mercati in tutta la sua pienezza, mettendo l’accento principalmente sulla globalizzazione della concorrenza, sull’effetto supposto dell’apertura delle frontiere per la crescita degli scambi di beni e servizi e anche sulle dinamiche dei flussi internazionali di capitali a breve termine. Tutto ciò non è a vantaggio del consumatore, apparentemente libero di acquistare i prodotti ai prezzi più bassi grazie all’apertura dei mercati, allo smantellamento delle regolamentazioni pubbliche e al totale regime di concorrenza tra le imprese. Il contenuto effettivo della globalizzazione è dato, non dalla mondializzazione degli scambi, ma da quella delle operazioni del capitale, tanto sotto la forma industriale che finanziaria. All’origine della crescita della sfera finanziaria esistono dei flussi verso questo settore di frazioni di ricchezza che sono nate all’interno della produzione e che, prima di essere travasati nelle diverse forme nei vari paesi attraverso la via delle imposte e trasferiti verso la sfera finanziaria a titolo di pagamento degli interessi e di rimborso di una frazione del debito pubblico, avevano assunto la forma di salari e di stipendi, o di redditi operai, contadini e artigiani. Questi flussi sono all’origine dei meccanismi di accumulazione perversi in cui la caccia alle economie nazionali sono finalizzate al dominio del capitale finanziario e sono parte del rapporto di competizione internazionale tra poli imperialisti, mediati da compromessi all’interno delle organizzazioni sovranazionali del capitale finanziario (G8, BM, FMI, OCSE, BEI, BRI, ONU) ed in quest’ambito deve, o almeno dovrebbe, giocare il suo ruolo l’UE, e quindi l’euro, con una funzione, inizialmente utile anche agli USA, come meglio si vedrà successivamente.
1.2. L’andamento del fattore capitale in Italia
Prima di analizzare i caratteri dello scontro politico-economico fra il polo imperialista statunitense e quello europeo è interessante verificare alcune tendenze avute dai margini di profitto, e in genere dai parametri riferiti al fattore capitale, nel nostro paese negli ultimi anni per cercare di comprendere se e in che modo agisce la competitività delle imprese italiane nei confronti degli altri paesi occidentali nel nuovo contesto di globalizzazione. Dal trend di crescita economica di quasi tutta l’area dell’euro, si discosta completamente l’Italia (cfr. Tab.7 e Tab.8) che evidenziano negli ultimi anni tra le peggiori performance dell’area euro per i più importanti indicatori macroeconomici, compresa una scarsissima dinamicità positiva degli investimenti, come si era già evidenziato in precedenza.
Le tabelle indicano una economia sicuramente in difficoltà, in particolare con forme dirette o indirette di contrazioni del reddito. Ad esempio a fronte di un sempre alto tasso di disoccupazione (sempre superiore al 12%) e a bassi incrementi occupazionali (dovuti esclusivamente a forme di lavoro atipico, interinale, part-time, LSU, ecc.) si realizzano nel contempo scarsi incrementi dei consumi privati a causa di una contrazione dei redditi da lavoro e una scarsa propensione agli investimenti privati interni, anche perchè i capitali fuggono sempre di più all’estero alla ricerca di paradisi fiscali, di speculazione finanziaria e di costi del lavoro sempre più bassi. Si noti invece l’enorme incremento in Italia dei profitti. Infatti ricordando che la redditività viene valutata attraverso il tasso di profitto, ossia il profitto in rapporto al valore del capitale, e il margine di profitto, ossia il profitto in rapporto al valore aggiunto, va evidenziato che la tendenza alla diminuzione dei margini di profitto avutasi in Italia negli anni 1988-1992 è stata sostituita da una forte crescita di tale margine negli anni successivi dovuta soprattutto alla svalutazione della lira, alla diminuzione dei costi di produzione (principalmente il lavoro) e all’aumento dei prezzi dei prodotti destinati all’esportazione. Negli anni 1993-1995 si è avuto un incremento della domanda interna per beni di uso durevole e di investimento; il fatturato è aumentato del 15,7% ( in termini nominali) e del 7,4% (in termini reali). Nel 1995 si è avuto nel complesso un utile netto rettificato di oltre 6.600 miliardi (ossia l’1,4% del fatturato), con un apporto di oltre 1.150 miliardi da parte delle imprese pubbliche (ossia il 2,2% del fatturato). Sempre in questi anni si è realizzato un incremento del 5,5% della remunerazione lorda del capitale in termini di valore aggiunto, ciò è stato dovuto soprattutto ad uno sviluppo della produttività del lavoro (14%) rispetto a quello del costo del lavoro unitario (5%). In sostanza la Centrale dei Bilanci registra che “la fase di espansione delle attività produttive ha ulteriormente incrementato i fabbisogni operativi derivanti sia dall’intensità degli investimenti tecnici sia dalla lievitazione del capitale circolante, raggiungendo il 7% del fatturato rispetto al 6.5% del 1994. La crescita dei margini si è tradotta in un incremento dell’autofinanziamento ante gestione finanziaria ed imposte di 1,5 punti percentuali, al 10,5% in termini di fatturato, mentre a livello di autofinanziamento netto la crescita è stata più contenuta (+0,8 punti percentuali, al 6,8%) per un aumento delle componenti distributive". Ricordando che, secondo la definizione fornita dall’ISTAT, il fatturato è dato da: “l’ammontare di tutte le fatture emesse nel periodo di riferimento per vendite sul mercato interno e su quelli esteri. In esso sono comprese anche le vendite di prodotti non trasformati dall’impresa e le fatture per prestazioni di servizi e per lavorazioni eseguite per conto terzi su materie prime da essi fornite; sono però escluse le vendite di capitali fissi dell’impresa” [1] , è interessante mostrare l’evoluzione di tale parametro negli anni 1983-1998 distinguendo la parte interna da quella estera. Il Graf.6 e la relativa tabella dei dati mostrano chiaramente che la distribuzione fra il fatturato interno e quello esterno è quasi sempre intorno al 50% (l’unica vera eccezione si riscontra nel 1991 quando il fatturato interno è il 90% e quello estero il 10%). L’evidente tendenza all’aumento del fatturato estero rispetto a quello interno registrata dal 1996 in poi è dovuta all’internazionalizzazione dei mercati e alla conseguente sempre maggiore presenza di imprese italiane all’estero. Nei Graff. 7,8,9,10,11,12 seguenti si evidenzia l’andamento a livello settoriale del fatturato mostrando il fatturato totale e accanto il fatturato all’esportazione. Si evince immediatamente che sia nel settore dell’abbigliamento (in cui il valore del fatturato estero è quasi triplicato nel 1997 rispetto al 1988) sia nel settore meccanico ed in quelli siderurgico e dei trasporti ( i cui valori sono più che raddoppiati) si può riscontrare, così come ad esempio per il settore energetico, un significativo numero di imprese che hanno deciso di delocalizzarsi o che sono entrate a far parte di filiere estere di produzione.
E’ importante a questo punto analizzare anche l’indice del fatturato, ossia la variazione del valore delle vendite (sul mercato interno e su quello estero) delle imprese industriali a prezzi correnti (Istat) per meglio comprendere le dinamiche dell’evoluzione economica e industriale dell’Italia.
Nelle Tabb.9, 10, ponendo come base per l’indice nella prima tabella l’anno 1980 uguale a 100 e l’anno 1990 uguale a 100 nella seconda, si nota immediatamente che specialmente negli ultimi anni si è registrata una notevole crescita dell’indice dovuta soprattutto al forte ampliamento della parte estera e quindi ai processi di internazionalizzazione produttiva delle imprese italiane. Questo aumento dell’indice del fatturato ha toccato quasi tutti i settori economici ed in particolare i settori dell’industria che più si sono mostrati dinamici nel realizzare filiere produttive internazionali. Solo nel 1996 si è registrato un leggero calo da imputare alla diminuzione del fatturato interno (quello estero è invece cresciuto ancora). Si è avuto inoltre un forte aumento, negli ultimi anni, del fatturato per i beni finali di consumo e per i beni finali di investimento; i beni intermedi, significativamente cresciuti nel 1994 e 1995 hanno registrato un lieve calo nel 1996. I Graff. 13,14,15,16,17,18 evidenziano con immediatezza i risultati ottenuti dalle imprese distinte per settori [2]. Appare chiaro che il settore chimico, quello dei trasporti, siderurgico e metallurgico hanno fatto registrare degli utili negativi; va rilevato però che essendo la voce ammortamento molto elevata per tutti questi settori, tali risultati potrebbero essere spiegati in parte dalla facile usura degli impianti e in parte dal fatto che essendo comunque l’ammortamento una voce “negativa” in un bilancio contabile, questo ha avuto un peso significativo fra i costi rispetto all’andamento delle voci di ricavo.
L’ultimo rapporto di Mediobanca del 1999, che analizza i dati aggregati di 1755 società italiane (un campione che rappresenta oltre il 40% del fatturato complessivo), dati riferiti all’anno 1998, mette in evidenza quanto già si era sostenuto in questa parte del’analisi-inchiesta e nelle due parti precedenti (vedi Proteo 3/98 e Proteo 1/99). Infatti le imprese italiane hanno raggiunto nel 1998 un vero e proprio record per i profitti, con un incremento del 53% rispetto all’anno precedente degli utili netti. Ma ciò è avvenuto senza un corrispondente aumento del fatturato, con investimenti che continuano ad essere inferiori a quelli di dieci anni fa e a scapito dell’occupazione, che prosegue il suo trend ormai pluriennale al ribasso. Per evidenziare soltanto alcuni dati si tenga conto che, per lo stesso campione di imprese e rispetto all’anno 1997, gli utili netti nel 1998 si sono incrementati di 8.000 miliardi di lire, passando da 15.000 miliardi di lire a 23.000 miliardi (nel 1996 gli utili netti erano 10.000 miliardi di lire). In particolare tale incremento complessivo del 53% è avvenuto con pesi diversi rispetto alle tipologie d’impresa: ad esempio l’utile netto delle imprese pubbliche è aumentato del 36% mentre quello delle private del 32%, ed il settore terziario ha evidenziato il miglior risultato con un incremento annuo del 70%. Nel 1998 il giro di affari complessivo ha segnato un incremento totale del fatturato soltanto dell’1% sull’anno precedente, con un 6,9% di incremento del giro di affari nel terziario e una diminuzione dello 0,3% per il totale dell’industria; in più si tenga conto che il mercato interno ha segnato un aumento delle vendite soltanto dello 0,4%, contro il 6% del 1997 a conferma di una domanda interna molto debole, mentre le esportazioni sono cresciute del 2,7%, dato inferiore al 1997 anche a causa di una maggiore dinamica e aggressività da parte dei paesi asiatici. Si consideri, inoltre, che si deve evidenziare una flessione delle esportazioni in settori di importanza primaria come il tessile-abbigliamento, il chimico-energetico, mentre andamenti positivi nell’esport vengono segnalati per il settore meccanico-elettronico, i trasporti e le imprese di impiantistica e costruzioni. Si noti che il forte incremento dei profitti non è stato, quindi, dovuto a particolari incrementi delle vendite, cioè del fatturato, né a particolari risultati positivi nell’andamento del valore aggiunto, nonostante il netto calo dei prezzi dei prodotti di base e delle materie prime, con un abbattimento sostanziale nel prezzo del petrolio. Se a ciò si aggiunge una buona tenuta del Margine Operativo Lordo Globale, ciò sta a significare che l’incremento degli utili netti, e quindi dei profitti, è derivato da una forte compressione del costo del lavoro, diminuzione dovuta anche ai continui incrementi di produttività [3]. Infatti per il 1998 nell’industria si è avuta una diminuzione del costo del lavoro dello 0,2% e dell’1,7% nel terziario, a ciò si aggiunga che si è verificata una diminuzione dell’1,4% medio nel costo del denaro e l’abolizione dei contributi delle imprese al Servizio Sanitario Nazionale, oltre a una diminuzione complessiva delle imposte sul reddito. Si segnala, dunque, una riduzione dell’aliquota fiscale media di circa tre punti percentuali per il settore dell’industria (che passa dal 53 % al 50%) e di circa l’11% nel terziario (un’aliquota media che passa dal 54% al 43%) e ciò grazie all’introduzione dell’IRAP e della riforma tributaria che ha favorito fortemente le grandi imprese. Tale quadro sta anche a dimostrare una continua tendenza verso i processi di finanziarizzazione dell’economia, in quanto se è vero che i profitti si sono realizzati anche a causa dei minori oneri finanziari e della minore incidenza tributaria è anche vero che l’elevato importo dei profitti è stato solo in parte correlato a incrementi di valore aggiunto. Pertanto è desumibile che una parte degli utili netti è da attribuire ad operazioni di rendita finanziaria e ciò è anche confermato dalla mancanza di seri programmi di investimenti, nonostante la riduzione del costo del denaro. Ne segue che il vantaggio derivato dal calo dei tassi di interesse non ha comportato consistenti programmi di investimento, infatti gli investimenti tecnici e finanziari delle imprese private italiane continuano ad andare più all’estero che al mercato interno, ciò a conferma del processo intenso di internazionalizzazione che da qualche anno sta interessando le imprese italiane. Tant’è che nel 1998 gli investimenti tecnici delle società del campione sono aumentati globalmente del 5,4%, rimanendo ancora più bassi del 18% di quelli di inizio decennio. Va anche segnalato che per ogni 100 lire di investimenti realizzati nel 1998 ci sono state quasi 39 lire di disinvestimenti; ciò a dimostrare il continuo processo di esternalizzazione produttiva e di delocalizzazione internazionale che fanno sì che le imprese italiane si concentrino soltanto sulla parte del ciclo produttivo ad alti margini e sulle lavorazioni ad alto valore aggiunto, dismettendo le funzioni aziendali e le fasi del ciclo non strategiche a scarso contenuto di know how e quindi realizzabili in quei paesi dove più basso è il costo del lavoro e scarsi sono i diritti del lavoro. Si consideri, inoltre, che le imprese hanno continuato a generare molto denaro che è affluito spesso a speculazioni finanziarie e in incrementi di dividendi distribuiti. Ciò è spiegabile attraverso un semplice ragionamento per punti:
a) si realizza un aumento record degli utili netti; b) a ciò non corrispondono significativi incrementi né di fatturato né di valore aggiunto; c) sostanziale tenuta dei Margini Operativi Lordi e dei Margini Operativi Netti; d) il valore aggiunto deve essere redistribuito al fattore lavoro e al fattore capitale, ma al fattore lavoro non sono andati incrementi nè di salario diretto nè di salario indiretto; e) le imposte fiscali e tributarie diminuiscono; f) gli oneri finanziari sull’indebitamento calano come conseguenza del minor costo del denaro; g) i maggiori flussi di denaro realizzati dalle imprese non vanno ad investimenti, anzi si realizza anche un 39% di dismissioni di attività; h) per il terzo anno consecutivo i dividendi distribuiti (nel 1998 circa 8.500 milioni di euro) sono stati maggiori degli aumenti di capitale a pagamento (nel 1998 meno di 7.500 milioni di euro), realizzando un saldo negativo fra dividendi e aumenti di capitale di oltre 1000 milioni di euro, penalizzando di fatto l’autofinanziamento in quanto i detentori di azioni in pratica continuano a ricevere più di quanto danno; i) deciso miglioramento della struttura patrimoniale delle società e il rapporto tra debiti finanziari e patrimonio netto diminuisce toccando il valore più basso degli utlimi dieci anni, anche per la diminuita quota di debiti contratti con le banche a vantaggio di finanziamenti a breve realizzati con le consociate dovuti all’accentramento a livello di gruppo della gestione finanziaria. Con il quadro rappresentato nei punti precedenti si evince chiaramente che i vantaggi di cui hanno potuto usufruire le imprese italiane sono rimasti esclusivamente nelle tasche degli imprenditori, dei manager, degli azionisti i quali non hanno “socializzato” in alcun modo le condizioni ottimali di crescita di questi ultimi anni e in particolare del 1998, anno in cui si sono registrati i migliori risultati dell’ultimo decennio.
Il Profit State continua a omaggiare di condizioni favorevolissime gli imprenditori e a operare sconti eccezionali al profitto e ciò non si traduce neppure in miglioramenti di spesa sociale ( diminuisce il peso contributivo delle imprese), né in incrementi di investimenti sul mercato italiano, né in riduzione di orario di lavoro, né in incrementi di salario e in operazioni redistributive a favore del lavoro, né, come si vedrà meglio di seguito nel dettaglio, aumenta l’occupazione. Infatti, sempre in riferimento al campione di Mediobanca, si ha che negli ultimi tre anni sono stati espulsi dal processo produttivo 58.518, lavoratori di cui 19.867 nel 1998, 16.573 nel 1997 e circa 22.000 nel 1996; evidenziando così un intenso processo di deindustrializzazione nel nostro Paese, poiché dei 58.518 posti di lavoro persi ben 54.928 sono in imprese industriali mentre i restanti 3.590 sono lavoratori espulsi dai processi produttivi delle imprese terziarie. Solo nel 1998, sempre in riferimento al campione di Mediobanca di 1755 imprese si rileva che mentre le imprese terziarie registrano un aumento di 1.400 unità di lavoro essenzialmente nel comparto delle telecomuncazioni per lo sviluppo della telefonia mobile (anche se si tratta spesso di contratti part time) e di formazione, le imprese industriali invece evidenziano una perdita di 21.667 posti di lavoro. Si consideri inoltre che il lieve incremento registrato nelle retribuzioni dirette è stato ampiamente bilanciato, sempre nel 1998, dall’abolizione degli oneri a carico delle imprese per i contributi al Servizio Sanitario Nazionale e all’incidenza dell’imposizione fiscale che, come si è detto precedentemente, è fortemente variata in senso favorevole alle imprese, soprattutto per quelle di grande dimensione (si parla infatti che con l’introduzione dell’IRAP e della DIT, la Dual Income Tax, le grandi imprese e le banche abbiano risparmiato oltre 10.000 miliardi); va infine considerata anche la diminuzione degli oneri finanziari grazie al calo dei tassi di interesse. In pratica il capitalismo italiano continua ad intascare profitti senza creare opportunità di occupazione, ristrutturando per seguire esclusivamente un’ottica di competitività internazionale basata su processi di delocalizzazione produttiva all’estero, decrementi occupazionali all’interno del Paese, supersfruttamento del lavoro con incrementi degli straordinari e dei ritmi, uso di lavoro nero e precario e con scarsi diritti riconosciuti ai lavoratori, in particolare le nuove figure del lavoro atipico, con flessibilità del salario e del lavoro, con tagli continui alla spesa sociale, quindi con salari reali sempre a minore capacità di acquisto. Il tutto finalizzato a determinare utili che, nonostante le condizioni favorevoli di cui si è detto, non vengono utilizzati in investimenti produttivi nel Paese ma inseguono la speculazione finanziaria e l’investimento produttivo estero percorrendo traiettorie verso i paesi dove si può avere un lavoro specializzato a basso costo e a basso contenuto normativo.
1.3. L’internazionalizzazione italiana
Le Tabb.11,12,13 aiutano a comprendere più chiaramente che anche in questi ultimi anni, come già si era visto nella Seconda Parte dell’analisi-inchiesta (vedi Proteo 1/99), le imprese italiane non risultano essere molto competitive, non riescono a rimanere stabilmente sul mercato e i beni e servizi vengono venduti a prezzi troppo elevati rispetto alla concorrenza.
[1] Annuario 1997, ISTAT [2] Nei grafici è evidenziato il Risultato rettificato a nuovo; si ricorda che con questo termine si intende il risultato d’esercizio depurato di rivalutazioni, svalutazioni, stanziamenti e prelievi, riportato a nuovo dopo le attribuzioni deliberate dalle assemblee dei soci (Mediobanca). [3] Si ricorda infatti che il valore aggiunto rappresenta il quantum che va a remunerare il fattore produttivo lavoro e il fattore produttivo capitale e che il margine operativo lordo è ottenuto dalla sottrazione dal valore aggiunto del costo del lavoro. Pertanto la sostanziale stabilità del Margine Operativo Lordo denota che non ci sono state tendenze redistributive a favore del fattore lavoro
|