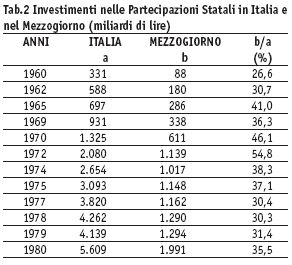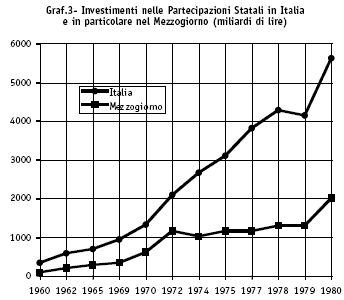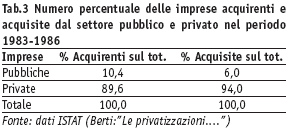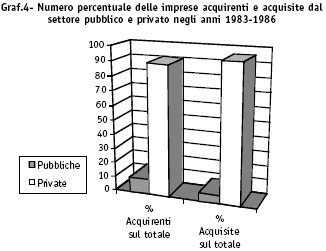![]()
Rubrica
L’analisi-inchiesta
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Luciano Vasapollo Docente di Economia Aziendale, Fac. di Scienze Statistiche, Università’ “La Sapienza”, Roma; Direttore Responsabile Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali (CESTES) - Proteo.
I diversi modelli del capitalismo internazionale si confrontano sulle strategie di privatizzazione Le diverse forme di privatizzazione Privatizzazioni e mercati finanziari La via alle privatizzazioni nel modello capitalistico italiano. Un’indagine statistico-aziendale
Tutti gli articoli della rubrica: analisi-inchiesta(in tutti i numeri di Proteo)
|
Negli anni ‘70 l’importanza di questi enti di gestione è cresciuta ancora, soprattutto in relazione alla necessità di arginare la crisi che ha colpito la maggior parte delle imprese private e alla volontà di concentrare gli sforzi pubblici a favore delle aree depresse del Mezzogiorno. Basta riflettere a questo proposito sull’alta incidenza degli investimenti nelle Partecipazioni Statali in Italia e la percentuale nel Sud; in particolare si osservi l’alta percentuale rispetto al totale degli investimenti realizzati tra il 1970 e il 1972 da questi enti. (Cfr. Tab.2 e Graf.3)
Va ricordato che in tale situazione, fino a inizio anni ‘80, l’unico azionista di questi enti di gestione è lo Stato; il capitale sociale, chiamato fondo di gestione, finanzia le società delle partecipazioni statali attraverso l’acquisto delle azioni o attraverso la concessione di prestiti. La massiccia quantità di investimenti che questi enti hanno realizzato nel corso degli anni ha portato spesso a una carenza del fondo che, pur essendo stata risolta attraverso l’emissione di obbligazioni o l’ottenimento di prestiti da parte delle banche, ha portato a lungo andare a una situazione di sottocapitalizzazione ed alla crescita del rapporto tra indebitamento e fatturato. Si è avuta in tal modo una sempre maggiore dipendenza dal flusso di trasferimenti monetari da parte del Ministero del Tesoro e quindi un indebolimento dell’autonomia gestionale degli enti di gestione. La crisi finanziaria del sistema, le discipline dei prezzi imposti che vincolavano la redditività delle imprese a partecipazione statale e la sempre maggiore dipendenza verso il potere politico che ha creato il perverso intreccio tra economia, affari e partitocrazia, e la decisa spinta verso un modello liberista puro, da “capitalismo selvaggio”, ha portato a prendere in seria considerazione l’idea di attuare un vasto programma di privatizzazioni. Il programma di privatizzazioni prende definitiva forma nel nostro Paese negli anni ‘80 e si realizza seguendo tipologie diverse, soprattutto per tentare di rispondere a logiche macro di politica-economica a connotati di liberismo puro, e a logiche micro legate a modalità produttive e finalità gestionali adatte al tipo di azienda considerata. In Italia, a differenza degli altri paesi europei, non è stata promulgata inizialmente alcuna legge, né si è svolto alcun tipo di dibattito politico o sindacale sul processo di privatizzazione. L’unica forma di controllo che si è stabilita è stata quella che prevedeva di informare il Ministero delle Partecipazioni Statali della possibile vendita e il CIPI (Comitato Interministeriale per la Politica Industriale) della possibilità offerta al fine di ottenere l’approvazione per la privatizzazione. Questa situazione ha permesso ai grandi gruppi privati di diventare i maggiori acquirenti delle imprese da cedere ed ha relegato i piccoli risparmiatori al ruolo di spettatori ai margini del processo di privatizzazione. Guardando alla storia dei paesi moderni, soprattutto agli ultimi 150 anni, si può rilevare come processi di nazionalizzazione e di privatizzazione della proprietà si siano succeduti nel tempo un pò in tutto il mondo. Le spinte sottostanti a queste ripetute inversioni di tendenza possono essere ricondotte a: - motivazioni in merito alla scelta dei principi che devono presiedere al funzionamento del contesto economico - politico - sociale di un paese, ed alla loro evoluzione, nonché al ruolo dello Stato nell’economia. Le nazionalizzazioni sono spesso nate dall’esigenza di raggiungere obiettivi socialmente rilevanti. Di converso, le privatizzazioni rispondono, nelle apparenze, a obiettivi di miglioramento della competitività dell’economia e dell’efficienza del sistema; - motivazioni legate a “patologie” del sistema economico - sociale, e a compatibilità del capitale internazionale. In merito alle privatizzazioni, lo spunto é stato - soprattutto negli ultimi dieci anni - la necessità di risanare le finanze pubbliche, anche a seguito delle pressioni derivarti dai processo di unificazione europea, e dei conseguneti parametri di Maastricht di vero “soffocamento di ogni comaptibilità sociale” Le privatizzazioni sono processi complessi che comportano, tra l’altro, la definizione degli obiettivi ultimi dell’operazione, la verifica dei presupposti giuridico-economici e delle compatibilità di politica economica, la selezione dei beni oggetto di privatizzazione, la definizione dell’entità, delle modalità e dei tempi della cessione ai privati. In particolare, la scelta degli obiettivi è un’operazione di carattere essenzialmente politico e, in quanto tale, implica metodi che variano da un paese all’altro, senza però trascurare il mantenimento, per quanto possibile, occupazionale. Ciò premesso, gli obiettivi finali di un programma di privatizzazione, sono riconducibili, in primo luogo, al ridimensionamento dell’intervento dello Stato nel settore economico, in secondo luogo, ad un ipotizzato, ma la realtà fattuale dimostra il contrario, miglioramento della struttura organizzativa, economica e finanziaria delle imprese pubbliche; infine, ma non da ultimo, all’ampliamento del numero degli investitori nel mercato finanziario (obiettivo conosciuto sotto il nome di “azionariato popolare” o “diffuso”), che di fatto significa contributo alla “bolla finanziaria”, alla finanziarizzazione dell’economia. Per contro, la scelta degli strumenti destinati a perseguire questi obiettivi dipende sia dalla considerazione di ciò che sembra possibile ad un dato momento, tenuto conto dell’ambiente sociale e politico, sia delle teorie economiche di chi decide le misure di politica economica. Dal punto di vista tecnico, le fattispecie operative sono riconducibili alle seguenti: - vendita diretta ad un unico acquirente; - management employee buy-out; - trattativa privata (private placing) ovvero vendita ad investitori istituzionali; - vendita ad asta (asta pubblica) od a prezzo fisso (offerta pubblica di vendita - OPV - a prezzo fisso). La scelta dipende da considerazioni che possono concernere sia il particolare tipo di attività che si intende smobilizzare sia il mercato in cui si intende effettuare la vendita. Vi è una profonda specificità delle politiche e dei programmi di privatizzazione, a seconda dei paese e dei periodi. E’ stato molto interessante ad esempio, seguire l’opera della apposita commissione tedesca che ha praticamente, in poco tempo, partecipato, venduto o riconvertito tutto il patrimonio statale della ex Germania dell’est. Per quanto riguarda l’Italia, dopo un lungo dibattito il Governo presieduto da Giuliano Amato ha dato ufficialmente il via ad un processo di privatizzazione di imprese pubbliche mediante l’emanazione del Decreto Legge 11 luglio 1992, n° 333, convertito nella Legge 8 agosto 1992, n° 359, contenente “misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”. Per il raggiungimento di questo obiettivo, il Governo ha redatto un piano di politica economica e sociale nel quale sono stati indicati gli strumenti - alcuni di natura tipicamente congiunturali, Atri volti a modificare la struttura del nostro sistema economico e sociale - ritenuti più idonei. Nella categoria degli strumenti di intervento strutturale, rientrano le proposte di privatizzazione di parte delle imprese attualmente in mano pubblica, previste dalla Legge 23 ottobre 1992, n° 421. Il provvedimento prevede, fra l’altro, la trasformazione in S.p.A. di IRI, ENI, INA ed ENEL e l’attribuzione al Ministero del Tesoro delle azioni della Cassa Depositi e Prestiti nel capitale dell’IMI. Le direttive fissate dal CIPE, con delibera del 30 dicembre 1992, stabiliscono che le dismissioni dovranno essere effettuate mediante offerta pubblica di vendita a prezzo fisso (OPV), offerta pubblica ad asta (o asta pubblica) ovvero trattativa privata. Tra i principi generali, si dispone in primo luogo che la determinazione del valore delle partecipazioni da dismettere dovrà essere effettuata mediante l’assistenza di “primari o intermediari specializzati”, nazionali o internazionali, in secondo luogo, negli statuti delle società da privatizzare dovranno essere introdotti meccanismi di tutela degli azionisti di minoranza. Nel caso di cessione mediante OPV, dovrà essere garantita la massima diffusione dell’azionariato, mentre il ricorso alla trattativa privata potrà essere utilizzato solo in presenza di interessi pubblici di particolare rilevanza. Il ricavato delle operazioni di privatizzazione andrà ad alimentare uno speciale Fondo di Ammortamento che dovrà essere utilizzato per acquistare sul mercato ed estinguere contestualmente titoli rappresentativi del debito pubblico in circolazione (Bot, Cct, ecc.) per un pari importo. Il primo grande smobilizzo di attività nel sistema delle Partecipazioni Statali si è avuto negli anni ‘80 con oltre 70 casi di dismissione dei principali enti di gestione (39 attribuibili all’IRI, 15 all’EFIM e 21 all’ENI). Questo fenomeno si è rivelato però nei fatti molto ridotto, anche se identifica una particolare volontà politica di inversione di tendenza. Infatti se si considera che negli anni 1983-86 le imprese pubbliche acquisite hanno raggiunto il 6% del totale a fronte di un 10,4% di casi in cui appaiono come acquirenti, allora questi dati dimostrano che in effetti in tale periodo il settore pubblico non ha diminuito la propria presenza nel sistema produttivo ma al contrario l’ha ampliata (vedi Tab.3 e Graf.4).
Tra gli altri, va ricordato che nel 1986 c’è stato il passaggio della società Alfa Romeo (IRI) alla FIAT, del gruppo Lanerossi (ENI) alla Marzotto; ci sono anche stati tentativi di privatizzazione che non hanno avuto successo: si pensi al caso dell’ENIMONT (società costituita con l’accordo tra l’ENI e il gruppo privato Montedison) conclusasi con lo scioglimento e il ritorno di tutte le sue attività all’ENI. Le operazioni di cessione hanno riguardato solo quote di minoranza e spesso hanno interessato imprese, come l’Alfa Romeo o la Lanerossi, che si trovavano in condizioni di evidente difficoltà economica, anche se bisognerebbe indagare in maniera approfondita sulle reali cause politico-economiche di tali dissesti gestionali. In questi casi si è potuto addurre a motivazione il fatto che le operazioni di vendita siano state dettate più da un intento di risanamento finanziario ed economico che da una reale intenzione di natura squisitamente politico-monetarista che impone il passaggio del controllo dal settore pubblico al settore privato. Per quanto riguarda poi le imprese di pubblica utilità, non si è verificato in questi anni un processo di privatizzazione inteso come vero e proprio trasferimento della proprietà pubblica al settore privato.
|