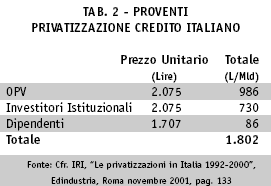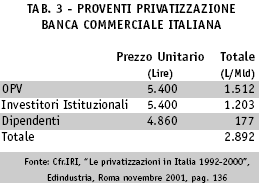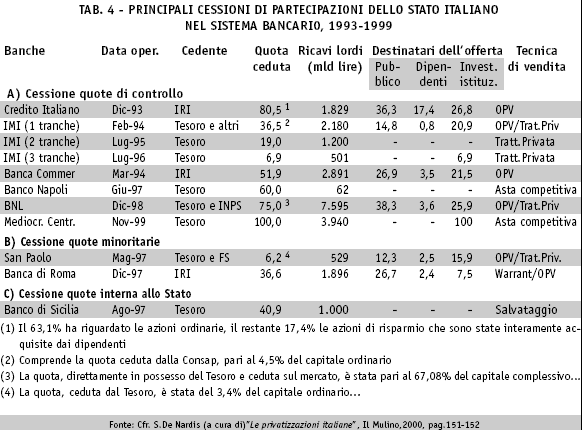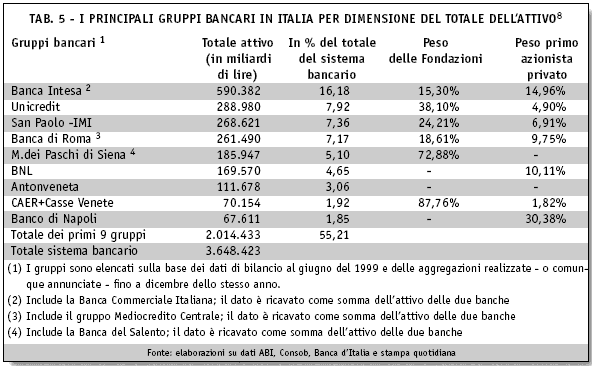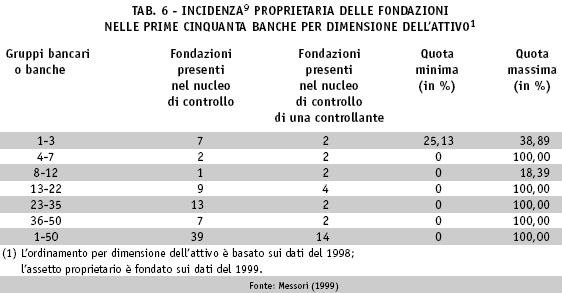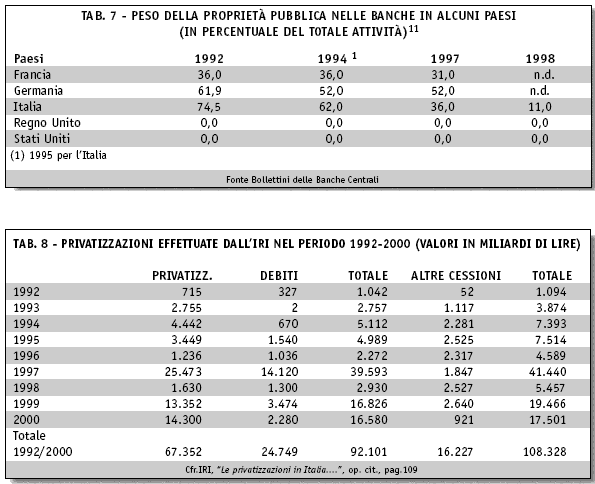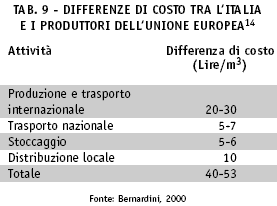![]()
Rubrica
L’analisi-inchiesta
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Luciano Vasapollo Docente di Economia Aziendale, Fac. di Scienze Statistiche, Università’ “La Sapienza”, Roma; Direttore Responsabile Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali (CESTES) - Proteo. Rita Martufi Consulente ricercatrice socio-economica; membro del Comitato Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico Sociali (CESTES) - PROTEO
Legge finanziaria e privatizzazione dei servizi pubblici locali Club privé. A cosa sono servite le privatizzazioni delle banche italiane Sulla questione sociale delle privatizzazioni La privatizzazione finanziaria Il privato... è politico! Le privatizzazioni contro il movimento dei lavoratori
|
4. Alcuni dati settoriali... per piangere dello smantellamento dell’impresa pubblicaVa ricordato che le privatizzazioni sono state gestite sia direttamente dal Ministero del Tesoro sia da enti pubblici quali l’IRI, l’ENI, l’EFIM, ecc. In particolare le più importanti operazioni di dismissione sono state attuate su quattro livelli:
In particolare l’IRI si interessava di aziende di servizi, bancarie e assicurative, l’ENI di aziende minerarie, petrolchimiche e ingegneristiche, mentre l’EFIM di aziende operanti nei settori dei trasporti e della difesa.
4.1 Il settore bancarioL’IRI ha avuto per più di sessanta anni un patrimonio bancario formato da tre banche denominate di interesse nazionale: Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano e Banca di Roma; nel biennio 1993-94 è stato avviato il processo di privatizzazione di due di queste banche (il Credito Italiano e la Banca Commerciale). A fine 1993 l’IRI aveva più dell’80% del pacchetto azionario del Credito Italiano e nel dicembre 1993 ha dismesso il 64% del capitale azionario trasformando il Credito Italiano in una public companies. Con la vendita delle azioni del Credito Italiano l’IRI ha avuto entrate pari ad oltre 1.800 miliardi di lire (Cfr. Tab. 2).
Come si è scritto l’IRI possedeva una quota rilevante anche della Banca Commerciale Italiana; nel febbraio 1994 è stata dismessa l’intera quota (circa il 57,4%) e sono state realizzate entrate pari a 2.900 miliardi di lire (cfr. Tab. 3).
È interessante analizzare le principali cessioni di partecipazioni dello Stato nel sistema bancario negli anni che vanno dal 1993 al 1999 (Tab. 4).
Nel decennio tra il 1990 e il 2000 ci sono state oltre 500 fusioni tra banche; oggi i cinque gruppi principali di banche controllano quasi la metà del l’intermediazione di credito totale, (nel 1996 la percentuale era del 35%); in questo decennio sono state create 165 banche nuove mentre il numero delle banche estere presenti nel nostro Paese è salito da 40 a 65. In definitiva nonostante le considerevoli dismissioni statali effettuate dal 1993 al 1999 il nostro sistema bancario è detenuto ancora in larga maggioranza dalle fondazioni. Alla fine del 1999, infatti, la maggioranza relativa delle azioni di ognuno dei cinque gruppi bancari italiani e il capitale dei primi nove gruppi era in mano alle fondazioni; a marzo 1999 oltre il 44% dei primi cinquanta gruppi bancari aveva come socio di maggioranza (per lo meno relativa) una o più fondazioni. Anche se nel 1998 vi sono stati una serie di incentivi fiscali atti a cedere le proprie partecipazioni azionarie, ciò non è avvenuto. Si ricorda che le fondazioni create nel 1990 con lo status di enti pubblici sono state autorizzate a divenire titolari di un cospicuo numero di azioni di partecipazione bancaria. Le tabelle seguenti (Tab. 5 [1] e 6 [2]) confermano quanto scritto in precedenza.
Va evidenziato poi che “le fondazioni hanno mantenuto una posizione cruciale nell’azionariato del sistema bancario italiano... tre fra le quattro più grandi fondazioni (ossia Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo ed Ente Cassa di Risparmio di Roma) detengono ancora oggi (da sole o con altre fondazioni) la posizione di azionisti di maggioranza relativa nel nuovo gruppo bancario scaturito dai processi di concentrazione. Inoltre, l’altra grande fondazione (ossia Monte dei Paschi) mantiene un’ampia maggioranza assoluta nel relativo gruppo bancario; e una posizione analoga è detenuta dalle fondazioni che controllano l’ottavo gruppo bancario per dimensione dell’attivo (l’aggregazione fra CAER e Casse venete, denominata Banca Cardine). Insieme a tre fondazioni minori, le due grandi fondazioni Cassa di risparmio di Verona e CRT sono poi largamente al di sopra della soglia OPA (il 30% del capitale) nel gruppo bancario controllato...” [3]. Questo dimostra che si è trattato soprattutto di un passaggio dallo Stato alle fondazioni. Va considerato, inoltre, che le fondazioni non essendo istituzioni di mercato non sono sottoposte alla disciplina di mercato; inoltre le fondazioni non sono da considerarsi investitori istituzionali in quanto non devono rispondere ad alcun finanziatore o risparmiatore. Comunque, che fino al 1995 l’Italia rispetto agli altri paesi europei si caratterizzava per un’alta percentuale della proprietà pubblica sulle banche; dal 1997 in poi, invece, si è avuto un adeguamento agli altri paesi europei. (Cfr. Tab. 7) [4].
È importante ricordare che, anche andando oltre il settore bancario, l’IRI negli anni che vanno dal 1992 al 1997 ha effettuato un programma di privatizzazioni di notevoli dimensioni realizzando entrate per oltre 25 mila miliardi di lire. I settori interessati sono stati oltre a quello bancario, anche il settore alimentare (SME), il settore siderurgico (Ilva Laminati Piani e Acciai Speciali Terni), il settore delle telecomunicazioni (STET, TELECOM Italia, SEAT), il settore delle Autostrade, il settore Aerospazio e Difesa (Finmeccanica) il settore degli Aeroporti (Aeroporti di Roma), oltre ad altre privatizzazioni come Fincantieri, Tirrenia, il caso Alitalia e le privatizzazioni finanziarie del gruppo IRI. Il valore complessivo delle cessioni effettuate negli anni dal 1992 al 2000 è stato di oltre 43, 54 miliardi di euro (ossia 84.314 miliardi di lire). La Tab. 8 seguente presenta la situazione dell’IRI a dicembre 2000. 4.2. Il settore delle telecomunicazioniRientrando nello specifico dell’analisi settoriale si può osservare un settore strategico sottoposto a privatizzazione che è stato quello delle telecomunicazioni. Si ricorda che questo settore in Italia è stato caratterizzato, fino al 1992, dalla presenza di una pluralità di gestori. La gestione delle infrastrutture e i vari servizi di telecomunicazione erano gestiti, infatti, direttamente dallo Stato in regime di monopolio o da altri soggetti economici ai quali era stata data una concessione. In specifico mentre lo Stato gestiva il servizio telefonico nazionale e internazionale con l’Europa e il bacino del Mediterraneo, i servizi svolti in regime di concessione erano affidati a vari enti tra i quali la SIP, l’Italcable, Telespazio e la SIRM. Nel 1992 la fusione per incorporazione nella SIP della Iritel, Telespazio, SIRM e Italcable ha fatto nascere la società Telecom Italia; in seguito si sono separate le attività radiomobili (luglio 1995) e le attività satellitari (gennaio 1995) attraverso la costituzione di due società la Telecom Italia Mobile e la Nuova Telespazio. La Telecom Italia ha come attività principali oltre quelle nel settore delle telecomunicazioni anche quelle nel settore dei servizi, della progettazione, installazione, progettazione e manutenzione degli impianti e delle reti di telecomunicazioni, nei settori dell’informatica, dei servizi e applicazioni multimediali e nei servizi innovativi di rete. Il processo di privatizzazione della Telecom ha avuto la sua massima espressione nell’ottobre 1997 quando il Tesoro ha ceduto il 39, 5% della sua quota di capitale sociale incassando 22.880 mld di lire. Va rilevato però che, a fronte dell’andamento molto favorevole in termini di redditività ciò ha comportato in questi ultimi anni, connessione frequente, anzi necessaria ormai nell’economia del neoliberismo, una flessione nel numero dei dipendenti dovuta al cosiddetto processo di “razionalizzazione delle strutture” oltre a precarizzazione e ad esternalizzazioni. Dal 1 gennaio 2001 è decaduto il monopolio detenuto dalla Telecom sulle comunicazioni urbane (il settore della telefonia mobile è stato sempre libero in quanto non è mai stato considerato un servizio di pubblica utilità). Infatti il processo di liberalizzazione già avviato, insieme ai livelli di domanda sempre più in crescita, hanno stimolato numerosi nuovi operatori ad affacciarsi ad questo mercato. “Il gruppo Telecom Italia era l’unico operatore nel comparto della telefonia fissa e di gran lunga il principale nella telefonia mobile. Dopo la privatizzazione esso ha sensibilmente diminuito le sue quote di mercato soprattutto a seguito dell’ingresso di nuovi operatori italiani ed esteri. Nella telefonia mobile la quota di mercato della TIM è passata dal 79% nel 1997 al 60% circa nel 1999, ma in presenza di un numero doppio di abbonati. I concorrenti sono Omnitel Pronto Italia (Gruppo Vodafone) e Wind (Gruppo ENEL) che detenevano a fine 1999 quote pari rispettivamente al 35% e al 5% oltre alla Blu (operativa dal 2000). Per quanto riguarda la telefonia fissa la Telecom Italia è stata fino al 1999 l’unico gestore nel comparto urbano (liberalizzato nel 2000) mentre nell’interurbano e nell’internazionale le quote di mercato si sono ridotte rispettivamente all’85% e al 69%...” [5]. Per internet le tariffe del nostro Paese sono tra le più basse nell’area dei paesi OCSE; pur essendo l’Italia al di sotto della media OCSE per ciò che riguarda gli abbonati ad internet si è avuto negli ultimi anni un considerevole aumento (tra il 1998 e il 1999 si è realizzato un incremento di oltre il 60% degli abbonati). L’intero settore delle telecomunicazioni, con particolare riferimento alla telefonia mobile, è stato caratterizzato negli ultimi tempi dalla creazione di poli di aggregazione tra i diversi operatori - anche attraverso la costituzione di idonei consorzi - per la partecipazione alla gara che si è svolta recentemente per il rilascio delle licenze per la telefonia mobile di ultima generazione (UMTS). “Il metodo utilizzato in Italia per assegnare le licenze UMTS è una combinazione unica fra i paesi OCSE di elementi di beauty contest e di asta. Gli operatori interessati sono stati prima sottoposti ad una fase di pre-selezione... Questa fase di pre-selezione non ha dato luogo ad alcun punteggio ma semplicemente ad una attestazione di ammissione alla fase successiva di asta (o ad un attestazione di esclusione). Il 14 gennaio del 2000, era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale una decisione dell’AGCOM in merito al rilascio di licenze nazionali individuali per il sistema di comunicazioni mobile di terza generazione (UMTS)... La fase di selezione della procedura è stata stabilita come un’asta con successiva decisione dell’AGCOM. Alla prima fase della procedura si sono iscritti otto candidati: i quattro operatori esistenti di telefonia mobile e quattro nuovi entranti. Per la fase successiva di asta si sono qualificati solo sei candidati su otto. L’asta è iniziata il 19 ottobre del 2000 con i sei candidati e si è conclusa dopo 11 tornate il 23 ottobre. Per le cinque licenze il Governo ha incassato 12 miliardi di euro... Il costo finale di ciascuna licenza in Italia è stato ben superiore a quello dei Paesi Bassi e della Spagna ma inferiore a quello della Germania e del Regno Unito” [6]/cap06.htm.
4.3. Il settore energeticoIl settore dell’energia elettrica è stato anch’esso soggetto alle operazioni di privatizzazione. Si ricorda che la distribuzione, l’importazione, l’esportazione e la produzione di elettricità erano stati nazionalizzati nel 1962 con la creazione di un organismo pubblico, l’ENEL, che ha detenuto il monopolio fino al 1991 anno in cui l’ENEL è diventata società per azioni. L’obiettivo principale è stato per lungo tempo quello della copertura totale del territorio e il risparmio energetico; dall’anno 1995 invece, è stato posto come principale scopo del settore il raggiungimento della massima efficienza oltre che la ricerca di un equilibrio tra nord e sud, sia per quanto riguarda il servizio sia per le infrastrutture. Con il decreto legislativo n. 79/ 99 è stato liberalizzato l’intero settore ed è stato introdotto lo scorporo funzionale del settore, una limitazione al 50% della produzione e importazione da parte di un’unica azienda a partire da gennaio 2003, ecc. Per quanto attiene alle tariffe si ricorda che il principio secondo cui dal 1961 esse erano uniformate in tutto il territorio è ora valido solo per gli utenti vincolati. Le concessioni e autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero dell’Industria. Si ricorda che l’ENEL è stata parzialmente privatizzata pur mantenendo lo Stato il possesso della Golden Share. Considerando che il costo medio dell’elettricità per le famiglie e per le imprese è più elevato rispetto al costo medio dell’UE e dei paesi OCSE, l’ENEL ha accresciuto la propria efficienza diminuendo il numero degli addetti e, come al solito, facendo aumentare ai lavoratori la propria produttività con intensificazione dei ritmi e con meno attenzione al controllo dei rischi sulla salute e sull’ambiente! Anche la politica dei prezzi e delle tariffe è stata orientata a non proteggere i ceti meno abbienti; infatti è prevista una graduale riduzione delle”tariffe sociali” che saranno applicate in senso generico solo a chi “ne ha realmente bisogno”!! Fino a giugno 2000 l’ENEL controllava il 93% della distribuzione dell’energia e il 73% della possibilità di generazione e questo conferma che ancora conserva una posizione di rilevo nell’intero settore; la continuità del servizio però rimane diverso (con forte divario) tra nord e sud del Paese. Per quanto riguarda l’occupazione nel settore va rilevato che nel 1999 si è avuta una diminuzione di occupati pari al 5, 7%; in particolare gli occupati nell’ENEL sono diminuiti del 7, 5%. Nel settore del Gas naturale nel 1995 con la legge 481 è stata istituita l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. L’ENI ha avuto il monopolio del settore fino al 1996, anno in cui, con il decreto legislativo 625/96 è stato eliminato; nel 2000 con il decreto legislativo 164 si è avuta la liberalizzazione del settore del gas. Questo decreto ha liberalizzato più del 60% della domanda a partire dal 1 gennaio 2001 e dal 2003 anche i privati e le piccole aziende potranno scegliere il proprio fornitore. Infatti dal 2003 non sarà possibile per una singola impresa superare il 50% delle vendite ai consumatori finali né superare il 75% della produzione e delle importazioni totali (è prevista una ulteriore diminuzione del 2% annuo fino ad arrivare al 61% nel 2010). Per quanto riguarda le tariffe per la distribuzione ai privati (non industrie) queste vengono fissate su una base di un generico concetto di “orientamento ai costi” mentre le tariffe per i settori industriali si stabiliscono in base ad accordi tra operatori e fornitori.
Come avviene per il settore dell’elettricità anche per il gas le tariffe applicate nel nostro Paese sono molto più alte se confrontate con quelle degli altri paesi europei; molto più alti sono anche i costi come si può vedere dalla tab. 9 [7] seguente.
Il settore del gas è capeggiato dall’ENI (attraverso la SNAM);
si ricorda che più del 70% del gas naturale del nostro Paese è importato; per
la quasi totalità le esportazioni vengono fatte dall’ENI, che, oltre a possedere
il 99% delle infrastrutture per lo stoccaggio controlla anche la SNAM che è
un’azienda di trasmissione (e possiede il 96% della rete). Per la distribuzione
del gas sono presenti molte aziende locali che controllano più del 60 % del
mercato; tra di esse vi è l’Italgas. Il prezzo del gas per le famiglie risulta
essere più elevato se confrontato con gli standard nazionali. 4.4 Il settore assicurativo Il settore delle Assicurazioni era regolato fino alla
metà degli anni ’80 dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Pianificazione
Economica), dall’ISVAP e dal Ministero dell’Industria. Nel 1994 sono state liberalizzate
le tariffe di assicurazione sulla vita e sulle autovetture e i poteri sono stati
trasferiti quasi del tutto all’ISVAP (Autorità Autonoma per le Assicurazioni).
Questo ente concede l’autorizzazione alle aziende che vogliono aprire consociate
in altri paesi europei; non è prevista alcuna restrizione all’uscita o all’entrata. Si evidenzia che a fronte di una non brillante efficienza del
settore i premi sono aumentati, mentre l’occupazione è diminuita dal 1994 al
1998 da 48.523 a 42.609 unità, forte è il livello di precarizzazione del lavoro
nel settore e il ricorso a forme di esternalizzazione. [1] U. Inzerillo, M. Messori, “Le privatizzazioni bancarie in Italia”, Centro Studi Confindustria, Novembre 2000, pag. 59. [2] U. Inzerillo, M. Messori, “Le privatizzazioni bancarie...”. op. cit. pag. 60. [3] U. Inzerillo, M. Messori, “Le privatizzazioni bancarie...”. op. cit. pag. 35, 36. [4] Cfr. S. De Nardis (a cura di) “Le privatizzazioni italiane”, Il Mulino, 2000, pag. 129. [5] R&S, “Le privatizzazioni in Italia dal 1992”, op. cit, pag. 99-100. [6] Cfr. www.agcom.it/oecd [7] Cfr. www.agcom.it/oecd/cap05.htm <http://www.agcom.it/oecd/cap05.htm>
|