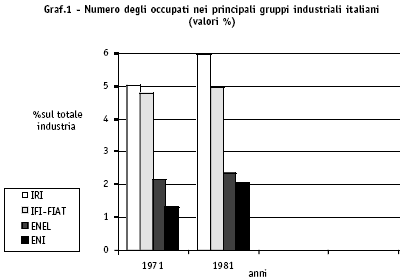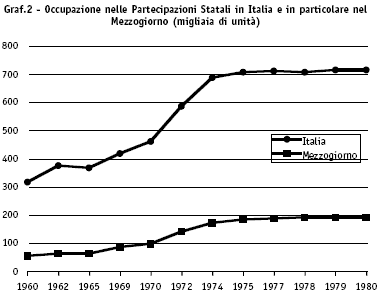![]()
Rubrica
L’analisi-inchiesta
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Luciano Vasapollo Docente di Economia Aziendale, Fac. di Scienze Statistiche, Università’ “La Sapienza”, Roma; Direttore Responsabile Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali (CESTES) - Proteo.
I diversi modelli del capitalismo internazionale si confrontano sulle strategie di privatizzazione Le diverse forme di privatizzazione Privatizzazioni e mercati finanziari La via alle privatizzazioni nel modello capitalistico italiano. Un’indagine statistico-aziendale
Tutti gli articoli della rubrica: analisi-inchiesta(in tutti i numeri di Proteo)
|
1. Gli anni ‘80 e il forte impulso ai processi di privatizzazione
Generalità
Dagli inizi degli anni ’80, si è verificato in tutti i paesi a modello capitalista, anche dove più marcata era la scelta per l’economia mista, un processo di assestamento della presenza pubblica in economia; questo è avvenuto, almeno nelle intenzioni dichiarate, soprattutto per tentare di adeguare la gestione produttiva pubblica alle nuove condizioni della concorrenza internazionale. Le motivazioni principalmente addotte, erano quelle, in sostanza, più legate a ragioni politico-formali che a reali esigenze di efficienza economico-produttiva; pertanto la motivazione di rendere maggiormente competitive le imprese pubbliche si è poi necessariamente legata alle purtroppo reali lungaggini e controlli burocratici che spesso non sono riuscite a consentire alle aziende pubbliche un funzionamento più snello ed innovativo. Il diverso ruolo assunto dallo Stato nelle regole della gestione delle imprese pubbliche ha visto il rafforzarsi dei processi a ritmi intensi di “privatizzazione”; sottolineando con questo termine un maggior ricorso al privato anche per la soddisfazione dei bisogni collettivi prioritari. [1] Si giunge così ad una conseguente riduzione del potere dello “Stato-imprenditore” e allo stesso tempo a forzare il processo di privatizzazione dello stesso Welfare State, imponendo un restringimento delle sue caratteristiche di universalismo delle prestazioni pubbliche fondamentali (incentivando, così, un sempre maggior ricorso alla sanità privata, all’istruzione e formazione a connotati aziendali, al ricorso a forme pensionistiche integrative private, ecc.).
Il modello di capitalismo italiano prima delle privatizzazioni degli anni’80
L’Italia si è caratterizzata, all’interno del contesto europeo, per la diversa e variegata posizione che ha assunto fin dagli anni trenta nei confronti dell’intervento pubblico nell’economia. E’ così che si viene a creare un “via italiana al capitalismo” del tutto peculiare. L’economia italiana si è sviluppata con delle caratteristiche particolari che comportano dei paradossi e delle contraddizioni. Il boom economico degli anni ’50 ha visto la nascita di grandi famiglie capitalistiche che, passate indenni al processo di trasformazione economica-sociale post-conflitto mondiale, hanno inciso profondamente nelle modalità dello stesso sviluppo complessivo. L’industrializzazione che caratterizza questi anni ha comportato un divario tra il nord e il sud del paese, determinato soprattutto dal fatto che mentre per il Settentrione si sono adoperate politiche di integrazione con gli altri stati europei, il Mezzogiorno è invece rimasto sempre più isolato economicamente e socialmente. Ed è stata quindi la famiglia padronale, sia essa fondata su aristocrazie cittadine sia essa caratterizzata da un congiunzione solidale, ad essere la principale protagonista dello sviluppo economico del nostro paese. Si è passati dall’affermazione della piccola e media impresa familiare allo sviluppo della grande impresa familiare che hanno rappresentato la colonna portante del nostro sistema economico. Lo scenario che si presenta nella realtà italiana è, quindi, caratterizzato in primo luogo dalla presenza di grandi holding private (a carattere familiare con il supporto del manager); ci sono poi le imprese pubbliche che hanno sostenuto lo sviluppo ed infine un numero elevato di piccole e medie imprese le quali per la loro innovatività si caratterizzano per un elevato livello di efficienza. [2] Il nostro Paese è comunque a tutt’oggi caratterizzato dalla presenza di piccole e medie imprese, mentre le grandi aziende restano ancora in numero molto ristretto; questa situazione è dovuta in gran parte a problemi di natura politico-economica e storico-culturale. L’Italia, infatti è uno Stato ancora giovane con alle spalle una storia molto frantumata e di conseguenza, a differenza di altri paesi quali la Germania, l’Inghilterra caratterizzate da sempre da burocrazie molto centralizzate, non ha acquisito una “cultura dell’organizzazione” ed ha accentuato solo processi di sviluppo individualistici basati sulla creatività e l’intraprendenza personale di alcuni componenti le grandi famiglie italiane. E’ chiaro quindi che, per entrare a pieno titolo nei processi di globalizzazione che ormai caratterizzano il sistema economico mondiale è necessario adoperarsi affinchè si effettui una giusta conciliazione fra “famiglie e clan manageriale”; è quindi necessario superare il conflitto esistente fra famiglia e management per consentire una cooperazione tra queste due forze che permettano all’Italia di ottenere uno sviluppo unitario e strutturale. Si assiste in sostanza a tutt’oggi ad una forma di imprenditoria di élite tipica delle grandi aziende, all’imprenditoria della piccola e media impresa ed infine all’imprenditoria assistita. Questa situazione fa risaltare lo storico problema delle “tre italie imprenditoriali”, in quanto gli imprenditori d’élite sono concentrati nell’Italia settentrionale, al centro troviamo un tipo di imprenditorialità diffusa, mentre al sud si trova il cosiddetto “imprenditore assistito” legato in maniera più diretta e dipendente al sistema politico. Considerando che l’Italia fino alla seconda guerra mondiale era un paese basato su un’economia prevalentemente agricola, va segnalato che lo sviluppo industriale avutosi tra gli anni ‘50 e gli anni ‘70 si è concentrato solo su alcune zone senza estendersi alle aree più depresse. Accanto alle imprese pubbliche tradizionali (Ferrovie, Monopoli, Poste) sono sorti nella prima metà del secolo una serie di enti di gestione (IRI,EFIM,ENI, ecc.) riuniti nel 1956 sotto il controllo del Ministero delle Partecipazioni Statali e del Ministero dell’Industria; se si aggiungono poi le varie imprese municipalizzate (gas, elettricità, trasporti) e le finanziarie regionali si ha un quadro completo del vastità dei settori economici controllati dallo Stato. Le imprese a partecipazione pubblica sono state raggruppate quindi in holding: ad esempio l’IRI controllava le partecipazioni industriali, bancarie e altri servizi; l’EFIM controllava le partecipazioni nei settori metallurgico e meccanico; l’ENI quelle petrolifere, tessili e petrolchimiche, l’EAGG le imprese del settore cinematografico, l’EAGAT nel settore termale e l’EGAM nel settore minerario. [3] Negli anni ‘70 si attua il cosiddetto “decentramento produttivo” che scorporando alcune fasi del processo produttivo le indirizza verso imprese di minore dimensione; in questo senso la piccola impresa si caratterizza sempre più per una elevata indipendenza dalla grande azienda committente, in quanto si specializza e si caratterizza per la sua innovatività. Si realizza in sostanza una forma di industrializzazione diffusa che ha il vantaggio di associare i benefici della piccola dimensione con quelli della grande. [4] L’intervento dello Stato nell’economia è derivato dalle esigenze contingenti di compensare, integrare, ed in alcuni casi sostituire la gestione privata in settori in difficoltà con lo scopo di tutelare l’interesse collettivo. Va ricordato, infatti, che l’origine del sistema delle partecipazioni statali risale al 1933, anno in cui è stata costituito provvisoriamente l’IRI (divenuto nel 1936 un ente permanente) con l’obiettivo di acquisire parte delle tre banche miste italiane in evidente difficoltà e garantire quindi i depositi e il risparmio dei cittadini. Nella situazione italiana che realizza quel sistema di gestione aziendale, chiamato da alcuni studiosi di tipo “padronale”, sono presenti forti limiti finanziari; il management deve tener conto delle risorse finanziarie già immediatamente disponibili prima di effettuare gli investimenti a meno di ricorrere a forti indebitamenti. Vi sono inoltre limiti economici perché si verifica un alto costo del capitale dovuto alle esigue possibilità degli azionisti di diversificare il proprio portafoglio di investimenti; infine anche la classe manageriale sovente è poco dotata di professionalità in quanto i ricambi del vertice seguono logiche dinastiche, politico-clientelari e non professionali. Gli obiettivi di redditività di breve periodo hanno portato a scarsi investimenti nello sviluppo tecnologico e quindi a una limitata competitività delle imprese italiane nei confronti delle altre aziende europee. L’impresa familiare ha sempre frenato lo sviluppo della cultura manageriale e quindi lo sviluppo competitivo dell’impresa stessa; questo accade perché ereditare un’azienda non presuppone la continuità dello sviluppo della stessa. Un’azienda non può fondarsi su fattori di continuazione genetica ma deve invece avere uno management attivo, dinamico, capace di promuovere strategie efficienti. La famiglia padronale ha sempre condizionato la vita stessa dell’azienda non riuscendo quasi mai a operare in sintonia con i managers. La gestione dell’azienda in Italia, sempre avvenuta nell’interesse di pochi soggetti economici, sta portando sicuramente ad un sua perdita di importanza per le strategie di globalizzazione finanziaria del capitale internazionale. Il capitalismo italiano non è stato in grado di realizzare imprese con caratteristiche nuove, dotate di dinamismo, di autonomia, con facile accesso ai finanziamenti e soprattutto tali che non siano guidate da vertici ristretti ma piuttosto da una varietà di soggetti economici. [5] E’ in tale contesto che per il capitalismo italiano, e per le stesse modalità di uno sviluppo equilibrato dell’economia del Paese, che si è reso fondamentale, addirittura indispensabile, l’intervento dello Stato; ciò per realizzare quel modello di “economia mista” in grado di compensare le inefficienze strutturali tipiche del capitalismo familiare italiano, e di garantire nel contempo una salvaguardia minima di quegli interessi collettivi che un modello di tal genere a caratterizzazione oligopolistica avrebbe senz’altro trascurato e compresso. Sempre con tali finalità, e con lo scopo di salvare le imprese più deboli non in grado di reggere all’impatto oligopolistico delle grandi famiglie, evitando nel contempo la costituzione di monopoli in settori economici strategici del Paese, si capisce il ruolo fondamentale ed irrinunciabile assunto dall’ENI, dall’ENEL e dall’EFIM. Per meglio comprendere l’importanza di questi enti di gestione basti ricordare che nel decennio 1971-1981 l’IRI, l’ENI e l’EFIM erano, in termini di occupazione, ai primi posti nell’elenco dei dieci più importanti gruppi industriali italiani (Cfr. Graf.1) Si noti anche nelle rispettive Tab.1 e Graf.2 l’importante apporto occupazionale offerto dalle Partecipazioni Statali (dati 1960-1980), e le significative percentuali nel Mezzogiorno.
[1] “... La natura privata o pubblica della proprietà si definisce in base al soggetto che ha il diritto di disporre dell’impresa in tutti i modi che non siano esclusi dai contratti e dalle norme vigenti. Le due forme private dell’impresa, privata e pubblica, sono dunque, rispettivamente: quella di un’azienda gestita direttamente da uno o più proprietari privati o da managers su delega dei proprietari privati; quella di un’azienda gestita da funzionari pubblici che rispondono a organi dell’Amministrazione statale..... Alcuni intendono come privatizzazione ogni iniziativa volta a ridurre la presenza pubblica nella proprietà o nella gestione dell’impresa. In questa accezione del termine rientrano allora la cessione a privati di quote di minoranza...la deregolamentazione di aspetti di attività dell’impresa; l’abbandono di attività accessorie prima integrate nella gestione in favore dell’acquisto sul mercato di quei beni o servizi....”; in Padoa-Schioppa T.,”Il processo di privatizzazione:sei esperienze a confronto”, Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, genn.-febbr. 1992, p. 3. [2] Tali considerazioni sul modello di capitalismo italiano, come alcune altre successive, sono tratte da : R. Martufi e L.Vasapollo, “Sviluppo capitalistico e modelli d’impresa”, in “Altra Europa”, anno 3, n.8, Luglio-Settembre 1997. [3] Va ricordato che nel 1977 l’EGAM è stato sciolto come pure l’EAGG e l’EAGAT (sciolti agli inizi degli anni ‘80); l’EFIM è stato liquidato recentemente mentre l’IRI e l’ENI nel 1992 sono state trasformate in società per azioni. [4] Cfr.R.Martufi e L. Vasapollo, “Sviluppo capitalistico...”, op. cit. [5] Cfr.R.Martufi e L. Vasapollo, “Sviluppo capitalistico...”, op. cit.
|