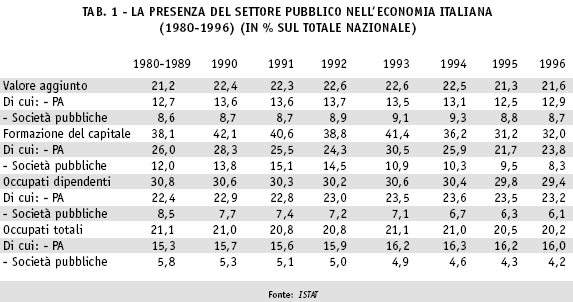![]()
Rubrica
L’analisi-inchiesta
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Luciano Vasapollo Docente di Economia Aziendale, Fac. di Scienze Statistiche, Università’ “La Sapienza”, Roma; Direttore Responsabile Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali (CESTES) - Proteo. Rita Martufi Consulente ricercatrice socio-economica; membro del Comitato Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico Sociali (CESTES) - PROTEO
Legge finanziaria e privatizzazione dei servizi pubblici locali Club privé. A cosa sono servite le privatizzazioni delle banche italiane Sulla questione sociale delle privatizzazioni La privatizzazione finanziaria Il privato... è politico! Le privatizzazioni contro il movimento dei lavoratori
|
La nostra rivista si è interessata al fenomeno delle privatizzazioni già in passato con delle inchieste [1] che analizzavano le circostanze e le motivazioni addotte dai governi per procedere allo “smantellamento della cosa pubblica”. L’indagine sulle privatizzazioni è partita già con i numeri 1/98 e 2/99 di PROTEO e come tutte le indagini che abbiamo fatto, dai dati ufficiali dell’ISTAT, della Banca d’Italia, dell’EUROSTAT, dai dati provenienti dalle fonti interne delle singole aziende e dai dati ABI (Associazione Bancaria Italiana); incrociando questi dati siamo andati a vedere le tanta facce delle privatizzazioni sia a livello macro, quindi un’indagine di carattere statistico-economica legata agli indicatori che devono dimostrare la validità o meno e il relativo peso nei conti economici nazionali dei vari paesi d’Europa, sia a livello micro, portando avanti l’indagine su delle particolari aziende, con un’analisi a caratteristiche più statistico-aziendali. È stato un lavoro molto faticoso e impegnativo che si è protratto per lungo tempo e con questo numero di PROTEO vogliamo riprendere. L’analisi è partita dal fatto che in Europa e nel resto del mondo, è in atto un conflitto molto pesante fra aree di influenza capitalistiche; un conflitto che apparentemente non è armato ma che forse è più pesante di un conflitto di guerra, perché è una guerra economica-finaziaria quella che si è scatenata fra l’area di influenza dello yen, quella di influenza ex marco tedesco, oggi euro, e quella del dollaro. All’interno di questo conflitto si vanno ridefinendo sia i ruoli e i modelli di capitalismo sia i ruoli e i modelli d’impresa. Vediamo in particolare che in Europa si è realizzata soltanto una apparente unità di carattere finanziario ma non c’è assolutamente un’unità politica, né tantomeno una di tipo economico. Questa premessa sui modelli di capitalismo per evidenziare il fatto che anche i modelli di privatizzazione che si sono attuati in Europa non sono assolutamente univoci; c’è in effetti una forte tendenza, un accorpamento, un appiattimento verso il capitalismo selvaggio anglosassone, nonostante le vie di privatizzazione inglese, francese, tedesca e italiana siano state completamente differenti. L’analisi inchiesta che abbiamo svolto si è occupata delle privatizzazioni in Europa e in Italia. In Europa siamo andati a vedere il collegamento tra modelli di capitalismo e modelli di impresa; abbiamo analizzato in particolare in Germania, paese in cui l’economia in un prossimo futuro verrà ancor più privatizzata con processi molto più accelerati di quelli stabiliti durante il precedente governo, nonostante l’attuale governo sia di sinistra, al fine di risolvere e addossare al resto d’Europa i costi dell’unificazione della Germania. Parallelamente al modello tedesco, abbiamo analizzato quello francese, che sembrava a prima lettura meno democratico, in quanto si rifaceva alla logica del ‘nocciolo duro’ e non a quella delle pubblic-companies, poi invece, ci siamo accorti che il modello della Golden Share, del nocciolo duro si è apparentemente rivelato più democratico economicamente del modello delle pubblic-companies, anche se poi ha portato gli investitori istituzionali, le banche e i grossi poteri finanziari a controllare le imprese di grandissime dimensioni con un capitale minimo relativamente a quello che era il capitale d’impresa venduto. Si è analizzato il processo di privatizzazione anche in Austria, Svezia, Norvegia e nei paesi dell’ex blocco socialista, dell’Europa dell’est, dove ci siamo accorti che il processo di privatizzazione ha una finalità legata alla corsa competitiva con le economie occidentali più forti. Infine abbiamo analizzato il processo di privatizzazione in Italia; il modello italiano risente della particolarità del capitalismo nel nostro Paese. Sulla rivista PROTEO, sia sul n. 1 che sul 2 del 1998, si possono trovare tabelle e grafici che spiegano più dettagliatamente la dinamica delle privatizzazioni di cui ho parlato finora. Sono stati analizzati i vari casi studio sulle privatizzazioni avvenute successivamente al Governo Amato, per esempio La Nuova Pignone, le banche (CREDIT e COMIT), l’ENI 1, 2, 3 e 4, l’INI, l’INA, l’ALITALIA, TELECOM, Banca di Roma e l’ENEL; ci si è soffermati sulla privatizzazione e la battaglia sull’ENEL che non è soltanto di carattere economico ma è una battaglia di principi, per ridare un ruolo interventista allo Stato. Si sono inoltre analizzati dei casi locali di privatizzazione, come quello della Centrale del Latte di Roma e dell’ACEA. Ci sembra opportuno ora riprendere il discorso per analizzare quali sono state le conseguenze sul sistema economico del nostro Paese, dovute alla trasformazione di grandi aziende pubbliche in imprese private, anche se con processi e modalità non sempre evidenti. Le privatizzazioni delle imprese pubbliche sono state attuate per raggiungere, secondo i vari governi che si sono succeduti negli anni ’90, diversi obiettivi: in primo luogo per cercare di risanare le finanze pubbliche; poi per favorire una migliore efficienza delle imprese e quindi per facilitare la diffusione dell’azionariato popolare in un tentativo di creazione di processi di allargamento di forme di democrazia economica. Va ricordato che la con l’operazione di privatizzazione si trasferisce in vario modo un’azienda di proprietà pubblica al settore privato; con la privatizzazione formale le imprese pubbliche vengono sottoposte agli istituti del diritto privato e così il controllo dei fattori di produzione passa dal pubblico al privato pur mantenendo lo Stato il controllo del profitto (in quanto mantiene la maggioranza del capitale sociale), mentre con la privatizzazione sostanziale vengono cedute le quote di controllo sul mercato e, quindi, anche il profitto passa in mano ai privati. Le forme principali di privatizzazione sono essenzialmente tre: la prima consiste nel vendere a operatori privati la maggioranza delle azioni di imprese a controllo pubblico; la seconda è data dalle vendite a privati di componenti del portafoglio immobiliare pubblico (Stato, enti territoriali locali, altri enti pubblici); la terza infine consiste nel concedere a privati la gestione di servizi svolti in precedenza da operatori pubblici centralmente o localmente in una situazione come quella italiana che era fortemente caratterizzata dall’economia mista.
2. La via all’economia mista: ... pubbliche virtùL’intervento dello Stato nell’economia è derivato, in un paese come il nostro che si era strutturato su assetti di economia mista, dalle esigenze contingenti di compensare, integrare, ed in alcuni casi sostituire la gestione privata in settori in difficoltà con lo scopo di tutelare l’interesse collettivo. Ma occorre ricordare che l’intervento dello Stato nell’economia è avvenuto per compensare i fallimenti e le insufficienze dei privati; senza l’intervento pubblico infatti il capitalismo italiano non sarebbe stato in grado di sopravvivere e rafforzarsi a livello internazionale. È possibile datare i primi interventi statali a sostegno dell’economia già dal 1929 a seguito della crisi economica che ha coinvolto l’economia mondiale. Più precisamente l’origine del sistema delle partecipazioni statali risale al 1933, anno in cui è stata costituito provvisoriamente l’IRI (divenuto nel 1936 un ente permanente) con l’obiettivo di acquisire parte delle tre banche miste italiane in evidente difficoltà e garantire quindi i depositi e il risparmio dei cittadini. Nel secondo dopoguerra poi il ruolo dello Stato come imprenditore si è consolidato: “È stato così che a partire dagli anni ’50, e fino in pratica all’inizio degli anni ’90, alle holding pubbliche sono stati demandati in modo improprio, implicitamente o esplicitamente, compiti strategici di politica industriale, come garantire la separazione fra proprietà e controllo delle imprese, non assicurata da un efficiente sistema finanziario, guidare l’allocazione delle risorse e fornire gli indirizzi strategici ultimi dello sviluppo economico” [2]. In quegli anni era ritenuta fondamentale la presenza dello Stato in settori strategici come quelli delle fonti di energia, della chimica, dell’industria siderurgica; la nascita delle cosiddette economie miste, ossia con la presenza di imprese pubbliche e private insieme (le prime per garantire uno sviluppo generale e le seconde con regole di profitto), aveva come scopo proprio quello di garantire delle economie di scala condizioni di parità e soprattutto di impedire la nascita di monopoli. Fino all’inizio degli anni ’90 il nostro Paese aveva partecipazioni statali che interessavano una vasta gamma di servizi infrastrutturali (ferrovie, gas, elettricità, comunicazioni, trasporti, ecc.). Il controllo pubblico era esercitato attraverso le holding pubbliche, gli enti pubblici oppure attraverso le aziende autonome o le aziende speciali. Il Ministero delle Partecipazioni Statali controllava direttamente i tre grandi enti di diritto pubblico - l’IRI, l’ENI e l’Efim. Negli anni ’80 e nella prima metà degli anni ’90, sulla base dei dati ISTAT relativi ai conti dei settori istituzionali, il settore pubblico aveva raggiunto un peso superiore al 20% in termini di valore aggiunto prodotto, contribuendo per il 38% alla formazione del capitale fisso e per oltre il 20% dell’occupazione complessiva (cfr. Tab. 1).
Ci troviamo davanti a quel capitalismo definito padronale, familiare, dove quattro o cinque famiglie controllano l’economia del Paese nonostante la piccola media impresa abbia forti capacità di esportazione, ma il controllo reale, quello politico ed economico, è in mano direttamente o indirettamente alle grandi, potenti famiglie. Questo modello padronale è stato temperato dalla via italiana all’economia mista, cioè dal ruolo delle partecipazioni statali. Il ruolo dell’impresa pubblica è stato nel nostro Paese, almeno fino ad un certo periodo, estremamente rilevante per il fatto che ha permesso di bloccare l’impostazione monopolistica, di temperare almeno gli eccessi del capitalismo monopolista e inoltre di permettere alcune fasi di sviluppo nel Mezzogiorno. Con questo non si vuole salvare per intero il ruolo e le dinamiche dell’impresa pubblica, in quanto ognuno di noi ha potuto notare l’intreccio perverso fra l’impresa pubblica e il mondo politico e partitocratico. Tangentopoli è stata soltanto una rappresentazione di un sistema di cui da anni tutti conoscevano l’esistenza. Il “fattore K” è stato un fattore determinante per lo sviluppo dell’economia, cioè il blocco democristiano ha portato avanti l’economia pubblica proprio in funzione del controllo dell’eventuale ascesa dei comunisti all’interno del Paese. Dall’altra parte, spesso, i sindacati confederali e lo stesso Partito Comunista hanno accettato tali ricadute del “fattore K” perché, attraverso la mediazione con la politica all’interno di un modello consociativo hanno ottenuto le briciole del sottogoverno contraccambiando con la compressione delle iniziative di lotta del movimento operaio italiano. Se tali scelte politico-economiche hanno permesso, anche se in maniera altalenante e con seri problemi redistributivi, una significativa crescita senza i forti eccessi monopolistici, in un paese come il nostro caratterizzato da un tipico capitalismo familiare allora è giusto chiedersi: cosa è cambiato oggi e in questi ultimi dieci anni? La globalizzazione, l’internazionalizzazione dei mercati i nuovi meccanismi di comunicazione hanno realmente imposto la totale e sfrenata privatizzazione dei settori pubblici strategici? E con quali risultati? È importante sottolineare infatti che: “Le privatizzazioni presentano, tuttavia, alcuni gravi rischi:
Fino ad oggi il sistema delle partecipazioni statali, pur con i suoi limiti e sprechi, ha consentito al nostro Paese di mantenere una presenza qualificata in settori produttivi di grande importanza per lo sviluppo... ha consentito di presidiare settori strategici per il Paese (difesa, telecomunicazioni, energia)...” [3].
3. Liberalizzare è bello... privatizzare è meglio!La fase di trasformazione rapporto tra Stato ed economia segue principalmente tre obiettivi: liberalizzazione dei capitali, deregolamentazione del mercato e privatizzazione [4]. In sostanza il processo di privatizzazione che ha caratterizzato l’Italia negli anni ’80 ha privilegiato gli interessi di parte, di alcune istituzioni e grandi famiglie del padronato italiano, invece di conseguire finalità pubbliche, o di allargamento della base azionaria in funzione di ventilati progetti di democrazia economica basati sull’azionariato dei lavoratori e l’azionariato popolare. Molti politici e studiosi, anche all’interno della sinistra, quando cominciò il processo di privatizzazione in Italia, quando si parlava di pubblic-company, di democrazia economica, erano sicuri che questo processo avrebbe potuto dare un ruolo principale ai lavoratori attraverso l’azionariato diffuso, per cui si poteva allargare la base azionaria e quindi il potere decisionale. Su questo erano stati, però, molto attenti i sindacati extra confederali perché, vivendo la situazione all’interno delle imprese e mantenendo un approccio conflittuale e non consociativo, si rendevano conto che il cosiddetto azionariato da lavoro poteva portare sicuramente alla distruzione di quella unità di lotta che i lavoratori avevano espresso nel nostro Paese negli anni ’60-’70 [5]. L’intento è stato piuttosto quello di favorire grandi gruppi industriali privati con il risultato di condizionare l’economia del Paese, sottoponendola ancor più al dominio delle famiglie-guida del capitalismo nostrano, con scelte solo inizialmente di deregolamentazione e liberalizzazione, per approdare ad uno dei processi di vera e propria privatizzazione fra i più intensi del mondo. Di fatto molti sono stati gli effetti negativi delle privatizzazioni che stanno portando ad un indebolimento e non ad un rafforzamento del sistema produttivo del nostro Paese, anche in considerazione del fatto che le nostre grandi imprese sono già di numero inferiore a quelle presenti negli altri paesi europei. A ciò vanno aggiunte le ricadute sui lavoratori dei processi di privatizzazione; è infatti chiaro che le garanzie derivanti dall’essere dipendente pubblico, accettando al contempo miseri stipendi vengono a mancare nel momento in cui lo Stato dismette le proprie aziende. Senza parlare dei processi di flessibilità e precarizzazione del lavoro, di esternalizzazione e delle funzioni di subfornitura, allo smantellamento dei diritti sindacali, all’abbassamento degli standards della qualità e di protezione dei rischi per i lavoratori e le conseguenti ricadute sulla qualità del servizio, il mantenimento di salari appena di sopravvivenza; tutto questo è stato “il bello del privato” nel nostro Paese. [1] Vedi PROTEO 1 e 2/98 [2] Cfr. G. Foresti, M. Malgarini, “Privatizzazioni e liberalizzazioni dei mercati: un confronto tra l’esperienza italiana e quella dei principali paesi europei” in Quaderni Agens, Roma, Maggio 2001 pag. 11. [3] Affinito M., De Cecco M., Dringoli A., “Le privatizzazioni nell’industria manifatturiera italiana”, Donzelli editore, Roma, 2000, pag.3. [4] Cfr. IRI, “Le privatizzazioni in Italia 1992-2000”, Edindustria, Roma novembre 2001. [5] Le public companies sono molto presenti nell’economia statunitense sotto forma di SpA quotate in Borsa a proprietà diffusa, quindi ad azionariato diffuso senza uno specifico gruppo di controllo. Spesso il controllo è esercitato dai managers e gli investimenti sono tutelati da una presenza istituzionale che detenendo azioni di privilegio, pilota le strategie di sviluppo. In tal modo si può indirizzare il pubblico risparmio verso forme di azionariato popolare e favorire l’azionariato da lavoro attraverso l’assegnazione gratuita e l’acquisto di azioni da parte dei dipendenti. Si può così promuovere la realizzazione di una certa forma di democrazia economica nel nostro Paese, contribuendo alla realizzazione delle Public Companies che potrebbe essere legata al “processo di privatizzazione” in atto. Vedi PROTEO 1 e 2/98.
|