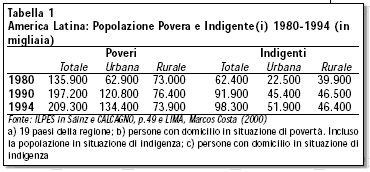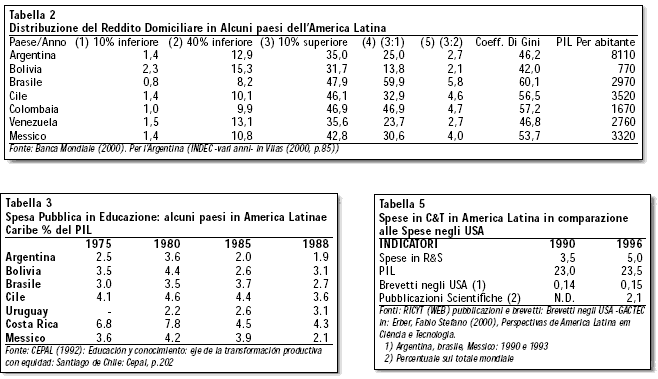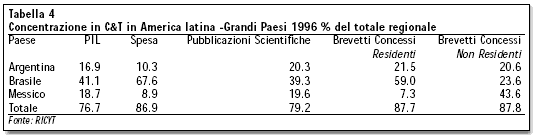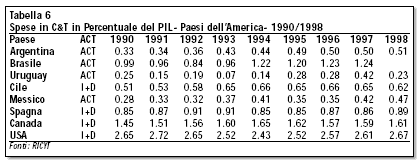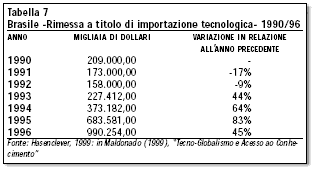![]()
Rubrica
Tendenze della competizione globale
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Marcos Costa Lima Prof.Dr. del Programma di Dottorato in Scienze Politiche dell’Università Federale di Pernambuco-Recife-Brasil. Attualmente compie studi di post-dottorato presso l’Università di Parigi XIII-Villetaneuse
Il dominio dei brevetti e la globalizzazione diseguale Quando gli americani propongono il libero scambio
Tutti gli articoli della rubrica "Tendenze della competizione globale"(in tutti i numeri di Proteo)
|
In uno studio del 1995 Patel rappresenta la forte evidenza dell’affermazione del controllo tecnologico esercitato dalle multinazionali, nell’analizzare un campione di 569 imprese nella OCDE, sull’aspetto dell’internazionalizzazione in Ricerca e Sviluppo. Delle imprese studiate, 341 realizzavano meno del 10% dei loro sforzi tecnologici all’estero e solo 43 realizzavano più del 50% degli sforzi in altri paesi. Le più grandi imprese del Giappone, degli Stati Uniti, di Francia e di Germania effettuavano più dell’85% delle loro spese in R&S entro le loro frontiere Costa Lima, 2000). Questi dati convergono con le tesi di Celso Furtado sulla valutazione dell’efficacia del processo di sostituzione delle importazioni in America latina, realizzate attraverso dei gruppi stranieri. Per l’economista, questo processo è stato ed è limitato, in primo luogo perché le imprese straniere rispondono ad un sistema di decisioni che sta fuori del paese. In secondo luogo perché decentralizzano determinate attività, mentre ne centralizzano altre, specialmente quelle di maggior valore aggiunto basate sulle tecnologie di punta. La complessità e la rapida obsolescenza dei prodotti le rendono dipendenti sempre di più dagli input delle case-madri. In terzo luogo, ancora più determinante, è il loro scopo, per ciò che concerne l’integrazione internazionale.”Che paesi come il Brasile e l’Argentina, che hanno raggiunto un grado relativamente elevato di industrializzazione senza per nulla riuscire a modificare la composizione delle esportazioni -che continuano a riflettere le vecchie strutture esportatrici di materie prime- costituisce la chiara indicazione di ciò che questo tipo di industrializzazione è, un semplice adattamento di una nuova forma di dipendenza esteriore” (furtado, 1987: 40). Sebbene l’America latina abbia costruito, dall’inizio degli anni 50, una ricca e creativa produzione accademica in relazione agli ampi temi della scienza, della tecnologia, dell’innovazione e soprattutto delle politiche di sviluppo, quando è giunta a formare le proprie specifiche agenzie di scienza e tecnologia, (il CNPq, in Brasile ; il Conycet in Argentina; il Conacyt in Messico e il Conicyt in Cile nel 1965); qualunque bilancio o valutazione del settore negli anni 90 non può essere ottimista (Soares [1], 2001). Ci sono stati sicuramente contributi inestimabili come quello dell’argentino Amílcar Herrera [2], che fissa la distinzione tra le politiche tecnologiche esplicite e implicite, strumento molto utile nell’indicarci che le decisioni in materia di politica economica e di industrializzazione sono quelle che definiscono la dinamica tecnologica, indipendentemente dalle strategie politiche e piani di C&T. Le strategie esplicite, quasi sempre ispirate nell’esperienza dei paesi industrialmente avanzati, erano in generale descritte in progetti e documenti che difficilmente uscivano dalla carta in cui erano scritti, perché richiedevano uno Stato diverso e trasformazioni sociali che non esistevano. Fondamentale è anche il suo contributo nel senso di rivelare le cause del ritardo scientifico e cercare i modi per superarlo attraverso una politica di C&T adeguata alla realtà della regione, rivelando che le imprese dell’America latina presentavano una serie di condizionamenti che hanno generato degli ostacoli, ad esempio la non combinazione dei risultati in R&S delle università; i comportamenti delle imprese; la struttura dell’industria. Indica come uno dei nostri problemi, la dimensione delle imprese, le imprese del Nord non sono solo più grandi delle maggiori del Sud, ma lo sono anche in numero, concentrando i loro investimenti in ricerche sulla formazione. O ancora quando per la necessità di formulare strategie di ricerche nelle case-madri articolate e ancorate a progetti nazionali che facciano parte di una politica scientifica ampia (Oteiza, 1991). Altri autori hanno dato dei grandi contributi, che non c’è bisogno di mettere in dettaglio qui, ad esempio Oscar Varsavksy, che propone la formazione di squadre interdisciplinari di scienziati; quello di Jorge Sábato e il suo modello triangolare, che sottolineava la mancanza di articolazione e le debolezze tra Governo, infrastruttura di ricerca e struttura produttiva, senza dimenticare l’urgenza che invocava, nel trasferire i risultati della ricerca e dell’articolazione dell’infrastruttura scientifica e tecnologica alla struttura produttiva della società. O ancora Osvaldo Sunkel, che accentuava l’impatto sulla periferia dei processi di transnazionalizzazione combinata con la sostituzione di importazioni. I lavori di Jeorge Katz, che valorizzavano gli aspetti incrementali delle fasi tecnologiche, dell’apprendistato collettivo degli adattamenti; dei loro studi sui brevetti in America latina. Non possiamo dimenticare “l’industrializzazione monca in America latina”, di Fernando Fejnzylber e la scoperta delle “competitività spurie”; nemmeno della competente produzione del nucleo “neo-schumpeteriano” di Economia Industriale della UFRJ,Paulo Tigre, Fábio Erber, Cassiolato. Non è stata e non è la mancanza di competenza investita e di teorizzazione originale ciò che ha ostacolato l’indipendenza e l’avanzamento tecnologico nella regione. L’America latina,è in extremis, una risultante delle trasformazioni che si sono avute nel continente europeo nel suo passaggio alla fase mercantile del capitalismo. Senza ombra di dubbio ha le sue particolarità, i suoi processi di articolazione coloniale, di liberazione di costruzione sovrana. Ma il carattere della dipendenza esterna e del sottosviluppo è un tratto indelebile della sua storia. Il CEPAL ha pubblicato recentemente un comunicato dove si legge che nel 1960 c’erano nella regione 114 milioni di poveri, che sarebbero aumentati a 196 milioni nel 1990, arrivando al 1994 con la triste constatazione che “il numero dei latino americani e caribegni in situazione di povertà raggiunge i 210 milioni”, per una popolazione di 481 milioni nel 1995 (Costa Lima, 2000). Nonostante la crescita sistematica del PIL regionale tra il 1950 e il 1980, quando raggiunse la media del 6% l’anno, e la cattiva costruzione dello sviluppo, ha generato una serie di squilibri che oggi si vedono aggravati, tenendo in conto gli “anni perduti del 1980”, il basso tasso di crescita risultante dalle politiche di aggiustamento, che includono la concentrazione di reddito e l’assenza di politiche sociali strutturali (tabelle 1, 2 e 3).
I paesi sviluppati al contrario di ciò che ha fatto l’America latina, aumentarono il livello di qualità dell’educazione oltre l’aumento del numero di matricole, elevando considerevolmente le spese, per un valore compreso tra i US$ 2000 e i US$ 4500 annui per alunno, quasi dieci volte di più che in quella regione. Questa è una sfida che dovrà essere affrontata con fermezza e creatività, se si vuole stabilire un sistema regionale di innovazione degno del nome (Sainz e Calcagno, 1992). Se consideriamo il Decennio Perduto degli anni ’80 e le politiche di aggiustamento prevalenti nel consiglio di Washington, che stabilirono un modello economico basato sullo stato minimo (privatizzazioni); deregolamentazione finanziaria e lavorativa e controllo monetarista, è più facile capire i risultati rozzi e contraddittori della regione, soprattutto dei grandi paesi, in termini di progresso tecnologico, nonostante i grandi investimenti diretti come risultante della vendita delle imprese statali e della politica di apertura commerciale. Con degli indicatori così sostenuti della concentrazione di reddito e dello scarso investimento dispendio e in un settore così strategico ed essenziale come l’educazione, evidenziati nelle tabelle 2 e 3, è difficile per l’America Latina presentare risultati significativi in Scienza e Tecnologia. Se non bastassero gli equivoci accumulati nel tempo nella regione, in termini di comprensione del ruolo decisivo nella globalizzazione, nei settori significativi della società civile, benché si parli della nuova società di informazione e di conoscenza, lo spirito che prevale è molto più quello della subordinazione, della ricerca di imitazione o dell’importazione diretta. Sebbene ci sia un grande insieme di problemi comuni nella regione, è importante segnalare le asimmetrie e le differenze in C&T esistenti, come si può vedere nella tabella 4 sotto. Malgrado tutto, e malgrado la forte concentrazione brasiliana nel settore, se facessimo una comparazione con gli USA, si riscontrerebbe l’enorme fragilità della posizione dell’America Latina. Anche riconoscendo l’eterogeneità della situazione, in S&T in America Latina, possiamo sintetizzare i punti nevralgici del ritardo tecnologico della regione, senza dimenticare che la stessa natura delle crisi e le instabilità politico-economiche, da ciò decorrenti, stanno alla radice del problema:
3.1 C&T in Brasile negli anni ’90
Per l’economista Maria da Conceição Tavares, in un saggio brillante e pessimista, l’economia brasiliana è sempre cresciuta “verso l’interno” e allo stesso tempo è sempre stata inserita in forma periferica e dipendente dall’ordine economico mondiale. Malgrado non possa contare sulla generazione di progresso tecnologico proprio, neanche con valuta convertibile sul mercato mondiale, è stata una delle economie che, per più di 100 anni, ha avuto uno dei maggiori tassi di crescita del mondo capitalista (Tavares, 1999: 456). Il Brasile ha sempre funzionato come una piattaforma di espansione del capitale industriale (1950) e, soprattutto, finanziario (dal XIX secolo) internazionale. In pieno XXI secolo, gli interessi degli Stati Uniti per il Brasile sono di mantenere la vocazione agro-esportatrice (i nostri “vantaggi corporativi”), di preferenza all’interno delle proprie regole di libero commercio, delle quali essi stessi sono autori (Costa Lima, 2000). Avevo segnalato in un altro articolo le trappole di un modello di sviluppo senza creatività, senza forza endogena, strutturato in maniera che la leadership delle sue industrie venisse esercitata attraverso filiali di imprese e i cui centri di gravità erano localizzati in altri paesi, e l’approfondimento di questo modello difficilmente svilupperà un processo creativo interno, perché questo non è l’obiettivo di chi comanda il processo (Costa Lima, 2000). Lo stesso con la creazione, nel 1951, del Consiglio Nazionale di Ricerche -CNPq, non si può affermare di fatto che il paese all’epoca avesse una politica deliberata di C&T. Solo a partire dagli anni ’70 si pensa di sviluppare meccanismi finanziari specifici e di costruire un infrastruttura istituzionale capace di stabilire un progetto di autonomia e tecnologica per il paese. Negli anni ’80 fu fondamentale la creazione di organi pubblici che dessero supporto finanziario perché le imprese potessero investire in C&T, ad esempio l’Istituto Nazionale di Proprietà Industriale (INPI), per la registrazione dei brevetti e l’acquisto di tecnologie; l’Istituto Nazionale di Metrologia, Normalizzazione e Qualità Industriale -INMETRO, per norme tecniche e certificazioni di qualità, e il FINEP, una specie di banca nazionale per lo sviluppo di C&T. C’è una lunga polemica in Brasile sulle statistiche che si riferiscono a C&T e, soprattutto, quanto alla forma di verifica di queste spese da parte del settore privato. Ciò nonostante è evidente che c’è stato un processo di ristrutturazione nell’industria brasiliana negli anni ’90, che segue in maniera mimetica la tendenza alla globalizzazione e all’apertura del mercato, dando come risultati un rinnovamento tecnologico selettivo e incrementale in diversi settori. Secondo il bilancio stabilito da Paulo Tigre ed altri per gli anni ’90, il settore produttivo brasiliano aveva incrementato la sua partecipazione nelle spese in C&T, dal 22% al 31% degli investimenti totali. Esistono questioni preoccupanti, per quanto riguarda l’aumento delle importazioni, che ha deteriorato sistematicamente la Bilancia dei Pagamenti, da un surplus di US$ 16 miliardi nel 1992 ad un deficit di US$ 9 miliardi nel 1997. Le importazioni triplicarono dal 1992-1997, balzando da US$ 20 miliardi a US$ 60 miliardi, poiché le esportazioni crebbero solo del 7,6% l’anno, nello stesso periodo (Tigre e altri, 1999; 217). La forte entrata di capitale internazionale, attraverso gli IDE, configurandosi nell’acquisizione di imprese statali, principalmente in servizi di telefonia, energia e banche, non genera esportazioni. Allo stesso tempo vedono aumentare sensibilmente il coefficiente di importazione, che solo nel settore dell’elettronica, nel 2000 è stato più di US$ 6 miliardi, senza menzionare l’aumento delle rimesse in valuta all’estero (tabella7). Pertanto la mancanza di una politica aggressiva di esportazione che va a pesare sul deficit pubblico, come l’assenza di una politica industriale attiva nei settori ad alta intensità di conoscenza, finiscono per accelerare il grado di dipendenza tecnologica.
L’aumento delle importazioni delle forniture e dei contratti tecnologici evidenzia che non stiamo camminando verso una posizione miglior sul mercato internazionale, se continuiamo scegliendo, con rare eccezioni, le esportazioni dei cosiddetti “vantaggi comparativi naturali”. Nonostante l’attuale governo abbia stabilito nell’anno passato dieci “fondi settoriali” di sviluppo scientifico e tecnologico, che probabilmente andranno a generare una cospicua fetta di più di un miliardo all’anno in C&T, ad esempio dei fondi di petrolio, di gas, di telefonia, di energia elettrica, trasporti terrestri, risorse idriche e minerali, attività spaziali, oltre al fondo “verde giallo” (università-imprese), che ancora non ci garantisce che queste risorse verranno utilizzate nel modo migliore, né che saranno capaci di istituire un effettivo sistema nazionale di innovazione, come afferma Fabio Erber “in contesti dove predomina l’investimento minimo per in organismi di C&T, il concetto sembra essere quello di una bassa applicazione” (op. cit.: 186). Il fondo “verde giallo” è l’unico a creare nuovi contributi e che non è destinato ad un settore industriale o di servizi specifico. Per alimentare il programma Università-Impresa, che è il suo obiettivo, deve essere pagato un contributo del 10% per persona giuridica che detenga una licenza di uso della conoscenza tecnologica e per chi avessi contratti con l’esterno che implichino trasferimenti di tecnologia, sfruttamento di brevetti, uso di marchi, fornitura di tecnologia e prestazione di assistenza tecnica (Bittar, 2000). Secondo il professor Roberto Nicolsky, della UFRJ, la formattazione dei fondi settoriali non permetterà che si instaurino le innovazioni tecnologiche necessarie, soprattutto perché tiene il mito che “è nell’università che si fa ricerca ed innovazione tecnologica, contrariamente alle tendenze mondiali e nei paesi di punta in tecnologia, dove il 75% delle ricerche sono dirette all’innovazione tecnologica e realizzate nel settore produttivo, pur garantendo un ruolo sostanziale alle università in questo processo” (Nicolsky, 2000). Tuttavia il rigido controllo delle spese pubbliche da parte della FMI ha significato esattamente il contrario, a misura che il governo passa a restringere le risorse per l’educazione superiore, rottamando lentamente l’insegnamento pubblico, sia attraverso l’appiattimento salariale del settore, sia attraverso i tagli alle risorse per la ricerca, tra gli altri. [1] Susanna Arosa Soares traccia un quadro, sintesi della storia della formazione dei sistemi nazionali di C&T nel Mercosud e nel Cile. [2] È un’opera indispensabile: Herrera Amílcar (1971), Ciência e Política na America Latina. México: Siglo XXI. Herrera contribuì anche in maniera decisiva al consolidamento di un nucleo di C&T nella Unicamp, in Campinas, São Paulo.
|