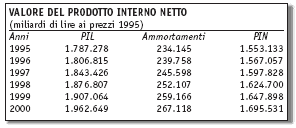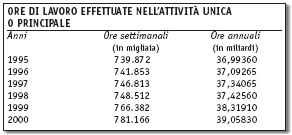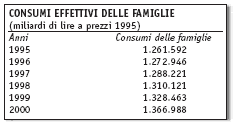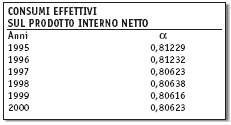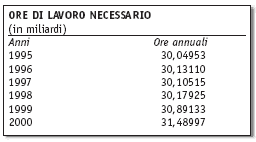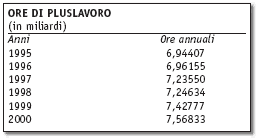![]()
Rubrica
Per la critica del capitalismo
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Giampiero Betti Università di Bologna Giorgio Gattei Professore Università di Bologna
Lavoro vivo e pluslavoro in Italia. Per una misurazione teorico-statistica (prima parte) Neoliberismo di guerra e ordine mondiale
Tutti gli articoli della rubrica "Per la critica del capitalismo"(in tutti i numeri di Proteo)
|
La prima grandezza statistica che ci servirebbe è il «prezzo di produzione del prodotto netto», che tuttavia non esiste. Esso può però essere approssimativamente rappresentato nei dati della Contabilità nazionale dal Prodotto Interno Netto a prezzi costanti. Spieghiamoci meglio [1]. È noto che la variabile di riferimento consuetudinariamente utilizzata per valutare l’efficienza di una economia nazionale è il Prodotto Interno Lordo (PIL) che misura il valore statisticamente accertato dell’attività di produzione delle unità produttive residenti in un dato intervallo di tempo sul territorio nazionale di un certo paese. Esso corrisponde all’ammontare della produzione complessiva di beni e servizi finali diminuita dei beni e servizi (materie prime e semilavorati) che sono stati necessari a quella produzione e che nella Contabilità nazionale sono definiti come «consumi intermedi». Ma il Prodotto Interno Lordo è, per l’appunto, lordo perché comprende ancora al proprio interno il valore delle quote di ammortamento dei beni strumentali impiegati come macchine, impianti, mezzi di trasporto e così via (i beni strumentali sono quei beni che perdono valore solo progressivamente nel corso dei processi produttivi a seguito del logorio fisico e della obsolescenza). Ora, se dal Prodotto Interno Lordo si tolgono anche questi ammortamenti, si ottiene un’altra misura del prodotto nazionale: il Prodotto Interno Netto (PIN) - che tra l’altro l’ISTAT ha sempre diligentemente rilevato - che è il dato empirico che più si avvicina alla grandezza economica del «prezzo di produzione del Netto» in quanto misurato a prescindere dal consumo dei beni intermedi (come il PIL), ma pure dall’ammortamento del capitale fisso. Così è solo il Prodotto Interno Netto a determinare il prezzo della produzione nazionale al netto di tutti i consumi di capitale costante, circolante o fisso che sia [2]. Ma l’ISTAT rileva il Prodotto Interno Netto (per adesso soltanto fino all’anno 2000) secondo due diversi indici di prezzo: ai prezzi correnti ai vari anni, o PIL «nominale», e a prezzi costanti riferiti all’anno 1995 (PIL «reale») [3]. Per avvicinarci alla misura del prezzo di produzione, che è quanto qui interessa, pare evidente escludere dalla considerazione la serie statistica del Prodotto Interno Netto a prezzi correnti, che è troppo condizionata dagli effetti monetari contingenti. Naturalmente neanche i prezzi costanti dell’ISTAT, ottenuti moltiplicando le quantità dei beni e servizi prodotti ai vari anni, anziché per i corrispondenti prezzi di mercato, per quelli registrati nell’anno prescelto come base (nel caso in questione quelli del 1995), corrispondono ai prezzi di produzione della teoria (se non altro perché, per essere tali, dovrebbero scontare l’uniformità dei salari unitari e dei saggi del profitto, che sono condizioni di equilibrio di lungo periodo del tutto impossibili a concretizzarsi nella realtà). Ma siccome di statistiche del PIN non se ne danno altre, si tratta di fare di necessità virtù: dovendo scegliere solo tra queste due contabilità, non resta che adottare quella a prezzi costanti in quanto più prossima alla grandezza economica che ci interessa quantificare. E così, individuato il PIN a prezzi costanti come la misura statisticamente più vicina alla grandezza economica richiesta dalla teoria, raccogliamo i dati ISTAT che ci portano a determinarla:
Ciò posto, nella «equivalenza di neovalore» compare a secondo membro il lavoro vivo complessivo. È questa una grandezza economica che sembra trovare invece un più preciso riscontro nella contabilità dell’ISTAT, che contempla infatti la misurazione statistica delle Ore di lavoro effettuate nell’attività unica o principale durante la c.d. “settimana di riferimento” (la prima settimana priva di giorni festivi del mese in cui viene condotta l’indagine sulle forze di lavoro) e rilevate nella c.d. “settimana di rilevazione” (la settimana successiva a quella di riferimento durante la quale i rilevatori si recano presso le famiglie per intervistarle) [4]. Così l’ISTAT calcola l’ammontare settimanale di qualcosa che è molto simile al lavoro vivo e che, nell’ipotesi di un anno lavorativo di cinquanta settimane, dà quella stima delle ore di lavoro erogate annualmente in Italia che approssima la grandezza teorica del lavoro vivo [5]:
A sua volta il lavoro vivo si suddivide, come abbiamo visto, nel lavoro necessario (o «lavoro indisponibile») e nel pluslavoro che dà luogo al profitto. Ma che cos’è il lavoro necessario? È il costo del «lavoro vivo» quale è monetariamente rappresentato dal monte-salari pagato ai lavorator nel complessoi. Poi questo monte-salari viene convertito, al termine del processo di produzione, nell’acquisto dei beni di consumo che risultano accessibili ai lavoratori traendoli dal «prezzo del Netto» (si fa sempre l’ipotesi che non si verifichino scambi internazionali oppure, alternativamente, che i valori delle esportazioni e delle importazioni si compensino esattamente). Utilizzando allora l’«equivalenza di neovalore», una semplice proporzione può consentire di risalire al quantum di lavoro vivo contenuto nel prezzo di quella parte del «prezzo del Netto» che viene destinata al benessere dei lavoratori impiegati nella produzione: infatti il «prezzo del Netto» sta al lavoro vivo così come il prezzo dei beni di consumo acquistati dai lavoratori sta al lavoro necessario. Statisticamente, si tratta di scegliere nella Contabilità nazionale la misura del costo monetario del lavoro vivo. Ce ne sono due che possono aspirare a tanto titolo: la prima è direttamente il totale dei salari pagati, la seconda è la somma dei consumi complessivi. Naturalmente parrebbe più corretto utilizzare la prima misurazione, ma se si fa l’ipotesi che i consumi siano: a) espressione dei soli lavoratori e b) che vi spendono l’intero monte-salari (siccome la prima ipotesi è esagerata per difetto, dato che anche altri consumano, mentre la seconda è esagerata per eccesso, dato che anche i lavoratori possono risparmiare, si può supporre che le due esagerazioni si compensino), allora può essere più conveniente servirsi della seconda, che l’ISTAT peraltro calcola anche a prezzi costanti (a base 1995) rendendola così perfettamente omogenea alla misura precedentemente scelta del PIN. Abbiamo allora la serie statistica dei:
che rappresenta la parte indisponibile del Prodotto Interno Netto secondo la percentuale a che risulta agli anni:
Sulla base della «equazione di neovalore» la percentuale α sarà la stessa che misura la proporzione del lavoro necessario sul lavoro vivo. E quindi, applicandola all’ammontare complessivo del lavoro vivo, ne risulta l’ammontare delle ore di lavoro necessario:
A questo punto basta sottrarre dalle ore di lavoro vivo le ore di lavoro necessario per arrivare alla misura quantitativa delle Ore annuali di pluslavoro annuo che sono state erogate in Italia nel periodo temporale considerato:
Il risultato, se si accettano tutte le approssimazioni che si sono dovute introdurre per arrivare a tanta misurazione statistica, mostra un progressivo incremento della massa del pluslavoro [6], sulla cui base è possibile procedere al calcolo del saggio del pluslavoro, che è «l’espressione esatta del grado di sfruttamento della forza-lavoro da parte de capitale» [7]. Tuttavia il passaggio dalla massa al saggio del pluslavoro non è così immediato come si potrebbe pensare. Sorgono questioni fondamentali che devono essere discusse in dettaglio, sicché pare opportuno rimandare il seguito ad un altro articolo. (Continua). [1] I testi consultati per la definizione delle grandezze macroeconomiche cui si farà riferimento sono: G. ANTONELLI, G. CAINELLI, N. DE LISO, R. LEONCINI, S. MONTRESOR, Economia, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 373-377; G. ALVARO, Contabilità nazionale e statistica economica, Cacucci, Bari, 1999, pp. 160-162; V. SIESTO, La contabilità nazionale italiana., Il sistema dei conti del 2000, Il Mulino, Bologna, 1996. [2] È noto che il “punto di vista del Netto” è stato reintrodotto nell’analisi economica da Piero Sraffa: «il reddito nazionale di un sistema in stato reintegrativo è formato dall’insieme di merci che rimangono dopo che dal prodotto nazionale lordo abbiamo tolto una per una le merci che occorrono per reintegrare i mezzi di produzione che sono stati usati dall’insieme delle industrie» (P. SRAFFA, Produzione di merci a mezzo di merci, Einaudi,Torino, 1969, p. 14). Ma pure la teoria neoclassica della crescita, quale ad esempio esposta da Robert Solow nell’articolo seminale Un contributo alla teoria della crescita economica del 1956, assume l’identico punto di vista per misurare «il prodotto ottenuto con l’aiuto di due fattori di produzione, il capitale ed il lavoro» quando stabilisce che «per prodotto si deve intendere il prodotto netto dopo aver tenuto conto dell’ammortamento del capitale» (R. SOLOW, Crescita, produttività, disoccupazione, Il Mulino, Bologna, 1996, p. 33). La scelta del Prodotto Nazionale Netto (PNN) è peraltro opportunamente presente anche nell’unico tentativo che ci è noto di misurare statisticamente il pluslavoro in italia» in Italia: cfr. A. IOVANE e G. PALA, Lavoro salariato e tempo libero. Un’analisi dell’economia del tempo, Franco Angeli, Milano, 1977, p. 139 («per tener conto del consumo dei mezzi di produzione impiegati per la produzione strettamente necessaria si devono porre a confronto le ore complessivamente lavorate con il PNN; con il PNL, viceversa, si escluderebbe proprio l’effetto degli ammortamenti»). [3] ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, Contabilità nazionale, Tomo 1. Conti economici nazionali. Anni 1970-2000, Roma, 2002. [4] ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, Forze di lavoro. Media 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000, Roma, ai vari anni. [5] A confronto, le cifre stimate da A. Iovane e G. Pala (op. cit., p. 134) erano, in miliardi di ore, nel 1960: 38,24; nel 1964: 39,24; nel 1968: 37,99; nel 1972: 38,01. E questo è stato il loro commento: «il numero stimato di ore effettive lavorate non ha subito variazioni notevoli, oscillando intorno ad un valore medio di circa 38 miliardi: questo è il dato che più immediatamente interessa per la ripartizione del tempo sociale complessivo» (idem, p. 135). Trent’anni dopo la cifra risulta più o meno la stessa. [6] Il paragone con la cifre del pluslavoro stimate da A. Iovane e G. Pala è possibile soltanto dopo una precisazione. I due autori, avendo distinto il «consumo necessario (salario di sussistenza)» (op. cit., p. 138) dal sopraconsumo (che misura il consumo oltre la sussistenza), ricavano un «tempo di lavoro strettamente necessario» da cui per differenz, ottengono, come massa del pluslavoro, la somma del «tempo di lavoro per sopraconsumo» e del «tempo di lavoro per accumulazione». Ora è soltanto quest’ultima grandezza ad essere confrontabile con le nostre Ore di pluslavoro, dopo di che essa mostra nel tempo questo andamento: 6,45 miliardi di ore di pluslavoro nel 1960; 6,12 nel 1964; 6,10 nel 1968; 5,15 nel 1972 (op. cit., p. 137). [7] K. MARX, Il capitale. Libro primo, cit., p. 251.
|