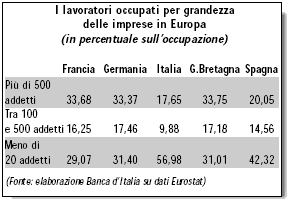![]()
Rubrica
Il punto, la pratica, il progetto
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Luciano Vasapollo Docente di Economia Aziendale, Fac. di Scienze Statistiche, Università’ “La Sapienza”, Roma; Direttore Responsabile Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali (CESTES) - Proteo.
CUB: una realtà su cui contare Il movimento dei lavoratori davanti ai nuovi assetti capitalistici internazionali della competizione globale Comunicato finale della riunione di Napoli sul reddito sociale e i diritti per tutti
Tutti gli articoli della rubrica "Il punto, la pratica, progetto"(in tutti i numeri di Proteo)
|
Nel corso del 2001 l’attività economica è rallentata in misura significativa anche nell’area dell’euro. I principali indicatori congiunturali mostrano che la fase recessiva del 2001 ha toccato il suo punto di minimo nel novembre 2001. Nella media dell’anno il prodotto è aumentato dell’1,5%, contro il 3,5 nel 2000. Tutti i paesi dell’area hanno registrato una decelerazione dell’attività nel 2001. Anche per il 2002 e questi ultimi mesi sul rallentamento dell’attività economica nei paesi dell’area hanno pesato la brusca frenata degli investimenti e la netta decelerazione delle esportazioni. Il netto deterioramento delle attese sull’evoluzione della domanda estera ha inciso sull’accumulazione, che si è arrestata. Il tasso di sviluppo dei consumi delle famiglie si è ridotto in misura significativa rispetto all’anno precedente. Il tasso di disoccupazione, sceso di quasi un punto percentuale nel 2000, è rimasto sostanzialmente invariato nel corso del 2001, all’8,3% per crescere poi ulteriormente. La scomposizione settoriale mostra come il rallentamento della crescita dell’occupazione abbia riguardato principalmente il comparto industriale. Anche la creazione di posti di lavoro nei servizi è risultata più lenta rispetto all’anno precedente [1]. In tutti i paesi dell’area si è registrata una moderata intensità della ripresa nel 2002, comunque inferiore a quella degli Stati Uniti. Infatti, contrariamente alle attese di molti operatori, la produzione industriale non ha mostrato segni di accelerazione [2]. Si può stimare che il rallentamento dell’attività economica nell’area dell’euro sia riconducibile per oltre la metà a quello della domanda mondiale, su cui hanno influito i rincari del petrolio negli anni precedenti. Le principali istituzioni internazionali prevedono inoltre una crescita in ripresa per il biennio 2003-2004. Ciò in previsione di una accelerazione degli investimenti, dei consumi delle famiglie e di una ripresa delle esportazioni; il tutto probabilmente sarà possibile se si continua a mantenere in maniera diretta e indiretta un contesto di keynesismo di guerra. Si consideri che l’ipotesi di riforma del bilancio europeo da effettuare per il 2006 ha scatenato gli economisti di scuola keynesiana, che vedono la possibilità di realizzare un modello di federalismo classico in modo da utilizzare il bilancio comunitario in funzione di stabilizzazione anticiclica, togliendo così tali funzioni alle singole autorità nazionali. In quest’ambito bisogna considerare ovviamente le spese della difesa e della sicurezza che dovranno essere sussunte in un quadro generale finanziario europeo mettendole al centro della riforma del bilancio comunitario; giustificando tutto ciò in funzione dei mutamenti del quadro geopolitica e della nuova caratterizzazione che si è data la NATO a partire dagli attentati dell’11 settembre del 2001. Si consideri che in un rapporto commissionato dal Governo Federale USA si è evidenziato che i quattro maggiori paesi della UE (Gran Bretagna, Germania, Francia e Italia) hanno avuto una bassa crescita del PIL per la scarsa spesa della difesa. Il rapporto della RAND si conclude sottolineando che la spesa per la difesa dei suddetti paesi dell’UE è assolutamente insufficiente non solo per gli impegni assunti dalla UE nella NATO ma anche per gli impegni che i paesi membri dell’UE hanno sottoscritto nell’ambito della ESDP (European Security and Defence Policy) e della RRF (Rapid Reaction Force). Moderazione dell’inflazione, politiche economiche decisamente espansive a connotati militari nelle maggiori economie e la ripresa dei profitti delle imprese maggiormente legate all’economia di guerra, sono, quindi, i fattori principali che potrebbero consentire alle economie avanzate di riportarsi su un sentiero di crescita nel medio termine [3]. 5. Il ruolo dell’Italia nella competizione globaleSi sta completando anche in Italia una fase di ristrutturazione e ridefinizione del modello capitalistico che aveva caratterizzato il periodo della ricostruzione post-bellica e della corsa allo sviluppo industriale tipica degli anni ‘60 e ‘70. Non si tratta soltanto del passaggio dall’era taylorista alle forme di liberismo postfordista, ma anche del diffondersi dei diversi modi di presentarsi delle attività produttive, con i connessi mutamenti nelle dinamiche evolutive dello sviluppo e delle soggettualità socio-economiche. In Italia, così come nel resto dei paesi a capitalismo maturo, si è davanti, oltre che ad alcuni processi di deindustrializzazione e ad una delle tante crisi del capitalismo, anche ad una sua importante trasformazione in chiave economico-sociale che investe l’intera società. Cioè dei processi di modificazione economico-produttiva che creano nuovi bisogni senza soddisfarli, con una concezione della crescita economica, dello stesso modo di essere della vita che induce a diversi comportamenti socio-economici della collettività imposti e coercizzati dalla cultura d’impresa; imposti, cioè, dalla flessibilità dell’impresa diffusa nel tessuto sociale. Si superano, così, molte rigidità della società industrialista basata sulla centralità di fabbrica in un contesto di crescita quantitativa senza qualità dello sviluppo nelle aree centrali e di completa miseria assoluta senza mediazioni nelle aree del Sud e più periferiche. Ciò spiega ancor meglio i connotati anche qualitativi, oltre che quantitativi, della ristrutturazione del capitale, la sua ridefinizione sociale e come essa assuma sempre più un ruolo fondamentale per comprendere il conflitto di classe delle nuove forme che andrà assumendo. L’evoluzione del quadro economico internazionale si ripercuote, quindi, necessariamente anche sull’economia italiana. È evidente un rallentamento dell’attività produttiva. Le ultime stime indicano che anche il 2003 sarà un anno in cui difficilmente potrà aversi una ripresa economica. Tale decelerazione è stata causata da un indebolimento molto rapido della domanda aggregata, e ciò attraverso una contrazione dei consumi totali e degli stessi investimenti. È chiaro il legame con il mutamento delle condizioni dell’economia internazionale, in primo luogo del rallentamento della domanda mondiale. Infatti, l’unica componente che ha contribuito a sostenere la crescita, pur modesta, della domanda aggregata (consumi, investimenti, esportazioni) è stata quella interna a carattere derivato e riconducibile comunque soprattutto all’industria connessa alla produzione di tipo militare. Se comunque si nota una piccola ripresa degli investimenti, dovuta soprattutto al settore delle costruzioni e alle infrastrutture, si evidenzia un trend assolutamente negativo per quanto riguarda i consumi. E sembra veramente incredibile la ricetta del governo italiano sul rafforzamento della dotazione di infrastrutture nel Paese e sull’equazione meno tasse e contributi (ovviamente in particolare per le imprese) uguale a più sviluppo. L’incredibilità nasce dal fatto che proprio in questo momento si evidenzia una fase molto critica per la finanza pubblica, e che gli unici provvedimenti per aumentare le entrate fiscali sembrano le privatizzazioni, le cartolarizzazioni e i concordati fiscali. Non si pensa assolutamente invece a ridare slancio al PIL attraverso interventi che rafforzino la struttura produttiva italiana rilanciando l’occupazione. Si pensi al caso del gruppo FIAT che insieme al suo indotto pesa sul PIL per circa lo 0,5% ed è il produttore che ha subito sul mercato europeo la maggiore contrazione delle vendite mentre ai primi anni ‘90 era il secondo gruppo in Europa con una quota del 15%. Sembrerebbe quindi opportuno un rilancio degli investimenti e dell’occupazione e non le manovre ridicole sui condoni e le finte diminuzioni delle tasse. Il contributo delle attività economiche all’incremento annuo del PIL è stato piuttosto differenziato: positivo ed elevato quello delle attività dei servizi e delle costruzioni, quasi nullo quello delle attività industriali in senso stretto. Tra il 1995 e il 2001 il PIL è aumentato in Italia in media dell’1,9% ogni anno. Alla base della debole crescita della nostra economia si ritrova una perdita di competitività sia sul mercato internazionale sia su quello interno. Il volume delle esportazioni italiane è aumentato tra il 1995 e il 2001 del 25%. Nello stesso periodo lo sviluppo del commercio mondiale è stato del 45%. La quota percentuale di prodotti italiani nel commercio mondiale, valutata a prezzi costanti, è diminuita tra il 1995 e il 2001 dal 4,6 al 3,7%. È solo con tali caratterizzazioni macroeconomiche che si può pensare ad una ripresa della crescita del PIL e della domanda interna, cui si dovrebbero aggiungere una dinamica favorevole della redditività di impresa e la riduzione della pressione fiscale, mantenendo alta la domanda di investimenti, che nel 2004 registrerebbero un tasso medio-alto di crescita. Le esportazioni dovrebbero rimanere stabili risentendo della brusca frenata registrata negli ultimi anni. Il calo della competitività di tutto il sistema economico è dovuto maggiormente ai risultati delle imprese più grandi, in cui si notano ormai da anni difficoltà nel diffondere gli avanzamenti tecnologici, per stimolare la ricerca, per formare capacità gestionali. In questa direzione spingono sia il peggioramento delle prospettive di ripresa dell’economia internazionale sia la perdita di competitività di prezzo delle nostre esportazioni sui mercati extra-europei. Nel 2003 e 2004 il PIL italiano, traendo stimolo dalla domanda interna sia dal lato dei consumi delle famiglie che degli investimenti, dovrebbe riprendere a crescere più o meno in linea con l’area dell’euro [4]. Il passaggio ormai è chiaro. Il terziario sempre più abbandona il carattere residuale-assistenziale diventando, attraverso i processi di flessibilità e precarizzazione imposti dalla nuova fase capitalista, elemento di mantenimento e accelerazione della crescita quantitativa, fattore trainante di un modello capitalistico che si è allontanato dalla centralità industriale di fabbrica. Un terziario implicito ed esplicito capace di rispondere in termini quantitativi, ma soprattutto qualitativi, alle continue trasformazioni ed evoluzioni della domanda, promuovendo e realizzando di pari passo processi innovativi per i fattori dell’offerta, imponendo all’intero corpo sociale, alle nuove figure del lavoro, del non lavoro e del lavoro negato un adattamento attivo al nuovo ciclo capitalistico basato sull’accumulazione flessibile. Il modello del capitalismo italiano assume come risorsa principale ancora soprattutto le nuove forme del distretto industriale allargato attraverso la struttura e le dinamiche delle filiere internazionali. Un modello caratterizzato da specializzazione delle strutture e della forza lavoro all’interno di reti di imprese in continua trasformazione, con multilocalizzazione delle attività in presenza di strutture dinamiche e continuamente mutevoli. Al contempo si realizza un massiccio ricorso alla flessibilità salariale, all’intensificazione dei ritmi, all’elevata divisione del lavoro che spinge alla precarizzazione e alla diffusione della negazione dei diritti sindacali. La competitività della nostra industria ha risentito della frammentazione dell’attività in un numero elevatissimo di imprese piccole. Dimensioni aziendali ridotte conferiscono elasticità al sistema, ma rendono più difficile lo sviluppo di prodotti e tecniche innovative, limitano l’efficienza e puntando fortemente sul continuo processo di flessibilizzazione e precarizzazione del mercato del lavoro.
Il 95% delle nostre imprese ha meno di 10 addetti. Il contributo che le piccole imprese hanno fornito negli ultimi decenni allo sviluppo della nostra economia è stato determinante, ma la frammentazione rischia ora di incidere negativamente sulle capacità di crescita. Il decentramento produttivo, la delocalizzazione, i processi di esternalizzazione messi in essere dalle piccole, ma anche dalle grandi aziende, riduce sempre più la quota di raggruppamenti di imprese all’interno dei quali le condizioni di lavoro sfuggono ad una regolamentazione, il rapporto con il lavoratore è sempre più a carattere individuale, privo di garanzie. A ciò si aggiunge l’estendersi del fenomeno di miniaturizzazione dell’impresa sino alla forma dell’impresa individuale, con il conseguente allargamento del settore del lavoro autonomo di ultima generazione di strati crescenti di lavoratori espulsi dall’impresa madre, costretti ad un precario lavoro deregolamentato, nei fatti ancora più subordinato di quello che avevano in precedenza. La flessibilità è il nuovo paradigma per realizzare sicuramente i diversi obiettivi del moderno progetto della società del capitale: primo fra tutti un attacco deliberato ai diritti acquisiti dai lavoratori (si pensi all’art.18 e in genere all’attacco all’intero Statuto dei Lavoratori fino allo diritto di sciopero, alla deregolamentazione degli orari di lavoro, alle condizioni del lavoro e ai livelli di reddito). Attraverso la flessibilità si effettua poi una frammentazione della classe lavoratrice e di conseguenza della sua possibilità di associazione (è chiaro che se in un’impresa i lavoratori cambiano continuamente per sottostare ai principi di flessibilità è molto più difficile che si organizzino). Si va approfondendo così il solco fra un Paese ricco e settori sempre più vasti di popolazione esclusa, precarizzata, vicino alla soglia di povertà; masse sociali spesso rese da tali processi di precarizzazione talmente emarginate e povere da essere considerate fra i “nuovi miserabili” nella società dell’opulenza. Si giunge così alla determinazione di nuove soggettualità locali del lavoro e del lavoro negato, spesso ai margini del sistema produttivo ufficiale, che svolgono attività sottopagate, lavoro nero, lavoratori che pur di avere garantito un minimo reddito sono costrette ad accettare condizioni qualitative di lavoro tipiche dell’inizio del secolo. Si hanno, inoltre, dinamiche da economia marginale, come ad esempio, le relazioni che tutte le strutture dell’economia stabiliscono con la realtà produttiva meridionale. Relazioni che mutano nel tempo ma che continuano a configurare rapporti funzionali da sottosviluppo, realizzati in maniera specifica per l’evoluzione del sistema in altre aree dell’Italia, per la riproduzione e l’espansione della struttura centrale dell’economia. È con tale approccio che vanno letti i processi di trasformazione. Si capisce così, ad esempio, come viene utilizzata l’industria tradizionale (produzione standardizzata) nelle aree periferiche a basso costo del lavoro e bassa conflittualità, innalzando i livelli di precarietà sociale; mentre, invece, si mantiene l’industria innovativa (produzioni creative) nelle aree centrali con mercato del lavoro altamente specializzato andando a determinare una sorta di aristocrazia salariata e rendendo marginali ed emarginati gli altri soggetti economici del lavoro. Si pensi ai lavoratori del pubblico impiego, agli artigiani, ai piccoli commercianti, ai lavoratori precari, ai sottoccupati, alle sempre più folte masse di disoccupazione palese o più o meno occulta, fino a giungere alle aree sempre più fitte del lavoro negato, di espulsione e completa emarginazione produttiva, reddituale e sociale. Questa situazione ha portato alla nascita di una forma di lavoro nuovo, alternativo chiamato anche “lavoro atipico o informale”. La mancanza di protezioni legislative e sindacali fa sì che questi lavoratori non siano garantiti in alcun modo e si trovino, quindi, ad operare in condizioni di lavoro inaccettabili. Nonostante il rallentamento dell’attività produttiva, nella media l’occupazione, secondo la rilevazione delle forze di lavoro, è aumentata. Ma la corretta lettura di questo dato deve tener conto della precarizzazione del mercato del lavoro, della componente nelle sue diverse forme della quota di occupati di carattere temporaneo; il numero di quelli dipendenti permanenti a tempo pieno ha continuato a crescere anche grazie a specifiche politiche di incentivazione. Questo è dovuto principalmente ad un nuovo sistema economico, che produce quote sempre più elevate di ricchezza con quote sempre più basse di lavoro; ai processi di informatizzazione che producono un grande risparmio di forza lavoro, permettendo così la diminuzione dell’organico dei lavoratori permanenti a tutto vantaggio di coloro che lavorano in modo precario e a tempo parziale e creando un esercito di lavoratori di riserva in pianta stabile. La disoccupazione, la flessibilità e la precarizzazione di salari e delle forme di lavoro diventano così fenomeni strutturali. La maggiore occupazione si è concentrata nel settore terziario. È ancora aumentato il numero degli occupati nel settore delle costruzioni. Sono invece diminuiti gli addetti all’industria manifatturiera [5]. [1] Cfr. Ministero dell’Economia e delle Finanze “Relazione Generale...”, op. già citata. [2] Cfr. Confindustria, Previsioni Macroeconomiche “La politica economica....”, op.citata. [3] Cfr. Confindustria, Previsioni Macroeconomiche “La politica economica...”, op. già citata. [4] Cfr. Confindustria, Previsioni Macroeconomiche “La politica economica...”, op. già citata. [5] Cfr. Banca d’Italia “Assemblea generale ordinaria dei partecipanti”, tenuta in Roma il 31/05/02. Anno 2001, centottesimo esercizio.
|