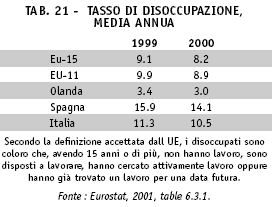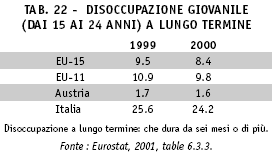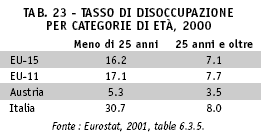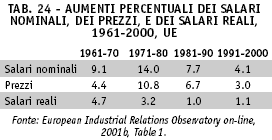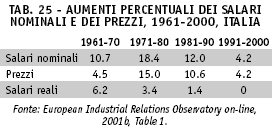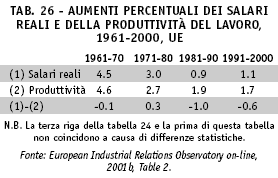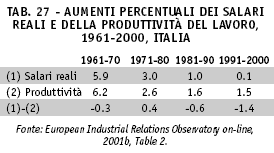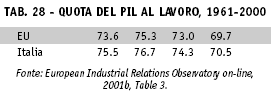![]()
Rubrica
Tendenze della competizione globale
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Guglielmo Carchedi Professore Università di Amsterdam
Il sindacato e il lavoro in Europa Considerazioni sul trionfo elettorale di Lula e il nuovo contesto regionale Economia, potere di influenza e il contesto latino-americano Intervista a René Contreras* a cura di M.Grazia Orsati
Tutti gli articoli della rubrica "Tendenze della competizione globale"(in tutti i numeri di Proteo)
|
Altre caratteristiche del lavoro part-time possono essere sottolineate. - Abbiamo visto che la settimana lavorativa media in Europa è di 38.2 ore (si veda tabella 16 più sopra). Vi sono però grandi differenze tra nazioni a causa del lavoro part-time. La media settimanale per tutti i lavoratori (dipendenti e autonomi) è più bassa in Olanda: 32.9 ore, a causa del suo tasso di lavoratori part-time, il più alto in Europa. Quella più alta è in Grecia (42.4), mentre l’Italia è al di sopra della media (39 ore). - Vi sono grandi differenze tra tipi di lavoro. I lavoratori con contratto a termine e quelli con contratto interinale lavorano di più part-time. - Vi sono grandi differenze tra occupazioni. La proporzione maggiore di lavoratori part-time si trova nei settori della vendita e dei servizi (33%) e delle occupazioni elementari (31%) mentre quella minore si trova nelle forze armate (4%) e negli operatori di macchina (5%). - Il 23% dei lavoratori part-time dichiara che vorrebbe lavorare più ore e il 9% che vorrebbero lavorare meno ore. Mentre l’8% delle donne vorrebbe, lavorare meno ore, la proporzione per gli uomini e 17%. Abbiamo considerato un tipo di lavoro atipico, il lavoro part-time. Un altro tipo di lavoro atipico è il lavoro interinale. La dimensione di questo nuovo fenomeno è relativamente modesta: si stima che, nel 1999, si aggirasse tra 1,8 milioni e 2,1 milioni. Questo è circa tra il 1.1% e il 1.3% del totale della popolazione lavoratrice. È tuttavia un fenomeno in grande espansione (vedi sopra, sezione 2B). Dal 1992, i lavoratori interinali sono raddoppiati in Belgio, nel Lussemburgo, in Inghilterra, in Olanda e in Germania, mentre si sono quadruplicati in Austria; dal 1995, si sono quadruplicati in Portogallo e quintuplicati in Spagna. In termini assoluti, sono la Francia (623.000 e in rapida crescita) e l’Inghilterra (557.000, raddoppiati dal 1992) che hanno il numero maggiore di lavoratori interinali. In termini relativi lo è l’Olanda (4% dei lavoratori dipendenti). Le nazioni in cui tale fenomeno cresce più rapidamente sono l’Italia e la Svezia. I lavoratori interinali sono giovani (ma l’età media incomincia a crescere), sono in prevalenza uomini e lavorano principalmente nell’edilizia (con l’eccezione dei paesi nordici). È chiaro che questo tipo di impiego può disturbare sia la vita lavorativa che quella familiare. In molti paesi dell’UE, questi lavoratori non sono difesi né dal sistema legale (con l’eccezione della Svezia) né dai contratti collettivi. Questa è una deficienza del sindacato. Inoltre, spesso non è chiaro chi abbia la responsabilità sulle condizioni di lavoro, della salute e dell’addestramento (training) di questi lavoratori. Essi sono quindi in una posizione svantaggiata in confronto ad altre categorie di contratto. Per esempio: - Gli incidenti sul lavoro non vengono denunciati - Le ore lavorative sono decise esclusivamente dal datore di lavoro e i lavoratori non hanno nessuna influenza sul ritmo di lavoro - L’addestramento sul lavoro (training) è il più basso di tutte le categorie di tipo di contratto (23%) con l’eccezione di coloro che apprendono un lavoro (apprendistato). La flessibilità ha un notevole effetto sulla durata del lavoro, un effetto certamente negativo per i lavoratori che sono costretti a organizzare il loro tempo di lavoro, sia settimanale che giornaliero, a seconda delle esigenze del capitale. La durata della settimana lavorativa è stabilita legalmente. Nell’UE, vi sono tre categorie di paesi con diverse lunghezze di settimane lavorative.
Nella prima categoria, con una durata massima di 48 ore, questo limite è di gran lunga maggiore della durata stabilita tramite contratti collettivi e della durata lavorata effettivamente. Questo limite quindi opera come una rete di sicurezza e denota un ruolo abbastanza passivo dello Stato. Invece il massimo di 40 ore nella seconda categoria è molto più vicino alla durata effettiva e contrattata e quindi denota un ruolo più attivo dello Stato. Ora, questi massimi possono essere facilmente ecceduti nel contesto della flessibilizzazione. Vediamo un paio di esempi. - In Austria è permesso lavorare fino a 50 ore settimanali se si mantiene una media di 40 ore per un certo periodo. - In Olanda la giornata lavorativa può essere estesa fino a 12 ore se in media la settimana lavorativa non eccede le 60 ore per un periodo di 4 settimane e le 48 ore per un periodo di 13 settimane. - In Norvegia, in circostanze specifiche e previo accordo coi sindacati, la settimana può essere di 54 ore e la giornata di 10 ore per un massimo di 6 settimane consecutive. - In Portogallo è permesso lavorare 50 ore alla settimana a patto che la media di 40 ore è mantenuta per un periodo di 4 mesi. Vi è anche un limite legale per la giornata lavorativa, come riassunto nella seguente tabella:
Anche in questo caso, questi limiti possono essere violati come conseguenza della flessibilizzazione. Per esempio: - In Germania il limite può essere esteso a 10 ore se la media di 8 ore è mantenuta per 24 settimane. - In Olanda, come menzionato più sopra, la giornata lavorativa può essere estesa a 12 ore se in media la settimana lavorativa non eccede le 60 ore per un periodo di 4 settimane e le 48 ore per un periodo di 13 settimane. - In Spagna la giornata può essere allungata se la media di 9 ore è mantenuta per un certo periodo di riferimento. È in questo contesto che bisogna porre la diminuzione delle settimana lavorativa dal 1995 al 2000. Per i lavoratori autonomi, si passa da 47 ore a 46,1 ore mentre per i lavoratori dipendenti si passa da 38 ore a 36.7 ore. Anche la disoccupazione cala, come si vede dalla seguente tabella:
Quindi, mentre l’occupazione cresce, la settimana lavorativa decresce. Cioè si lavora in più ma si lavora meno. Questo, è un dato positivo per i lavoratori o no? Non lo è. Prima di tutto, a prescindere dal miglioramento suddetto, le condizioni per certi settori della classe lavoratrice rimangono terribili.
Come si vede, l’Italia ha il poco invidiabile primato di essere il paese dell’UE che ha il più alto tasso di disoccupazione giovanile a lungo termine. Il tasso è ancor maggiore per i giovani del Sud Italia e per le giovani. La differenza tra i due gruppi di età è eclatante, come si vede nella prossima tabella. Anche qui l’Italia ha il triste primato di essere il paese col tasso più alto.
Si è visto più sopra che il tasso di disoccupazione è maggiore anche per quanto riguarda le donne rispetto agli uomini (tabella 7) e i lavoratori non qualificati relativamente a quelli qualificati (tabella 14). Quindi, chi paga di più per la disoccupazione sono i giovani, le donne e gli operai non specializzati. Vi è stato evidentemente uno scambio, il capitale ha diminuito la settimana lavorativa e la disoccupazione in cambio di un aumento della flessibilità, del ritmo di lavoro, ecc., cioè di tutti quei fenomeni che sono stati analizzati nella prima sezione, mentre la disoccupazione per gli strati più indifesi della popolazione lavorativa (giovani, le donne e gli operai non specializzati) rimane catastrofica. Secondo, prescindendo da queste caratteristiche negative, consideriamo gli effetti della diminuzione della settimana lavorativa sui salari. Vediamo prima di tutto la posizione ufficiale. Non a caso, la ‘moderazione’ salariale è la raccomandazione costante sia della Commissione Europea che del Consiglio Europeo le cui direttive (guidelines) per la politica economica dei paesi membri raccomandano che “nessuna riduzione del tempo di lavoro globale conduca ad un aumento dei costi unitari di lavoro”. Ciò sembrerebbe significare che una diminuzione del tempo di lavoro non debba essere compensata da un aumento dei costi di lavoro reali, della proporzione del PIL che va al monte salari. In altre parole, ciò sembrerebbe significare che si parli di un aumento assoluto del monte salari. In effetti non si tratta di un aumento assoluto ma di un aumento relativo alle ore lavorate. Se le ore lavorate diventa il termine di paragone, affinchè “nessuna riduzione del tempo di lavoro globale conduca ad un aumento dei costi unitari di lavoro”, la diminuzione del tempo di lavoro deve essere accompagnata da una uguale riduzione del costo del lavoro. [1] Vediamo come stanno le cose a livello europeo. Incominciamo dai salari nominali. Il loro tasso di crescita aumenta dal 1960 alla metà del 1970. Questo tasso era di circa il 9% alla fine degli anni ‘60 e aveva raggiunto il massimo, il 19%, nel 1975. Ciò è dovuto alla crescente forza del movimento operaio in quel periodo. Con la sconfitta del movimento, il tasso di crescita diminuisce costantemente fino a raggiungere il 3% alla fine degli anni ‘90.
Come si vede, in Europa i salari nominali cadono, i prezzi pure, ma siccome i salari cadono più dei prezzi, la crescita dei salari reali cade dal 4.7% annuale nel 1961-70 a circa l’1% del ventennio 1980-2000. i salari reali crescono ma ad un ritmo sempre minore. La crescita dei salari reali in Italia è al di sopra della media europea fino all’ultimo decennio per poi precipitare al di sotto di essa nel periodo 1991-2000.
L’aumento dei salari reali deve essere rapportato all’incremento della produttività del lavoro. Se i salari reali crescono ad una percentuale maggiore della produttività del lavoro, vi è una ridistribuzione del reddito a favore del lavoro e a sfavore del capitale. L’opposto vale per un incremento della produttività del lavoro maggiore di quello dei salari reali. A livello europeo, mentre nel decennio 1961-70 i due indici crescono più o meno allo stesso tempo, cioè l’incremento della produttività è diviso più o meno ugualmente tra capitale e lavoro, nel decennio successivo, la fetta al lavoro aumenta leggermente per poi cadere precipitosamente nel ventennio 1981-200, in cui la fetta maggiore va al capitale. [2]
La situazione in Italia si contraddistingue per la sua differenza con la media europea. Nel decennio passato, praticamente tutto l’aumento della produttività è andata al capitale, una distribuzione molto più sfavorevole di quella a livello europeo.
La relazione tra aumenti dei salari reali e aumenti della produttività si riflette sulla fetta di reddito nazionale che va al lavoro. Più aumentano i salari reali relativamente all’aumento della produttività, più aumenta la fetta di reddito che va al lavoro. Ciò può essere visto nella seguente tabella:
Mentre negli ultimi vent’anni la quota del lavoro è costantemente diminuita, di 3.9 punti percentuali, in Italia la diminuzione è stata ancor maggiore, di 5 punti percentuali. In breve, negli ultimi 20 anni del secolo scorso si nota un declino del tasso di crescita dei salari nominali e di quelli reali. I salari reali aumentano meno dell’aumento della produttività. Vi è quindi una ridistribuzione a favore del capitale. 4. Il sindacatoUno delle implicazioni della vittoria del pensiero neo-liberista per il sindacalismo è l’idea, comunemente accettata, che la concertazione a livello di impresa “può dare ai lavoratori dipendenti un maggior controllo sul loro lavoro attraverso il coinvolgimento degli attivisti sindacali nello sviluppo di nuove forme organizzative di lavoro e attraverso la creazione di posti di lavoro ad alta prestazione” (A.Danford, M.Richardson, M.Upchurch, 2002, p.2). I dati presentati in questo articolo sono una confutazione netta di tale posizione. Due conlusioni seguono. Prima di tutto, la concertazione non paga a livello europeo e paga ancor di meno a livello italiano. Quindi,ogni posizione che continui la linea compartecipativa non può che peggiorare tali condizioni, diminuire la combattività, e indebolire i sindacati e le organizzazioni della classe operaia. Siccome l’attacco viene sferrato prima di tutto contro le categorie più deboli, è necessario avanzare domande per un miglioramento delle condizioni di lavoro dei precari, per una riduzione del divario sia nelle mansioni che nel reddito tra uomini e donne, ecc. Secondo, l’attacco alle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori non è un fenomeno isolato ma è un’attacco a livello internazionale. Quindi la risposta deve essere data a livello internazionale. Cosa significa ciò concretamente? Prima di tutto dobbiamo essere coscienti che l’attacco padronale è globale, anche se si manifesta in forme talvolta estremamente diverse in vari paesi, e che quindi il movimento sindacale deve dare una risposta globale a quest’attacco. Secondo, bisogna essere coscienti delle ragioni e conseguenze internazionali dei problemi locali. Terzo, è necessario divulgare le violazioni dei diritti sindacali non solo in Italia ma anche all’estero. Quarto, bisogna evidenziare che tali violazioni hanno una radice specifica nella internazionalizzazione del capitale. Quinto bisogna supportare lotte sindacali all’estero attraverso informazione, coordinazione di proteste, messaggi di solidarietà, partecipazione in campagne internazionali, pressioni sul governo, boicottaggi, se possibile supporti finanziari, pressioni per l’abolizione di leggi anti-sindacali, provvedere assistenza a sindacati e membri sindacali, ecc. Creare contatti permanenti con sindacati e centrali sindacali estere al fine di scambiarsi esperienze, ecc. Sesto, bisogna indagare sugli investimenti esteri in Italia e le loro conseguenze per il movimento sindacale e fare lo stesso per investimenti italiani all’estero, specialmente in paesi a regime totalitario e fascista. Settimo, bisogna essere coscienti che ogniqualvolta gli interessi nazionali, compresi gli interessi della classe operaia nazionale, vengono contrapposti alla solidarietà internazionale, sono gli interessi del capitale che vengono favoriti, non quelli della classe operaia. Ottavo, essere coscienti che, anche se la solidarietà internazionale non è un sostituto della forza sindacale nelle fabbriche, negli uffici, ecc. essa può tuttavia rafforzare la forza sindacale locale. In breve, bisogna fare in modo che la solidarietà internazionale diventi parte integrale della vita sindacale nazionale, bisogna essere coscienti della sua funzione positiva per il sindacato nazionale, ed essere coscienti che questa è l’unica risposta all’attacco padronale su piano internazionale. Questo è il nuovo compito del sindacato nell’era della ‘globalizzazione’. BIBLIOGRAFIABellofiore, R. (1998), Il Lavoro di Domani, Franco Serantini, Pisa Carchedi, G. (1998), L’Euro e il movimento operaio europeo, in Bellofiore (1998) A.Danford, M.Richardson, M.Upchurch, (2002), ‘New Unionism’, organising and partnership, Capital and Class, N.76, Spring European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, (2001a), Employment through flexibility: squaring the circle European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, (2001b), Third European Survey on Working Conditions European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, (2001c), A trade union guide to globalization European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, (2001d), Working Conditions in Atypical Work European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, (2002), Quality of work and employment in Europe: issues and challenges, Foundation paper No.1, February European Industrial Relations On Line (2001), Labour costs - Annual update, 2001. European Industrial Relations Observatory on-line, (2001a), working times developments - annual update 2001. European Industrial Relations Observatory on-line (2001b), Wage Policy and EMU Eurostat, Economic portrait of the European Union 2001, [1] Per di più, il capitale reagirebbe ad un aumento assoluto del monte salari tentando di aumentare la intensità del lavoro. [2] I salari reali sono definiti come l’incremento percentuale annuo dei salari nominali corretti per l’inflazione. La produttività del lavoro è definita come l’incremento percentuale annuo del PIL ai prezzi di mercato del 1995.
|