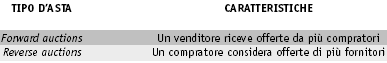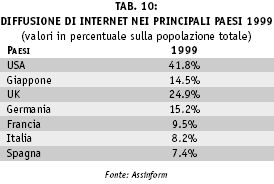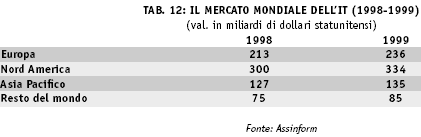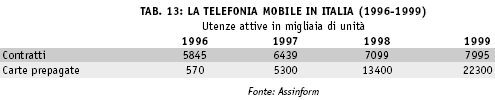![]()
Rubrica
Società e processi immateriali
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Maria Rosaria Del Ciello Collaboratrice e ricercatrice rivista “Proteo”
Soggettività sociale e televisione: un processo immateriale Verso una comunicazione politica egemonizzata Il ruolo della risorsa informazione nello sviluppo della new economy La telematica come nuovo linguaggio mitico
Tutti gli articoli della rubrica "Società e processi immateriali"(in tutti i numeri di Proteo)
|
Ed infatti, la comunicazione, secondo il principio della flessibilità sociale, deve perseguire obiettivi mirati a controllare i lavoratori anche attraverso sollecitazioni ed incentivi economici con il fine di concertare le decisioni a partire dalla conoscenza delle opinioni dei lavoratori. Il principio della flessibilità sociale e del lavoro viene ad essere applicato quindi come sistema del controllo sociale [1]. 5. ConclusioniCosì l’informazione, più spesso in forma digitale, è la materia prima della “nuova economia”. L’energia indispensabile per trasformare questa materia prima non è l’elettricità, ma l’elettronica, mentre le reti digitali (tra le quali Internet svolge un ruolo determinante) costituiscono il mezzo di trasporto per portare a destinazione l’informazione sotto tutte le sue forme, ivi compresi il suono e l’immagine. La concorrenza diventa universale, in particolare su Internet. La “nuova economia” è globale, privilegia gli oggetti immateriali, come per esempio l’informazione, ed è strettamente interconnessa. Che l’ideologia della new economy provenga dagli Stati Uniti non deve stupire poichè gli Stati Uniti sono stati il fulcro ed il motore della globalizzazione finanziaria che, nella società americana ha causato l’indebolimento dell’apparato industriale e la sua subordinazione ai settori più strettamente collegati ai processi finanziari. L’indebolimento dell’industria ha prodotto una caduta nei posti di lavoro ben pagati in favore di occupazioni precarie. Strutturalmente la new economy esiste da molto tempo, da almeno trent’anni. I prodotti dell’information technology hanno costituito la componente più dinamica degli investimenti dalla metà degli anni Sessanta. Informatica, globalizzazione e flessibilità sarebbero quindi al centro di una terza rivoluzione industriale: i sistemi in rete sono capaci di produrre in funzione delle esigenze particolari di ogni cliente e moltiplicano quindi il mercato potenziale. Così facendo, però, si perde di vista che ciò che c’è di nuovo nelle tecnologie dell’informazione non è la tecnologia digitale quanto la trasformazione in merce di tutta una parte dell’attività umana: la comunicazione. L’affermazione della telematica e dei mezzi di comunicazione sempre più sofisticati ha provocato una decisa evoluzione del concetto di comunicazione: non più semplice processo di trasmissione di informazioni a prevalente carattere commerciale, ma come capacità organizzativa di acquisire consenso nel sociale (...) capace di finalizzare le conoscenze e i comportamenti organizzativi al fine di trasmettere l’idea-azienda nell’intera società [2]. Se è vero però che “ogni modello di impresa è il frutto delle condizioni economiche della storia, delle tradizioni e della cultura del paese nel quale agisce” [3], allora il modello di impresa che si sta sempre più affermando nel nostro paese sta anche cercando di smentire questa affermazione. Quello che infatti caratterizza sempre più il sistema imprenditoriale emergente è una massiccia imitazione di modelli oltreoceano: precarietà del lavoro subordinato, azionariato diffuso, prevalenza di attività finanziaria speculativa a danno del fattore produttivo lavoro. Si afferma cioè sempre più quel liberismo selvaggio proprio del modello capitalistico anglosassone, in cui dominano l’aggressività, l’individualismo, e nel quale si vorrebbe far prevalere sempre più la finanziarizzazione dell’economia, legata alle logiche dei grossi potentati finanziari internazionali [4]. In questa situazione, fuori da ogni possibile controllo degli stati, il capitale precisa la sua funzione matura e, dall’integrazione globale semplice, dovuta a rapporti produttivi tradizionali meramente internazionalizzati, passa ad una integrazione globale complessa, dove i sistemi produttivi, commerciali, contabili e finanziari, si diffondono fino a quando l’azienda può essere definita come virtuale. La società madre, in questo scenario, affidando la produzione a filiali e subcontrattisti in diversi paesi, sfrutta razionalmente a proprio vantaggio le differenze fra leggi e condizioni locali per l’investimento, la produzione, i servizi. Si tratta, in sostanza, di quella divisione del lavoro un tempo esistente all’interno della singola impresa e che oggi è invece proiettata all’esterno. Tali dinamiche globali non rappresentano altro che la lotta del capitale contro la caduta del saggio di profitto, causata da fattori quali l’aumento del grado di sfruttamento della forza-lavoro attraverso la riduzione del salario al di sotto del valore medio della forza-lavoro. L’integrazione tra telecomunicazioni e informatica è, quindi, alla base del processo di globalizzazione che caratterizza gli attuali scenari economico-sociali. Idealmente questo processo viene descritto nel seguente modo: le nuove tecnologie riducono il costo delle comunicazioni, favorendo la globalizzazione della produzione e dei mercati finanziari. Quest’ultima, a sua volta, stimola il progresso tecnologico, intensificando la concorrenza e accelerando la diffusione delle nuove tecnologie attraverso investimenti esteri diretti [5]. Tale processo, anche se di modernizzazione, ha prodotto gerarchie e diseguaglianze macroscopiche tra Nord e Sud del mondo. Resa possibile grazie ai progressi nelle tecnologie della comunicazione, all’insegna di un capitalismo divenuto un sistema mondiale privo di concorrenti, la globalizzazione tende ad accrescere l’interdipendenza tra tutte le società, alterando i confini e le distinzioni tra le società. La contiguità spaziale viene, allora, meno come criterio di regionalizzazione ed è sostituita da flussi finanziari e di informazioni tramite reti computerizzate che accentuano la contiguità temporale degli eventi prefigurando un sistema-mondo unitario. La globalizzazione che caratterizza l’economia mondiale si lega alla rivoluzione nelle comunicazioni ed indica un processo di propagazione di certe attività economiche e di certe imprese su scala globale, che non si arresta di fronte a barriere territoriali o giuridiche. E tutto ciò significa che le economie sono tutte intrecciate tra loro in un unico mercato competitivo [6]. Tale sistema non è però necessariamente omogeneo o privo di conflitti. Alla fine del XVIII secolo la macchina a vapore ha provocato la rivoluzione industriale favorendo l’ascesa del capitalismo, la nascita della classe operaia e l’espansione del colonialismo, così come oggi Internet e le autostrade della comunicazione sono vigorosi fattori di impulso e intensificazione degli scambi [7]. Tuttavia alla fine del Settecento se si affacciava un nuovo modo di produrre ricchezza, il progresso che ne conseguiva non attenuava, anzi accresceva i conflitti e le turbolenze sociali favorendo il totalitarismo e il socialismo reale: così oggi l’unificazione del mercato mondiale può produrre disastri o benefici a seconda di come viene interpretata e guidata [8]. Il sistema capitalistico globale ha creato un terreno di gioco molto irregolare. Il divario tra ricchi e poveri è sempre maggiore. Il capitalismo crea ricchezza ma non dà garanzie di rispetto della libertà, della democrazia e dello stato di diritto. Il mondo degli affari è motivato dal profitto, non è fatto per salvaguardare principi universali. Gli interessi personali non sono sufficienti neppure alla protezione del mercato stesso: i partecipanti sono in competizione per vincere e, se potessero, eliminerebbero la concorrenza. Così la libertà, la democrazia e lo stato di diritto non possono essere affidati alle forze di mercato, c’è bisogno di salvaguardie istituzionali [9]. Due sono gli aspetti più attuali della new economy: 1. La net-economy; 2. Il mercato delle telecomunicazioni 1) Net economy. Essa è tuttora in crescita ed ha trasformato lo spazio virtuale del web da spazio libero e anarchico per la diffusione delle conoscenze in piazza del mercato, anzi dei mercati, poiché molteplici sono le configurazioni che il web assume e va assumendo. Abbiamo così il semplice spazio di e-commerce, in cui si promuove la vendita di prodotti, ma anche vere e proprie “aste Internet” in cui i prezzi sono predeterminati ma dinamici, ovvero contrattati momento dopo momento. Lo scambio di informazioni attraverso un mercato elettronico centralizzato è differente dall’invio di un messaggio elettronico attraverso Internet in quanto un mercato elettronico centralizzato permette di manipolare le informazioni, catalogandole, verificandole, datandole, criptandole, insomma utilizzandole nel modo più redditizio a chi lavora in questo tipo di mercato e, molto probabilmente, a danno dei soggetti proprietari di queste informazioni. La net economy è poi rappresentata da quelli che in America si chiamano day trader, ovvero giocatori di borsa su Internet: professionisti della compravendita di azioni tramite il web che stanno facendo proseliti anche fra chi su azioni e fondi di investimento investe qualche risparmio in modo, diciamo, amatoriale. I numeri americani resi noti dalla Securities Industries Association dicono che il 18 per cento, l’8 per cento in più rispetto al 1998, degli investitori utilizza il web per fare affari mentre il 45 per cento utilizza i servizi web di società di intermediazione finanziaria. E in effetti il tempo reale che Internet assicura sembra nato per i mercati finanziari dove il minuto è già un tempo infinito e può influire in modo pesante su una transazione. D’altra parte sulla Rete si seguono le borse di tutto il mondo, le news letter finanziarie inondano di notizie le mail box ad una velocità che nessun broker o banca del mondo può garantire e soprattutto si può comprare e vendere. Un colpo di acceleratore alla velocità delle transazioni e soprattutto alla velocità delle informazioni finanziarie che rischia però di diventare incontrollabile e di portare fuori strada, perché si gioca e si scommette su un terreno virtuale, ma se si perde si perdono soldi reali, un rischio che davanti al terminale di un Pc spesso tende ad essere dimenticato [10].
E questo spiega la grossa ondata speculativa che ha caratterizzato e continua a caratterizzare l’economia di questo terzo millennio: basti pensare all’aumento dell’85,6% registrato nel 1999 dal solo Nasdaq, il mercato americano in cui sono quotate la maggior parte delle società tecnologiche: tipicamente quelle legate all’informatica ed alla comunicazione. Sappiamo però che nell’economia finanziaria esiste un particolare problema detto dell’asimmetria informativa, che si verifica quando i diversi partecipanti presenti su un mercato non hanno, e in alcuni casi non possono avere, le stesse informazioni. Il caso più importante di asimmetria informativa è quello di una banca, o altro intermediario, che può fungere da filtro informativo tra investitori e prenditori. Nelle imprese gli unici depositari di tutte le informazioni sono i “managers”, mentre le principali vittime dell’asimmetria informativa sono i titoli azionari: il relativo mercato sconta infatti l’opinione che i managers non trasmettano tutte le informazioni a loro disposizione. L’altra grande critica nei confronti della “nuova economia” riguarda i rischi che fa correre all’economia reale. Dal 1997, si è formata una vera e propria bolla speculativa in Borsa intorno alle società Internet. Queste ultime, che lungi dall’essere redditizie a volte accumulano addirittura perdite record, conoscono tuttavia dei livelli di valorizzazione notevoli in Borsa. “In generale la comunicazione finanziaria deviante assume una forte valenza informativa a carattere sociale il cui obiettivo principale è quello di coinvolgere gli strati popolari, i piccoli risparmiatori in qualità di fondamentali operatori economici che incidono sulle evoluzioni e sui mutamenti dell’assetto finanziario complessivo dell’impresa, agendo sull’andamento dei titoli emessi e dei titoli acquisiti in portafoglio in chiave utile, così al grande capitale in quella determinata fase economico-borsistica.(...) I flussi comunicazionali sono orientati quasi esclusivamente non più alla conquista di fette di mercato per la singola impresa ma ad un interesse di omologazione alla cultura e al modo di essere della società competitiva del profitto. Le aspettative borsistiche mantengono in vita la quasi totalità del commercio e-mail. Megasocietà come Amazon.com continuano ad esistere grazie a queste aspettative dato che non generano profitti dal volume delle transazioni correnti. In realtà società del tipo Amazon operano strategicamente in perdita vendendo a margini negativi o nulli. Gli ottimisti sostengono che una volta affermata la propria reputazione simili aziende potranno ristabilire i margini di profitto che, nel lungo periodo, saranno più elevati di quelli della old economy. Tale tesi non sembra convincente perché una delle caratteristiche dell’e-commerce è la mancanza di lealtà dalla parte dei clienti che possono spostarsi verso il prezzo più basso utilizzando il Web. Inoltre il prezzo Web deve essere significamente inferiore a quello dei punti fissi. 2) Mercato delle telecomunicazioni. È il mercato che sta realizzando i maggiori profitti in questi ultimi tempi, grazie anche alle prospettive del UMTS (Universal mobile telecommunications system), la terza generazione di telefonia mobile (dopo TACS e GSM) che garantirebbe una velocità di trasferimento dei dati 200 volte superiore a quella attuale. Attraverso l’applicazione di questo nuovo sistema sarà possibile, attraverso i telefoni cellulari a banda larga navigare in Internet e utilizzare la posta elettronica, collegarsi a un computer, effettuare acquisti e pagare inserendo direttamente il bancomat nel telefonino, accedere ad una serie di servizi, come tra gli altri, la visualizzazione dell’estratto di conto corrente bancario o la possibilità di seguire l’andamento delle quotazioni di borsa. L’UMTS rappresenta l’offerta convergente tra Internet e telecomunicazioni mobili, ma coinvolge investimenti molto elevati. Inoltre comporta per i Governi la vendita delle frequenze con dei costi molto elevati per utente. La tecnologia UMTS è considerata da molti strategica per l’incremento della crescita economica, ma ciò non sembra tanto realistico se è vera l’ipotesi che l’UMTS avrebbe un target di clientela definito e limitato, in quanto caratterizzato da necessità sofisticate. Se poi pensiamo che l’UMTS è la diretta applicazione di Internet alla telefonia mobile e a quanto sia ancora poco sviluppato l’utilizzo di Internet da parte della popolazione nel suo complesso, questo farebbe pensare che anche la tecnologia UMTS, a dispetto degli enormi investimenti che sta smuovendo, non possa avere degli sviluppi considerevoli, o perlomeno non così incisivi sulla crescita economica. Forse il dibattito sulla nuova economia dovrebbe piuttosto trasformarsi in un dibattito sullo scontro tra il Capitale ed il Lavoro. Nel contesto delle nuove tecnologie, la riapertura della discussione dei rapporti tra capitale e lavoro dovrebbe avvenire all’interno di un quadro analitico in cui domina il concetto di immiserizing growth. Nel passato tale concetto veniva applicato ai paesi in via di sviluppo. Tuttavia l’evoluzione socio-economica degli Stati Uniti mostra che l’immiserizing growth è al cuore dell’attuale dinamica economica fondata sulla doppia flessibilità del lavoro imposta alla grande maggioranza delle famiglie americane. Inoltre la velocità di propagazione della “Net economy” è ben lungi dall’essere la stessa in tutto il mondo. Mentre i paesi del Nord investono miliardi di dollari in infrastrutture (fibre ottiche, telefonia mobile, generalizzazioni della strumentazione informatica nelle scuole e nelle amministrazioni ecc.) quelli del Sud, per mancanza di soldi, restano al traino. Dopo aver mancato la rivoluzione industriale, rischiano di perdere ogni possibilità di agganciarsi all’economia mondiale.
Scriveva Owen più di un secolo fa: ”È opinione diffusa tra i teorici dell’economia che l’uomo può provvedere a se stesso meglio e in modo più vantaggioso quando tutto è lasciato alla sua iniziativa privata, quando cioè è in concorrenza con i suoi simili (...). Tuttavia, quando finalmente conosceranno se stessi e scopriranno i meravigliosi effetti che la cooperazione e l’unione possono produrre, gli uomini riconosceranno che l’attuale organizzazione della società è la più antisociale, la più impolitica e irrazionale che si possa immaginare” [11]. [1] Martufi R., Vasapollo L., Comunicazione deviante. L’impero del capitale sulla comunicazione, MediaPrint Edizioni, 2000. [2] Martufi R., Vasapollo L., op. cit. [3] Martufi R., Vasapollo L., op. cit. [4] Martufi R., Vasapollo L., op. cit. [5] Woodell Pam, “Economia Globale”, The Economist, settembre, 1996. [6] Bonalumi Gilberto, “Le incognite della democrazia globale”, Politica Internazionale, n.3/1995. [7] Ramonet Ignacio, “La nuova economia”, Le Monde Diplomatique, marzo 2000. [8] Vertone Saverio, “Fine della politica? Non se ne parla nemmeno”, Il Sole 24 Ore, 21/3/2000. [9] George Soros, “Se il capitalismo è contro la democrazia”, la Repubblica, 2 agosto 2000). [10] Owen Robert, “Rapporto alla Contea di Lanark”, 1820. [11] Owen Robert, “Rapporto alla Contea di Lanark”, 1820.
|