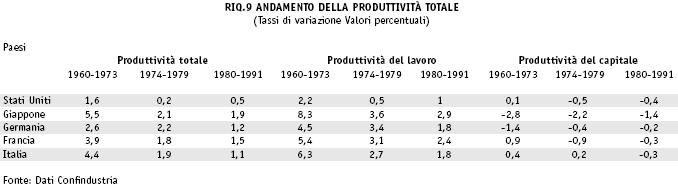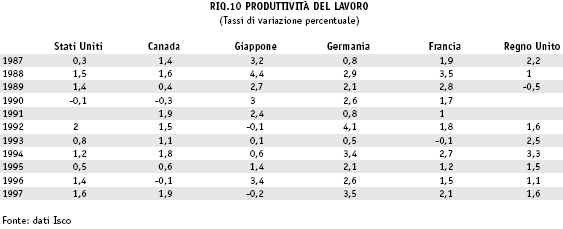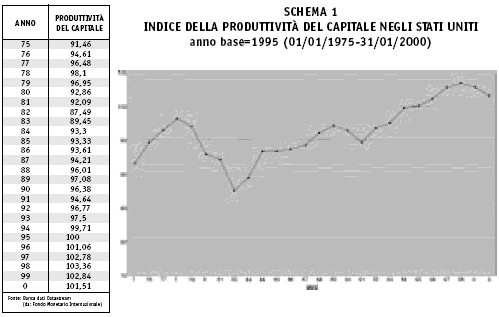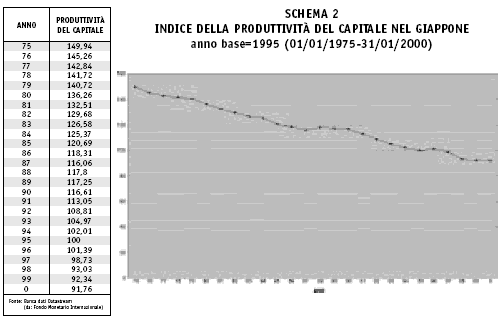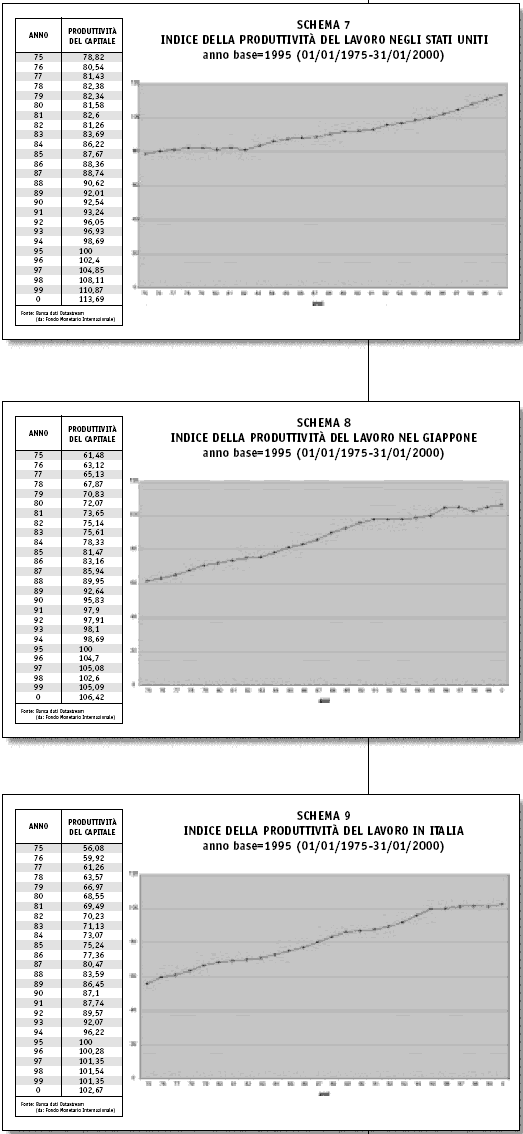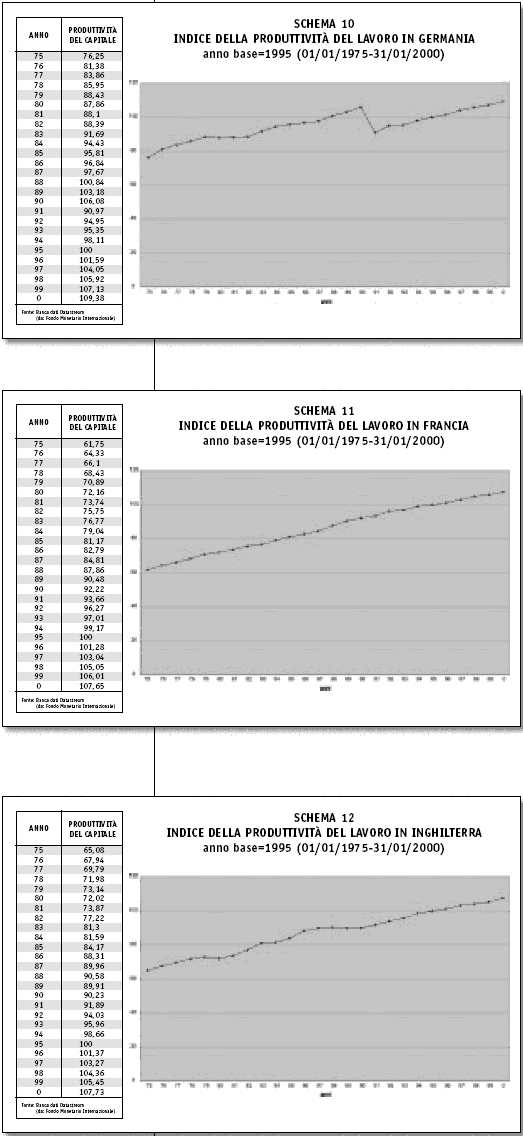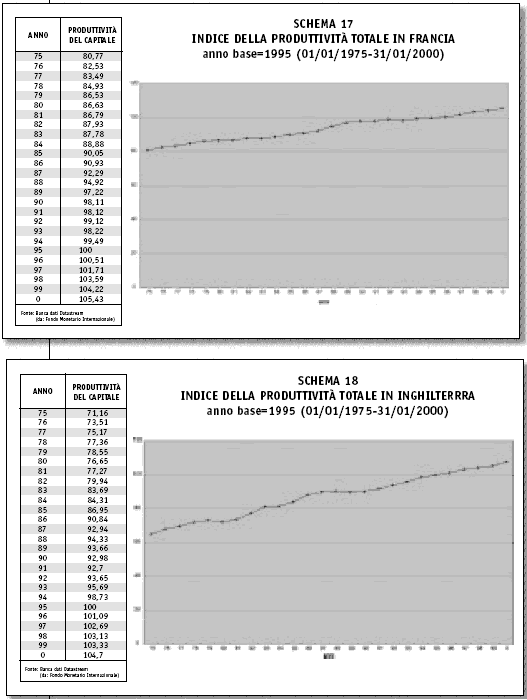![]()
Rubrica
L’analisi-inchiesta
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Luciano Vasapollo Docente di Economia Aziendale, Fac. di Scienze Statistiche, Università’ “La Sapienza”, Roma; Direttore Responsabile Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali (CESTES) - Proteo. Rita Martufi Consulente ricercatrice socio-economica; membro del Comitato Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico Sociali (CESTES) - PROTEO
Ristrutturazione capitalistica
Le tendenze macroeconomiche del processo di ristrutturazione capitalistica
Tutti gli articoli della rubrica: analisi-inchiesta(in tutti i numeri di Proteo)
|
È interessante confrontare di seguito l’andamento della produttività correlata ai tassi di variazione degli investimenti. In sintesi si può evidenziare che i processi di ristrutturazione che hanno caratterizzato la maggior parte dei paesi europei hanno provocato, non solo un brusco abbassamento dell’occupazione ma anche un sensibile incremento della produttività del lavoro e del capitale per addetto. In Germania, Francia e Italia, pur essendosi ridotto il livello degli investimenti, si mantiene un discreto grado di utilizzo degli impianti; in Gran Bretagna il decremento degli investimenti è stato spesso accompagnato da buoni livelli di crescita della produttività del capitale e quella totale. In Giappone, la produttività del lavoro si mantiene alta, contrariamente a quella del capitale che è diminuita del 4.4% a fronte di frequenti contrazioni degli investimenti. Gli Stati Uniti, invece, hanno una dinamica diversa, poiché non vi sono stati segnali significativi di mutamento nell’andamento della produttività del capitale e del lavoro. Come si può vedere dal Riquadro 9 in tutti i paesi presi in esame la produttività totale del settore privato ha avuto, negli anni ’60, tassi di variazione elevati, che però sono diminuiti tra il 1974 e il 1979, e anche tra il 1980-1991. Per quanto concerne, in specifico, la produttività del lavoro e del capitale, hanno fatto registrare andamenti fra loro dissimili: la prima si è incrementata molto velocemente nell’Unione Europea e in Giappone negli anni’60, per poi frenare la sua crescita solo in alcune fasi e comunque i processi di ristrutturazione hanno sempre avuto riflessi significativi sulla produttività del lavoro stesso; la produttività del capitale, al contrario, ha mostrato, in tutti i paesi, tendenze altalenanti con tassi di variazione per alcuni periodi negativi, risultati dovuti all’andamento degli investimenti e in genere all’andamento di molti parametri macroeconomici connessi all’andamento del fattore capitale, dimostrando comunque che i processi di ristrutturazione post-fordisti sono caratterizzati da sempre più intensi livelli di sfruttamento della forza-lavoro con diverse connotazioni (aumenti dei ritmi e dell’intensità di lavoro, ecc.).
Per concludere anche dai seguenti dati ISCO, fino al 1997, (Riq.10) risulta che la produttività del lavoro ha quasi sempre avuto tassi di variazione significativamente alti, non solo nel nostro Paese, ma anche in Germania, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, e anche in Francia, mentre ha un andamento più altalenante in Giappone.
Invece la produttività del capitale ha fatto registrare quasi sempre un andamento molto simile a quello del prodotto lordo, il quale ha avuto negli ultimi anni tassi di variazione annuali spesso in diminuzione, rispetto ai cicli precedenti, nell’Europa continentale e in Giappone, contrariamente a quanto è avvenuto negli Usa e in Gran Bretagna dove è risultato quasi sempre in netta crescita. Se, infine si osservano i Riquadri successivi elaborati su Banca dati Datastream (da: Fondo Monetario Internazionale e prendendo come anno base il 1995=100) si hanno delle informazioni aggiuntive rispetto ai riquadri precedenti in cui si consideravano il valore annuale dei diversi indici di produttività e i tassi percentuali di variazione. Considerando la produttività del capitale calcolata tra il 1974 e gli inizi del 2000, come anno base il 1995, dagli Schemi da 1 a 6 si può notare che quella del Giappone è drasticamente diminuita negli anni, passando da un indice pari a 149,94 nel 1974 a 91,76 nel 2000. Sono invece aumentate la produttività dell’Inghilterra e degli Stati Uniti che avevano negli anni ’70 e ’80 una bassa produttività del capitale; risultano avere un andamento molto simile, invece, la produttività di Italia, Francia e Germania con flessioni sempre contenute; infatti la produttività del capitale dal 1975 al 1995 è stata sempre non molto superiore al 100; mentre a partire dall’anno base 1995 Italia e Germania hanno subito una leggera flessione attestandosi sotto tale valore, la Francia ha avuto una leggera crescita superiore al 100. È interessante notare che, a partire dai primi anni ’90, tutti i paesi considerati (sia quelli che negli anni ’70 e ’80 avevano una bassa produttività del capitale sia quelli che si discostavano molto in senso positivo dal valore dell’anno base) si allineano a valori molto vicini a quelli del 1995 (anno base) stringendo molto il campo dei precedenti differenziali positivi o negativi rispetto ai valori base del ’95. Se si considera che proprio gli USA e l’Inghilterra avevano i valori di partenza molto bassi rispetto all’anno base, mentre ad esempio il Giappone, Francia e Germania quelli più alti, si intuisce allora il processo di allineamento dal capitalismo anglosassone al modello renano-nipponico. L’indice della produttività del lavoro, calcolato con anno base il 1995 (vedi Schemi da 7 a 12), mostra un tendenziale forte aumento in tutti i paesi considerati; in particolare, l’aumento risulta maggiore tra il 75 e il 95, dopo tale data l’incremento è meno accentuato ma costante. La Germania ha subito tra il 1990 e il 1991 una brusca diminuzione, infatti l’indice è passato da 106,08 a 90,97, probabilmente anche a causa del riallineamento dei dati contabili e del riassorbimento della struttura economico-produttiva dell’ex Germania Est. A partire dal 1995 tutti i paesi si attestano oltre il 100, in particolare gli Stati Uniti che nel primo mese del 2000 registrano un indice pari a 113,69, la Germania a 109,38, Inghilterra, Francia e Giappone intorno a 107, mentre l’Italia evidenzia un 102,67. Tale costante e accelerato incremento della produttività del lavoro dimostra chiaramente la centralità e il ruolo della forza lavoro rispetto al modo di produzione capitalistico che, seppur mutando fase e modalità dell’accumulazione, seppur imponga nuovi modelli di produzione e conseguenti diverse forme di presentarsi del lavoro (dal lavoro fordista, alle mille facce del lavoro atipico, flessibile e precario), è sempre e comunque basato sull’estorsione di pluslavoro e plusvalore a partire dallo sfruttamento di un, per quanto nuovo, ma sempre e comunque lavoro salariato e subordinato.
Dagli Schemi da 13 a 18 si evidenzia che l’indice della produttività totale, calcolato con anno base 1995, mostra un tendenziale aumento in tutti i paesi, in particolare l’aumento risulta maggiore tra il 1974 e il 1995; dopo tale data l’incremento è meno accentuato ma costante. La Germania ha subito tra il 1990 e il 1991 una brusca diminuzione, infatti l’indice è passato da 105,61 a 96,1 a causa probabilmente dei processi economici strutturali legati alla riunificazione con la ex Germania Est. A partire dal 1995 tutti i paesi si attestano oltre il 100, in particolare gli Stati Uniti che nel primo mese del 2000 registrano un indice pari a 109,7 e l’Italia 107,91; mentre per il Giappone risulta un valore di 100,02 nel 1998 e di 102,47 nel 2000 e Germania, Francia e Inghilterra si hanno valori intorno a 105 a Gennaio 2000.
Risulta, quindi, infine che anche l’indice di produttività totale, così come quello del lavoro, ha mostrato nel periodo 1975-2000 in tutti i paesi considerati, un andamento in continua e forte crescita, ciò a dimostrare che i forti incrementi della produttività del lavoro determinano il trend crescente dell’andamento dell’indice di produttività totale “compensando” ampiamente l’andamento a volte altalenante della produttività del capitale. È sempre nello sfruttamento del lavoro la chiave di lettura del modo di produzione capitalistico. Ma tutti gli incrementi di produttività non sono stati correttamente redistribuiti, anzi come si è visto nel corso dell’analisi-inchiesta sono andati quasi esclusivamente a remunerare il fattore capitale, sotto forma di un profitto non reinvestito produttivamente ma finito quasi totalmente nella “bolla finanziaria speculativa” a facile guadagno ma non capace di creare nuova e reale occupazione. Al risanamento finanziario pubblico e reddituale privato non è corrisposto un adeguato irrobustimento degli investimenti in ricerca e sviluppo e di innovazione e tale processo è stato caratterizzato da un forte incremento del progresso tecnologico ma che ha avuto come risvolto negativo una continua diminuzione del livello di occupazione e una sua precarizzazione con l’unico scopo di aumentare i profitti comprimendo i costi del lavoro, il salario sociale complessivo come insieme di salario diretto e indiretto. Il divario tra produzione (industria, servizi, attività pubbliche) ed esigenze occupazionali è stato riformulato solo nell’ottica di uno sviluppo della performance di profitto, sempre più spesso a connotati finanziari, nel quale la valorizzazione socio-culturale delle risorse umane ha rappresentato solo un costo, e non una grande occasione per incrementare la domanda singola e comunitaria, anche di sviluppo ad alta sostenibilità socio-ambientale favorendo le attività basate su funzioni di incremento di cultura, di solidarietà e di civiltà. Ciò perché anche lo Stato ha dismesso la sua funzione di regolatore del conflitto sociale e ha fatto proprie le più rigide politiche di efficienza d’impresa, imprese che da molti anni adottano la regola che i guadagni di produttività ottenuti grazie all’introduzione di tecnologie sempre più avanzate, vengono ripartiti esclusivamente al fattore capitale, cioè agli azionisti e ai manager, sotto forma di dividendi, aumenti di investimenti finanziari o benefici di altra natura. Questo stato di cose ha provocato, e provoca, la mancanza di redistribuzione degli incrementi di produttività ai salari diretti e indiretti dei lavoratori, i quali rivendicano il diritto di ricevere in forme remunerative dirette o indirette tali incrementi attraverso retribuzioni più elevate, o in alternativa con riduzioni dell’orario di lavoro, aumenti dell’occupazione, miglioramento dello Stato sociale, cioè forme di redistribuzione di ricchezza agli occupati e disoccupati di reddito e di ricchezza; nell’analisi-inchiesta finora condotta si è potuto verificare che tutto ciò non è avvenuto, che la remunerazione del fattore capitale si è rafforzata ai danni dei salari e del fattore lavoro in generale.
|