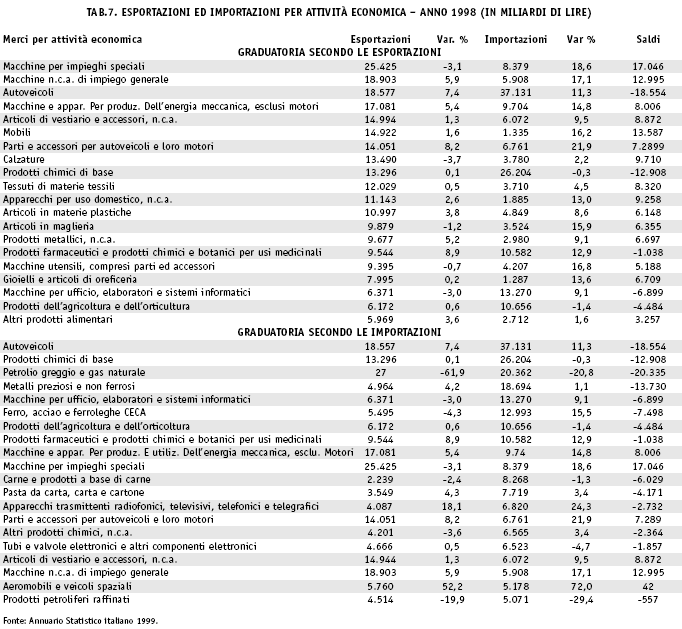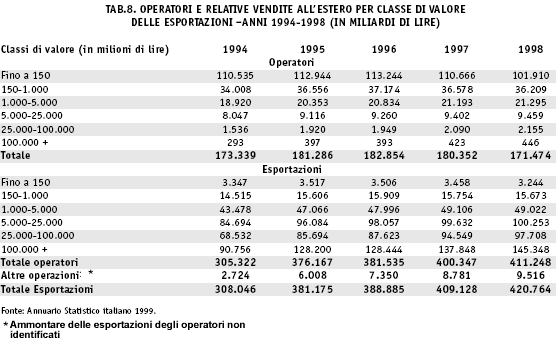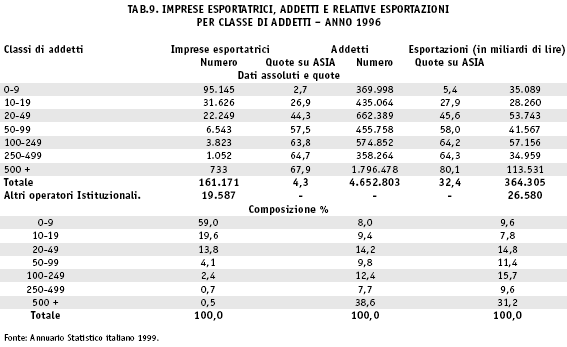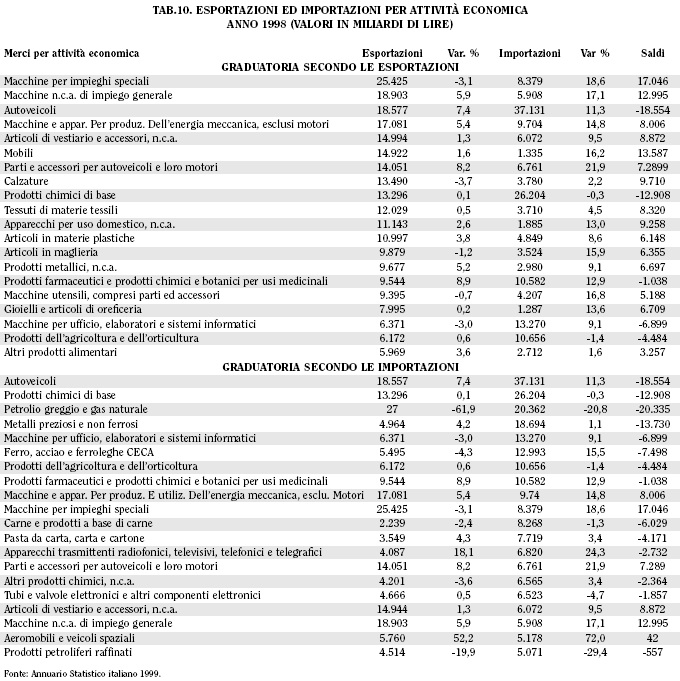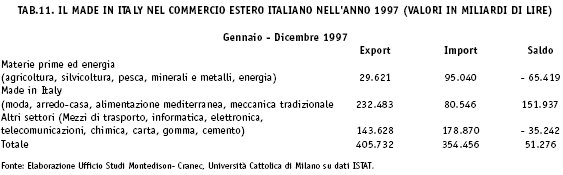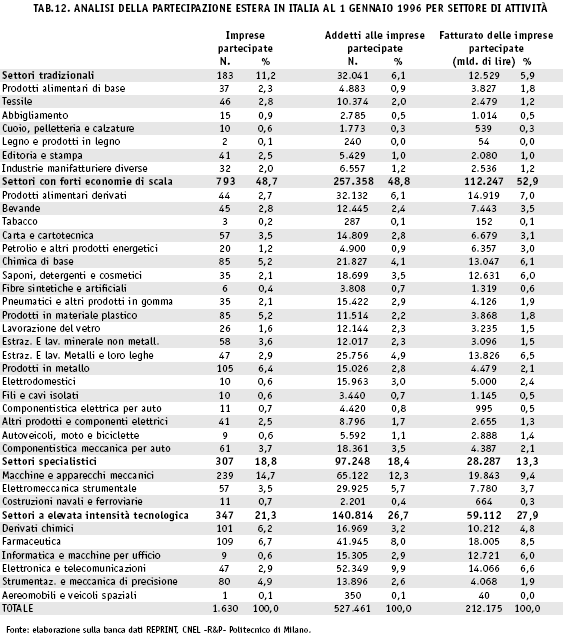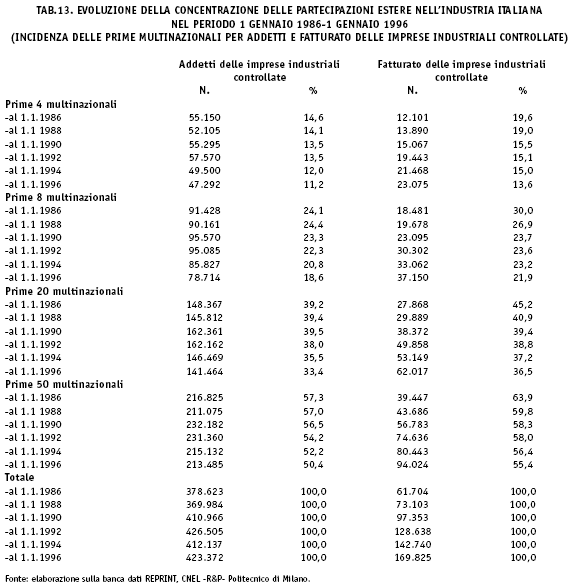![]()
Rubrica
3. Eurobang
Copyright - Gli articoli si possono diffondere liberamente citandone la fonte e inserendo un link all'articolo
Luciano Vasapollo Docente di Economia Aziendale, Fac. di Scienze Statistiche, Università’ “La Sapienza”, Roma; Direttore Responsabile Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico-Sociali (CESTES) - Proteo. Rita Martufi Consulente ricercatrice socio-economica; membro del Comitato Scientifico del Centro Studi Trasformazioni Economico Sociali (CESTES) - PROTEO
Sinistra plurale e ricompattamento del capitale in Francia: 1997- 2000 Il nuovo paradigma imprenditoriale nell’Europa del capitale. Il ruolo delle PMI
Tutti gli articoli della rubrica "Eurobang"(in tutti i numeri di Proteo)
|
3. In pratica, a livello di macrosettore, l’Italia presenta uno scarso peso dell’occupazione delle grandi imprese del settore industriale e, per contro, uno estremamente elevato delle piccolissime imprese dei servizi. In questo contesto, è rilevante il posizionamento delle imprese italiane all’interno dell’area UE, il quale può essere valutato attraverso l’analisi dei dati di produzione e di commercio estero, sulla base di un insieme d’indicatori strutturali e di redditività desunti dai bilanci delle imprese [1].
L’orientamento verso i mercati esteri del sistema della piccola e media impresa italiana rappresenta uno degli indicatori ai fini della valutazione del grado di integrazione nei processi innescati dalla competizione globale dell’economia. I principali mercati di sbocco delle esportazioni nel 1998, sono stati la Germania, con una crescita del 3% rispetto all’anno precedente, la Francia (+7,2%) e gli Stati Uniti d’America (+12%). Le principali attività economiche, significativi saldi attivi si riscontrano per le macchine e gli apparecchi meccanici (+56.016 miliardi), i prodotti delle industrie tessili e dell’abbigliamento (+26.570 miliardi) e gli altri prodotti dell’industria manifatturiera (+21.406 miliardi). I principali raggruppamenti di prodotti esportati sono stati le macchine per impieghi speciali, le macchine di impiego generale (+5.9%) e gli autoveicoli (+7,4%). I principali mercati di sbocco per le nostre esportazioni sono costituiti dall’Unione Europea (il 56,4%), dall’America Settentrionale (il 9,4%) e dall’Europa centro-orientale (7,9%) mentre dal lato delle esportazioni, le aree di maggior interesse sono l’Unione Europea (61,6%), l’Asia orientale (7,8%) e l’Europa centro-orientale (6,9%). I flussi in regime temporaneo danno conto di alcune importanti forme di scambio che contraddistinguono il sistema della sub-fornitura internazionale e forniscono indicazioni sui processi di delocalizzazione all’estero delle imprese. Le reimportazioni rappresentano, infatti, nel 1998, l’1,5% del valore complessivo delle importazioni, con un incremento di oltre il 23% rispetto all’anno precedente. Le principali aree geografiche di provenienza dei flussi sono l’Europa centro orientale (41,2% sul totale) e l’unione Europea (36,9%). Oltre il 40% degli operatori esporta merci verso un unico mercato e meno del 15% opera su oltre dieci mercati. Risulta evidente la presenza diffusa degli operatori nelle principali aree di scambio internazionale. La quota delle imprese esportatrici sul totale delle imprese attive cresce significativamente all’aumentare della dimensione di impresa, (espressa in termini di addetti). 4. Distretti industriali europei e Italia multinazionale1. Un cenno meritano a questo punto anche i cosiddetti distretti industriali europei. A questo proposito si distinguono, ai fini di una politica economica, zone residenziali e zone produttive; queste ultime sono proposte come una sintesi delle interrelazioni tra struttura produttiva e territoriale in cui dall’analisi ed osservazione della realtà si evidenziano quelle di specializzazioni produttive che danno origine ai distretti anche a carattere europeo internazionale. Anche per la maggior parte degli studi della fine anni ’80 e inizio ’90 l’obiettivo fondamentale è stato quello di individuare le dinamiche localizzative del modello di sviluppo dei singoli paesi; e spesso prevale una forzata interpretazione che consiste nel porre i presupposti per un analisi economica dello sviluppo regionale al fine del riconoscimento dei Distretti Industriali Marschalliani (DIM) sul territorio nazionale [2] anche se poi la dimensione del distretto, in funzione delle esternalizzazioni e dell’intensificarsi dei processi di delocalizzazione, assume sempre più spesso caratteri internazionali. 2. È in tale chiave che va letta la grande importanza che viene attribuita al nuovo concetto di distretto industriale internazionale e in particolare a centralità europea, il quale ha una forte specificità, una propria dimensione socio-economico e territoriale, definita in funzione delle relazioni di coercizione comportamentale complessiva che si instaurano tra imprese e comunità locale del paese (per esempio le relazioni fra Italia ed Europa centro-orientale) dove più si effettuano IDE, e una specifica forzata capacità autocontenitiva in relazione a domanda e offerta di lavoro realizzata tramite marginalizzazione, precarizzazione ed espulsione dei soggetti economici e produttivi non compatibili. Sempre secondo tale interpretazione socio-economica vanno analizzate le trasformazioni tecnologico-produttive che caratterizzano alcune realtà territoriali, determinando la crescita d’importanza di sistemi reticolari, in ambito europeo e anche internazionale, i quali si configurano come reti territoriali che si formano intorno a grandi imprese con forti connotazioni locali e reti risultanti dalla deverticalizzazione congiunta di grandi imprese produttive in ambiti locali e con forti connotati a specializzazione produttiva locale [3]. Se si analizza il concetto di internazionalizzazione riferito ai distretti industriali europei va ricordato che "una prima forme di internazionalizzazione dei distretti industriali è quella che vede il decentramento all’estero di alcune fasi intermedie del distretto, malgrado fasi terminali per le singole imprese. In questo caso si attua un decentramento internazionale di una fase produttiva, attraverso la scomparsa dell’offerta locale, e delle relative imprese, di quei prodotti di fase che sono stati decentrati. Il bene intermedio prodotto all’estero può ritornare alla produzione del distretto, andando a ricomporre l’intero processo produttivo, od essere destinato ad una distribuzione commerciale, interna o esterna al distretto o, addirittura, essere collocato sul mercato esterno dei prodotti di fase [4]". 3. In Italia è la forte presenza di piccole e medie imprese con una specializzazione flessibile a rendere il mercato in grado di adattarsi alle mutevoli oscillazioni della domanda. I bassi costi dell’organizzazione e relativamente quelli del lavoro, consentono alle piccole imprese di immettere sul mercato sempre nuovi prodotti anche se deve essere ridotto anche il “costo degli errori e dell’uscita dal mercato. Ciò è reso possibile dalla protezione offerta dalla famiglia, dato che il reddito familiare è per molti piccoli imprenditori l’unità entro cui si compensano i guadagni e le perdite; dall’alta propensione al risparmio, a cui le piccole imprese possono attingere anziché ricorrere al mercato dei capitali; e dall’assenza di investimento in capitale umano, visto che le competenze (e talvolta le attrezzature) vengono per lo più acquisite in una precedente posizione di lavoro dipendente, a partire dalla quale si prova a <mettersi in proprio> [5]”. Le medie imprese invece si richiamano di più alla tipologia di quelle tedesche o a quelle francesi. In Italia, si è detto, sono presenti anche un vasto numero di piccole e medie imprese che soprattutto negli ultimi anni stanno sviluppando sempre di più la dimensione e nella dimensione del distretto trasnazionale con centralità europea. Inoltre in Italia i tassi di “natalità di nuove imprese” sono (in apparenza) alti in quasi tutti i settori, in quanto presentano valori che raggiungono spesso il 10%; anche i tassi di mortalità, però, sono elevati e solo di poco inferiori a quelli di natalità; questo dimostra che vi è un alto processo di turnover che risulta però essere limitato solo alle piccole imprese. Infatti a fronte di una facile nascita di nuove piccole imprese vi è la scarsa possibilità per queste aziende di sopravvivere oltre il terzo anno. Nel nostro Paese si viene a realizzare in sostanza ad una forma di imprenditoria di élite tipica delle grandi aziende, un’imprenditoria della piccola e media impresa ed infine all’imprenditoria assistita. Questa situazione fa risaltare lo storico problema delle “tre italie imprenditoriali”, in quanto gli imprenditori d’élite sono concentrati nell’Italia settentrionale, al centro troviamo un tipo di imprenditorialità diffusa mentre al sud si trova il cosiddetto “imprenditore assistito” legato al sistema politico. Va segnalato che il Censis nel 1997 ha calcolato in Italia oltre 200 distretti industriali con più di 120 miliardi di fatturato ed oltre 2.200.000 addetti che rappresentano il 42% dell’intera occupazione manifatturiera italiana, distretti che ormai delocalizzano la produzione in particolare nel centro-est europeo. I distretti industriali italiani proiettati in Europa, e quindi a carattere internazionale, operano per la maggior parte nel campo del cosiddetto "made in Italy" che interessa e riguarda settori che agiscono nelle aree moda, meccanica collegata, arredo-casa, alimentazione mediterranea e tempo libero [6]. Vi sono distretti conosciuti, che vanno assumendo anche carattere internazionale, come ad esempio Prato, Como, Biella ed altri che pur essendo molto piccoli hanno creato una loro nicchia particolare di mercato e che sono ormai conosciuti in tutto il mondo (ad esempio il distretto di Bergamo per i bottoni, o quello a Lecco delle forbici). Ed ancora: è importante il distretto delle macchine per imballaggio a Bologna che conta più di 200 aziende con oltre 13.000 addetti e più di 3.000 miliardi di fatturato; il distretto di Mantova (Castel Goffredo) con la sua produzione di calze femminili raccoglie circa 300 aziende ed occupa tra i 7.000 e gli 8.000 addetti [7]. Il Sud si distingue per il distretto di Bari e Matera con più di 250 aziende e più di 6.000 addetti [8]. Va ricordato che i distretti industriali hanno creato occupazione in questi ultimi anni molto di più della grande industria che invece ha registrato una diminuzione generale degli occupati. Le varie rilevazioni ISTAT evidenziano che il Made in Italy, in particolare quello realizzato nei distretti internazionali, è formato soprattutto da piccole e medie imprese; più del 30% dell’occupazione del Made in Italy è raggruppato in aziende con meno di 10 lavoratori; le aziende con lavoratori da 10 a 49 raccolgono quasi il 35% dell’occupazione made in Italy e le aziende con addetti da 50 a 199 concentrano il 18% degli addetti. In totale circa l’85% dei lavoratori del made in Italy è raggruppato nelle piccole e medie imprese [9]. 4. In base al riferimento che fa l’ISTAT dei 236 gruppi merceologici che delimitano il commercio estero e considerato il 1995 come anno base, vengono considerati come facenti parte del Made in Italy, che soprattutto si sviluppa nei nostri distretti a carattere nazionale, i gruppi merceologici appartenenti ali settori sopra citati (moda, meccanica collegata, arredo-casa, alimentazione mediterranea e tempo libero) e che nel 1995 abbiano presentato esportazioni più alte di 1000 miliardi di lire. In questo modo l’ISTAT ha indicato 51 gruppi merceologici facenti parte del "Made in Italy" (di cui 9 gruppi merceologici alimentari, 20 gruppi merceologici di "Moda", 5 di "arredo-casa", 15 di meccanica tradizionale, 2 merceologici residuali. La Tab.11 mostra come il "Made in Italy" abbia influenzato positivamente il commercio estero italiano; nel 1997 infatti a fronte di un saldo negativo per l’import-export del settore materie prime ed energia ed un saldo ancora negativo per altri settori (mezzi di trasporto, informatica, ecc.) il settore del Made in Italy ha presentato un saldo molto positivo in grado di garantire alla bilancia commerciale italiana un saldo finale positivo (cfr. Tab.11) [10].
Ovviamente vi sono anche nel Made in Italy prodotti che vanno molto più degli altri; ad esempio nel 1996 nel nostro Paese si è avuto un alto attivo commerciale mondiale in più di 20 prodotti quali la lana, calze, maglioni, pelli conciate, calzature, mobili, cucine, macchine per lavorare il legno ecc. [11] 5. È chiaro comunque che il processo di competizione globale nell’internazionalizzazione produttiva che interessa ormai gran parte delle imprese nei sistemi di capitalismo occidentale rende necessario anche per le piccole e medie imprese italiane un adeguamento; in questo senso gli attuali distretti tenderanno a trasformarsi da "reti locali" a "reti che varcano i confini nazionali" con un sistema sempre più efficiente di flessibilità organizzata tendente a ridurre i costi per poter competere con le grandi imprese multinazionali per poter essere in grado di scegliere dove e cosa produrre in base al costo delle materie prime ecc., ma soprattutto continuando a delocalizzare in funzione dei costi del lavoro, della deregolamentazione, flessibilità e precarizzazione del mercato del lavoro. Analizzando i settori dell’investimento estero si rileva una forte predominanza dei settori con forti economie di scala che raggiungono il 48,7% del totale (con 793 imprese partecipate); seguono i settori ad alta intensità tecnologica con il 21,3% (347 imprese), i settori specialistici con il 18,8% (307 imprese) ed infine i settori tradizionali con l’11,2% (183 imprese). (Cfr. Tab.12) La tabella 13 che nel nostro Paese la presenza estera si caratterizza per un insieme molto solido di gruppi multinazionali e comunque i primi quattro gruppi multinazionali che investono in Italia sono l’11,2% del totale per addetti e il 13,6% per fatturato, come meglio si può vedere da un’attenta lettura delle Tabb. successive. [1] I valori di tali indicatori, riportati nelle tabelle seguenti, sono espressi in percentuale. [2] Il distretto industriale è identificato da Marshall come “interazioni interne ad un sistema di imprese di modeste dimensioni, spazialmente concentrate operanti in fasi diverse del processo produttivo con una certa popolazione, operaia e non, su un territorio di insediamento, industriale e residenziale relativamente ristretto”. [3] Cfr. Vasapollo L., " Analisi statistico-economica dei mutamenti strutturali e localizzativi dello sviluppo del sistema socio-economico italiano, in Proteo n.0. [4] Caroli G.M., Fratocchi L. (a cura di), "Nuove tendenze nuove strategie...", op. cit., pag.192-193. [5] M. Regini, “Modelli di capitalismo...”, op. cit., pag.42. [6] Non si prende in questo caso in considerazione il settore del turismo limitandosi ad analizzare il settore manifatturiero. [7] I dati si riferiscono al 1998. [8] Cfr.A. Quadro Curzio, M.Fortis "Il made in Italy oltre il 2000",il Mulino, Bologna,2000. [9] Cfr.A. Quadro Curzio, M.Fortis "Il made in Italy ...", op. cit. [10] Cfr.A. Quadro Curzio, M.Fortis "Il made in Italy ...", op. cit. [11] "Tale aggregato di beni commerciato dall’Italia rappresenta, in valore assoluto, la settima principale voce di esportazione dei paesi OCSE immediatamente dopo colossi quali la meccanica elettrica ed elettronica di Giappone e stati Uniti e la meccanica non elettrica della Germania. Ma, a livello di export pro-capite, il dato dell’Italia in questo aggregato di beni costituisce addirittura la più importante categoria di merci in assoluto tra i paesi OCSE con circa 1.179 dollari di esportazioni per abitante nel 1992...". Cfr.A. Quadro Curzio, M. Fortis "Il made in Italy...", op. cit., pag.35.
|