1. Parmalat: l’ennesimo caso di dissesto industriale
Nel corso degli ultimi anni si sono verificati clamorosi casi di dissesto aziendale, in Italia come in altri paesi occidentali. Episodi che hanno variegate e complesse chiavi di lettura. Una di queste fa sicuramente riferimento al funzionamento del sistema finanziario e creditizio. Abbiamo già espresso nel precedente numero di Proteo la nostra convinzione che la crisi dei mercati finanziari degli ultimi anni derivi solo in parte dal negativo andamento dell’economia reale, dipendendo in realtà anche da criticità interne al settore connesse alle regole che governano i mercati, il comportamento degli operatori e i meccanismi di sollecitazione e tutela del pubblico risparmio.
Questa valutazione era consequenziale all’osservazione empirica di casi concreti, tanto incresciosi quanto indicativi di un potenziale negativo forse non ancora pienamente esploso. Su queste basi era stata poi elaborata un’ampia analisi dei principali nodi del settore, che toccava aspetti come i conflitti di interesse nel sistema finanziario, la scarsa evoluzione della Corporate Governance, le lacune della vigilanza e così via.
Poi è scoppiato anche il caso Parmalat. Per molti versi non si tratta di un caso come gli altri. Quantomeno per le dimensioni. Dalle informazioni attualmente disponibili, il buco della Parmalat si aggirerebbe intorno ai 14 mld di Euro. Un valore pari a circa l’1% del PIL Italiano. E le obbligazioni emesse dovrebbero attestarsi, stando all’audizione parlamentare del Governatore della Banca d’Italia, intorno ai 7 mld di Euro. Due dei quali sottoscritti da piccoli risparmiatori italiani. Tanto per avere un termine di paragone, il caso Enron - considerato il più grande fallimento di tutti i tempi in termini assoluti - è stato pari allo 0,5% del PIL degli Stati Uniti, se consideriamo i valori di Borsa del gigante energetico prima del fallimento.
Ma il caso Parmalat ha un’ulteriore aggravante: arriva subito dopo quello Cirio, che aveva già profondamente minato la fiducia nei confronti del sistema finanziario e creditizio del nostro paese.
2. Capitalismo familiare sotto accusa e contributo “aggiuntivo” del sistema finanziario
I casi Parmalat e Cirio possono essere esaminati sotto diverse prospettive. C’è il capitalismo familiare italiano, più incline a comandare che a governare le aziende. C’è la crescente dimensione globale dei gruppi, industriale e finanziaria, che favorisce la “distrazione” di fondi dal processo produttivo e la realizzazione di falsa contabilità. C’è la struttura collusiva e marcatamente domestica del nostro sistema economico e creditizio, che mantiene il paese confinato nel proprio provincialismo senza ambizione. C’è l’inafferrabile rete dei conflitti di interesse: tra banche e imprese, imprese e società di revisione, banche e piccoli risparmiatori e persino tra autorità di vigilanza. C’è la commistione più deteriore tra affari e politica. C’è una struttura di vigilanza “sacralizzata” nel tempo, e quindi rimasta indietro rispetto alle nuove sfide poste dai cambiamenti degli anni ’90. C’è, infine, un sistema di regole inadeguato, che non ha ancora fatto i conti con l’innovazione tecnologica e la globalizzazione dei mercati.
Semplificando al massimo, si tratta comunque di episodi a doppia trazione: industriale e finanziaria. È su questo secondo aspetto, però, che intendiamo soffermare l’attenzione. Per chiederci se accanto alle cause primarie di queste gravi crisi aziendali, che indubbiamente risiedono nella sfera industriale, non ci sia stato anche un contributo “aggiuntivo” da parte della finanza. Un contributo, cioè, che lungi dall’arginare i limiti del capitalismo italiano, li abbia in qualche modo assecondati o amplificati.
In quest’ottica, dopo un breve riepilogo dei fatti riguardanti Parmalat e Cirio, concentreremo l’attenzione su due particolari aspetti che hanno giocato un ruolo determinante in entrambe le circostanze: quello delle obbligazioni societarie (“Corporate Bond” o “Bond”), come esemplificazione della “crisi delle regole che governano i mercati finanziari, il comportamento degli operatori e i meccanismi di sollecitazione e tutela del pubblico risparmio”, e il nodo della vigilanza.
3. Il caso Parmalat: cronistoria di un default annunciato
Prima del crollo, la Parmalat era l’ottavo gruppo industriale italiano per fatturato e il primo gruppo non finanziario tra i primi non finanziari del MIB 30 della nostra Borsa. Presente in 30 paesi diversi e in tutti e 5 i continenti, vantava - e vanta tuttora - circa 36 mila dipendenti. Queste dimensioni sono il frutto di una strategia di crescita in parte abbastanza recente. Tra il 1997 e il 2000, infatti, la Parmalat ha raddoppiato il fatturato attraverso una serie di acquisizioni, soprattutto in Sud America. Probabilmente è in questo passaggio che l’azienda ha superato definitivamente il punto di non ritorno nell’equilibrio economico-finanziario tra costi e ricavi, debiti e patrimonio, utili e interessi.
Nonostante la sua struttura globale e la crescita degli ultimi anni, la Parmalat è sempre rimasta un gruppo a conduzione strettamente familiare. La Coloniale, società della famiglia Tanzi, possiede il 51,16% circa di Parmalat Finanziaria che, a sua volta, controlla Parmalat SpA. Il gruppo, inoltre, conta su circa 30 mila azionisti che possiedono 400 milioni di azioni, oggi completamente prive di valore. Mancano, invece, altri rilevanti soci industriali, che avrebbero garantito una maggiore dialettica imprenditoriale nell’elaborazione di strategie d’impresa votate all’internazionalizzazione.
In buona sostanza, “la famiglia” non è mai voluta scendere sotto il 51%, nonostante il fatto che, notoriamente, società ad ampio flottante sono controllabili anche con percentuali inferiori alla metà del capitale sociale. Inoltre, la stessa Corporate Governance del gruppo - ovvero la struttura di governo dell’azienda - ha sempre mantenuto una forma piramidale chiusa sulla famiglia.
Benché l’epilogo sia stato apparentemente improvviso, la crisi del gruppo parte da lontano. Alla rapida crescita per vie esterne non è mai corrisposto un parallelo aumento della redditività che, anzi, si è progressivamente ridotta. Il rapporto della Parmalat con i mercati si è progressivamente deteriorato, pur essendo già da tempo molto negativo in termini di chiarezza e trasparenza. Proprio in ragione di questa scarsa trasparenza sui conti, peraltro, gli analisti finanziari hanno spesso applicato un sostanziale sconto al valore della società calcolato con gli apparenti fondamentali del gruppo.
Il tira e molla con i mercati andava ormai avanti da almeno un anno quando, a seguito dell’ennesima richiesta di chiarimento da parte della Consob, è crollato il castello. La contraddizione nota da tempo ai mercati finanziari si è rivelata essere proprio quello che si poteva temere che fosse: un buco. Anzi, una voragine. La contraddizione era tanto semplice quanto evidente: la società dichiarava una liquidità esorbitante, superiore ai 4 mld di Euro, eppure allo stesso tempo chiedeva continuamente finanziamenti al mercato, soprattutto sotto forma di emissioni obbligazionarie. Palesemente necessarie a rimborsare i debiti in essere, come dimostra una certa contestualità tra le scadenze di questi debiti e le nuove emissioni.
Eppure, l’indebitamento iscritto in bilancio era sempre cresciuto, fino a raggiungere livelli di guardia. Nel 2002, a fronte di un fatturato apparente di 7,5 mld di Euro, i debiti ufficiali della Parmalat erano di 6 mld di Euro. Il Rapporto debito finanziario / capitale netto era passato in pochi anni da 2,5 a 3,8, cioè sei volte superiore alla media del settore. Una situazione già molto critica, eppure rivelatasi estremamente più grave, alla luce della ricostruzione degli effettivi dati di bilancio attualmente in corso da parte della Pricewaterhouse. In totale i Bond emessi tra il 1997 e il 2002 sono risultati 32, per un controvalore complessivo di 7 mld di Euro (circa 7 volte di più di quelli Cirio). Le emissioni sono avvenute prevalentemente su mercati finanziari esteri, anche se circa 2 mld di Euro sono stati sottoscritti in Italia (il doppio di quelli Cirio), a fronte di un indebitamento di Parmalat verso banche italiane pari a circa 3 mld di Euro.
Oltre alla liquidità esorbitante, che poi è risultata inesistente, c’erano altre palesi criticità: operazioni finanziarie in derivati altamente sospette; inspiegabili impieghi finanziari in fantomatici fondi di investimento costituiti in paradisi fiscali; consistenti crediti commerciali sui quali il gruppo non dava sufficienti informazioni, ma che sicuramente stentavano a rientrare; depositi incomprensibilmente mantenuti liquidi (come quello presso la Bank of America, poi risultato un falso).
A completare il quadro, possiamo aggiungere i seguenti aspetti: la complicità dei revisori, sulla quale si sta ancora indagando; il ruolo ambiguo di alcune banche nazionali e internazionali; l’incredibile ritardo con il quale l’agenzia di rating, Standard & Poor’s, ha declassato la Parmalat, praticamente quando il dissesto era ormai già ampiamente manifesto; e infine le interconnessioni con l’altro grave epilogo in corso sul palcoscenico italiano: quello della Cirio.
4. Il caso Cirio: un’altra crisi partita da lontano
Il caso Cirio, che ha preceduto di qualche mese quello Parmalat, è decisamente più piccolo, anche se per alcuni versi potrebbe essere considerato persino più grave. Innanzitutto perché è un caso totalmente italiano. Poi perché presenta una dinamica che con maggiore evidenza lascia trasparire le responsabilità del sistema bancario. Esaminiamo brevemente i fatti.
Anche il caso Cirio parte da lontano. La storia è estremamente semplice e lineare. All’inizio degli anni ’90, Sergio Cragnotti costituisce una banca d’affari con sede operativa in Lussemburgo e holding di controllo a Dublino, denominata Cragnotti & Partners.
I soci di Cragnotti sono una serie di primarie banche nazionali e internazionali. Secondo le ricostruzioni di stampa, tuttavia, si tratta di soci solo “apparenti”. Le banche, infatti, chiedono e ottengono un’opzione “put”, cioè il diritto di rivendere in qualsiasi momento la propria quota di partecipazione a Cragnotti che, evidentemente, si è parallelamente impegnato a riacquistarla a semplice richiesta.
Con il passare degli anni, però, la redditività industriale del gruppo stenta a decollare. Forse anche per questa ragione, tra il 1994 e il 1999 tutte le banche associate alla C&P chiedono il rimborso delle rispettive quote (solo il gruppo Capitalia lo ha fatto più tardi, nel 2001).
Contestualmente, il gruppo Cirio ha intrapreso una strada di espansione, raddoppiando il fatturato in 4 anni attraverso successive acquisizioni di imprese. Mentre, quindi, diminuiscono le partecipazioni delle banche nella holding di controllo e la redditività non migliora significativamente, la crescita del fatturato viene finanziata con il ricorso al debito. Tra il 1998 e il 2002, l’indebitamento di Cirio Holding (controllata dalla C&P) passa dal 60 ad oltre il 160% del fatturato. Nel 1994 era appena il 20%.
Rimborsato il capitale alle banche, il gruppo Cirio deve ora rimborsare i debiti. Dato che la redditività non è sufficiente, serve un’altra soluzione. Nel 1999 ha luogo la prima emissione obbligazionaria. Poi, a ruota, tra il 1999 e il 2002 il gruppo Cirio effettua 7 emissioni di Bond per un ammontare complessivo di circa 1.125 milioni di Euro. Sei di queste emissioni sono realizzate da banche italiane su mercati esteri (Olanda e Lussemburgo) e sono riservate ad investitori istituzionali (le banche stesse). A seguito di queste emissioni obbligazionarie, il rapporto tra debiti verso banche e Bond si inverte completamente. I finanziamenti bancari passano dal 94% dei debiti verso terzi del 1999 (di cui i 3/4 a breve termine) al 28% circa del 2002, mentre le obbligazioni avanzano dal 6 al 72%. I Bond, in sostanza, nel 2002 hanno sostituito il debito bancario, finendo nel portafoglio di circa 35 mila piccoli risparmiatori (per un controvalore di circa 900 mln di Euro).
Già così i fatti sarebbero abbastanza gravi. Ma c’è anche dell’altro. Questi Bond erano stati originariamente emessi in Lussemburgo come titoli riservati ad investitori istituzionali (ovvero le stesse banche). Di conseguenza erano privi di rating e senza alcun prospetto informativo. Il che sostanzialmente significa che non avrebbero potuto essere venduti allo sportello attraverso una sollecitazione al pubblico risparmio, ma solo su eventuale esplicita richiesta dei clienti. A quanto pare, la spontanea richiesta dei clienti è stata molto sostenuta, dato che questi titoli sono passati quasi totalmente dalle banche ai piccoli risparmiatori. Peraltro, molto spesso già in fase di emissione. La magistratura dovrà accertare se questa cessione sia avvenuta dolosamente da parte delle banche - cioè con la consapevolezza che il gruppo Cirio era sostanzialmente sulla strada del fallimento - e se, in ogni caso, c’è stata un’illecita attività di promozione finanziaria.
Non vi è dubbio, tuttavia, che qualcosa di importante non ha funzionato. I bilanci del gruppo Cirio avevano problemi da tempo: redditività contenuta; debiti crescenti rispetto al fatturato e una serie di singolari finanziamenti concessi al socio Cragnotti, sulla cui sorte si sta ancora cercando di fare luce. Quello che non ha funzionato va cercato in direzioni diverse. Ma in qualche modo confluisce sul mercato dei Bond, denunciando una clamorosa inefficienza macroeconomica. È questo mercato, in altre parole, il “luogo del delitto”.
5. Il mercato dei Bond nell’occhio del ciclone
I casi Argentina, Cirio e Parmalat [1] - pur essendo profondamente diversi tra loro - hanno portato sul banco degli imputati uno dei principali strumenti di indebitamento delle imprese: le obbligazioni societarie. Tanto per dare un ordine di grandezza, solo per questi tre casi stiamo parlando di oltre 500.000 risparmiatori italiani coinvolti e circa 15 miliardi di Euro di prestiti obbligazionari a rischio [2]. La seguente tabella fornisce i termini di paragone per inquadrare quantitativamente il fenomeno:
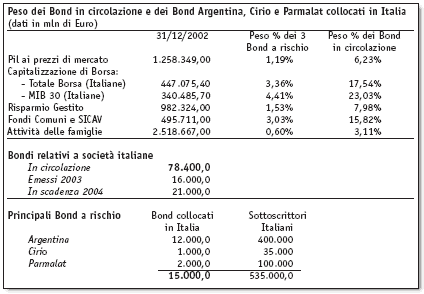
Solitamente i Bond sono considerati uno strumento a basso rischio. In sostanza questo è vero nella misura in cui è vero che gli obbligazionisti sono privilegiati rispetto agli azionisti nel rimborso del capitale. Anche i Bond, dunque, hanno un loro rischio e questo rischio, benché inferiore a quello delle azioni della stessa società, è comunque legato alle possibilità di fallimento dell’emittente.
In termini più generali, l’accusa principale emersa in questi mesi nei confronti dei Bond è che consentirebbero alle banche di trasferire il rischio dai loro bilanci al portafoglio dei risparmiatori. In una certa misura questo è un fatto reale ed è anche un fatto positivo, perché moltiplica e valorizza lo strumento del debito all’interno di un sistema, andandosi a sovrapporre ai finanziamenti bancari. Per questo non va criminalizzato lo strumento. Anzi, proprio lo sviluppo dei “Corporate Bond” negli anni ’90 ha consentito di moltiplicare enormemente le potenzialità di credito dei sistemi finanziari, a beneficio degli investimenti. Tanto per dare un’idea del fenomeno, nel mondo ci sono attualmente circa 6 mila mld di dollari di Corporate Bond” in circolazione, di cui 1/6 circa in Europa e 4/6 negli Stati Uniti. Nel 2003 si sono avute nuove emissioni per 170 mld di Euro, il 24% in più rispetto al 2002. In Italia, nei primi 11 mesi del 2003 ci sono state emissioni per circa 16 mld di Euro. I Bond in circolazione nel nostro paese ammontano a quasi 80 mld di Euro, di cui il 21% circa senza rating. E nel 2004 saranno in scadenza ben 21 mld di Euro [3].
Naturalmente gli effetti positivi dei Bond vengono meno se il trasferimento di rischio avviene senza alcuna responsabilizzazione delle banche o, addirittura, per scaricare sui piccoli risparmiatori probabili insolvenze degli emittenti. Quello che si può criticare, allora, non è lo strumento in sè, bensì l’uso che ne è stato eventualmente fatto in queste circostanze e il ricorso ai piccoli risparmiatori anche in situazioni che lo avrebbero sconsigliato.
Con riferimento ai casi Cirio e Parmalat, si possono individuare due termini del problema: uno di carattere generale, che ha a che fare con l’efficienza dei mercati in presenza di conclamati conflitti di interesse da parte delle banche, e uno più strettamente di cronaca, che ha a che fare con la correttezza dei comportamenti in questi specifici episodi.
Sul primo fronte, i recenti eventi dimostrano che lo sviluppo iperbolico dei mercati obbligazionari presenta indubbiamente un rischio sistemico. Quello, cioè, di avere un’enorme massa di risparmio non intermediata in base al criterio del merito di credito. È stata messa in discussione, in altre parole, la capacità delle banche di svolgere correttamente la loro funzione di intermediazione finanziaria, intesa come capacità di selezione dei migliori investimenti per il risparmio e per il sistema. Soprattutto in ragione del conflitto di interesse che esiste tra la banca che colloca obbligazioni per il proprio cliente-impresa, con il quale negozia le commissioni di collocamento, e il proprio cliente-risparmiatore, che le sottoscrive. Se la banca non assume in proprio almeno una porzione del finanziamento, e per tutta la sua durata, può essere più interessata a proporre i prodotti che fruttano le maggiori commissioni anziché quelli meritevoli di fiducia da parte del mercato.
Diversa e, per evidenti ragioni, più grave, è la prospettiva strettamente legata alla cronaca. Ciò che la magistratura dovrà accertare, caso per caso, è se le banche hanno venduto obbligazioni Argentina, Cirio e Parmalat quando i rischi d’insolvenza degli emittenti erano diventati più probabili o addirittura conclamati. Le denuncie, al riguardo, sono numerose e in alcuni casi sembrano ben circostanziate. Da questo punto di vista il caso più imbarazzante è sicuramente il caso Cirio, perché tra il 2000 e il 2002 la struttura dell’indebitamento del gruppo si è completamente ribaltata a sfavore dei Bond e a vantaggio dei finanziamenti bancari, quasi totalmente rimborsati. Peraltro in un contesto di redditività compromessa, scarsi investimenti aggiuntivi e modesta riduzione del debito complessivo. Il che significa che le emissioni obbligazionarie sono state utilizzate per ripagare le banche. -----
6. Il dibattito sui Bond tra falsi problemi e apparenti soluzioni
I casi Cirio e Parmalat hanno sollevato un enorme dibattito che, comprensibilmente, ha in gran parte riguardato i Bond. Spesso, tuttavia, questo dibattito si è polarizzato su valutazioni eccessivamente drastiche e radicali oppure, al contrario, su affermazioni vacuamente rassicuranti, accompagnante da soluzioni di mera facciata.
Certamente radicale è la critica indiscriminata alle obbligazioni come strumento finanziario, senza capacità di discernere tra gli utilizzi più o meno virtuosi di questa preziosa forma di indebitamento. Come eccessive sembrano le critiche verso paesi quali l’Olanda e il Lussemburgo, pienamente inseriti nell’Unione Europea ma spesso confusi con i numerosi paradisi fiscali sparsi per il mondo.
Per contro, non si può neanche far finta che tutto vada bene così. Abbiamo detto che il mercato dei Bond è essenziale per lo sviluppo economico. Tuttavia, nelle sue attuali condizioni questo mercato pone oggettivamente il rischio sistemico di un’allocazione inefficace del risparmio, dato che le banche sono motivate esclusivamente dalle commissioni percepite anziché da valutazioni del merito di credito dell’emittente. E quindi non svolgono in modo efficace la loro funzione di intermediazione, che non può essere totalmente demandata ad un “non investitore” come le agenzie di rating.
Per questo sono pericolose le soluzioni di mera facciata. Come il “Bollino Blu” dell’ABI, per esempio, una sorta di “rating” istituzionale attribuito da un’associazione di categoria secondo criteri ampiamente discutibili. Un’iniziativa, peraltro, che rischia di penalizzare ingiustamente i titoli esclusi e, anche per questo, sembra destinata ad esaurirsi molto presto.
Insufficienti, però, potrebbero essere anche proposte più sostanziali e coraggiose, se non inserite in un contesto organico e articolato di riforma del settore. Come quella di obbligare le banche, in determinate circostanze, a detenere per almeno un anno i titoli dei quali curano l’emissione, prima di poterli eventualmente collocare ai piccoli risparmiatori. Si tratta di una soluzione mutuata dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna, che potrebbe rivelarsi inutilmente penalizzante, se applicata in maniera indiscriminata, o poco incisiva, se applicata in presenza di gravi conflitti d’interesse. Perché il problema, in quest’ultimo caso, verrebbe solo rinviato e non risolto.
Parziale è anche la proposta, formulata dopo il crack della Cirio, di vietare il collocamento ai piccoli risparmiatori dei Bond senza rating, quantomeno se all’emissione sono riservati ad investitori istituzionali. A ben vedere, l’attribuzione di un rating non è un argomento risolutivo. Parmalat, ad esempio, aveva un rating e l’agenzia di rating non ha brillato per prontezza di riflessi. Certo, nel caso Cirio l’assenza di rating sui Bond è un’aggravante, perché le emissioni sono state utilizzate per rimborsare le banche che ne curavano il collocamento. Con tutti i suoi limiti, e non sono pochi, in questo caso il rating avrebbe indubbiamente costituito un momento di controllo indipendente a favore del mercato. Ma non sarebbe stato un elemento decisivo, perché un rating probabilmente sarebbe stato comunque assegnato a quei Bond. Concedere un rating, infatti, fa guadagnare le agenzie specializzate, che si coprono sempre dietro i limiti oggettivi delle loro valutazioni, strettamente circoscritte alla presunta solvibilità dell’emittente valutata in base alle informazioni rese disponibili. Anzi, la presenza di un rating potrebbe addirittura risultare pericolosa laddove fosse percepita dai risparmiatori come un’indicazione oggettiva di solvibilità, senza in effetti esserlo. Anche quella del rating, quindi, è un’ipotesi da valutare sempre nell’ambito di un più ampio ed organico progetto di riforma del settore.
Peraltro, come abbiamo ampiamente evidenziato, il fatto più grave del caso Cirio è stato un altro: e cioè la circostanza che dei titoli riservati a investitori istituzionali siano stati sistematicamente collocati a piccoli risparmiatori. Intendiamoci, com’è stato sottolineato anche dalla Banca d’Italia, se questo collocamento è effettivamente avvenuto senza alcuna attività di sollecitazione al pubblico risparmio, non c’erano divieti formali ad impedirlo. Ma, appunto, è grave proprio il fatto che non ci fossero divieti espliciti o anche solo indicazioni di “moral suasion” - come avviene in Germania e Gran Bretagna per casi analoghi - che superando gli aspetti formali in qualche modo subordinassero queste operazioni ad una maggiore corresponsabilizzazione delle banche. Perché è proprio la corresponsabilizzazione il perno centrale di qualsiasi efficace proposta di cambiamento.
7. Alcune proposte in materia di Bond
Le soluzioni per limitare la deresponsabilizzazione delle banche sulle emissioni di Bond possono essere numerose, anche se vanno attentamente modulate in base all’effettiva gravità delle diverse fattispecie. Distinguendo, peraltro, tra operazioni sul mercato primario (nuove emissioni) e operazioni sul mercato secondario (cessione di titoli già emessi nella disponibilità della banca o di suoi altri clienti). Con il duplice obiettivo di accrescere i profili di tutela sostanziale dei risparmiatori senza al contempo penalizzare lo sviluppo di un mercato necessario al buon andamento dell’economia. In linea estremamente sintetica, possiamo limitarci alle seguenti considerazioni:
• I divieti perentori di collocare o vendere Bond dovrebbero essere circoscritti a casi estremi, ma non possono essere del tutto esclusi (come ad esempio nel caso in cui nuove emissioni di obbligazioni fossero destinate a rimborsare finanziamenti bancari, in presenza di incerte prospettive di solvibilità dell’emittente);
• In assenza di veri e propri divieti, si potrebbe prevedere in particolari situazioni la garanzia di solvibilità obbligatoria da parte delle banche responsabili dei collocamenti. Si tratta di un’ipotesi già adottata da tempo in altri paesi e recentemente valorizzata anche dal nostro nuovo diritto societario, sebbene limitatamente alle Srl e alle emissioni di Bond da parte di Società per Azioni, per importi che eccedono il doppio del loro patrimonio. È, però, ancora una volta una soluzione estrema, che dovrebbe essere applicata solo in casi limite. Perché è una soluzione che ha il problema sistemico di far gravare sul patrimonio della banca il peso della garanzia, togliendo al Bond proprio la sua principale utilità: quella cioè di moltiplicare le potenzialità del sistema di finanziare le imprese;
• In presenza di rilevanti conflitti di interesse (partecipazioni incrociate; rapporti consolidati; passaggio dal finanziamento bancario al debito cartolare, ecc.), potrebbe essere prevista l’obbligatorietà di un rating all’emissione oppure, in aggiunta o in alternativa a seconda dei casi, l’obbligo per le banche responsabili del collocamento di mantenere in portafoglio una certa percentuale dell’emissione per tutta la durata del prestito. In questo modo si attenuerebbe in modo permanente il conflitto di interesse con il cliente risparmiatore e si responsabilizzerebbe la banca a svolgere la sua preziosa opera di selezione delle imprese in base al merito di credito;
• Un’altra soluzione da non sottovalutare è quella di prevedere in particolari circostanze, l’obbligo di collocamenti ripartiti tra piccoli risparmiatori e investitori qualificati, diversi e indipendenti dalle banche che effettuano il collocamento. Troppo spesso si vedono sul mercato prodotti destinati esclusivamente all’una o all’altra categoria di sottoscrittori, sulla base della retorica che le rispettive esigenze sarebbero inconciliabilmente diverse. L’esperienza dimostra, invece, che la principale differenza risiede soprattutto nella diversa capacità di valutare la struttura e l’equità commerciale dei prodotti sottoscritti. Non di rado sui mercati azionari sono proprio gli investitori istituzionali indipendenti il vero “cane da guardia” del piccolo risparmiatore retail. Perché i piccoli risparmiatori che si recano allo sportello non fanno il mercato ma, in un certo qual modo, lo subiscono. È per questo, del resto, che un obbligo del genere è stato recentemente introdotto, sia pure in forma blanda, per i collocamenti e le quotazioni di società sul Nuovo Mercato di Borsa;
• Una strada da intraprendere sicuramente è quella che, eloquentemente, viene sempre più spesso indicata come “trasparenza sostanziale”, in contrapposizione alla trasparenza solo formale attualmente prevalente sul mercato. In questo ambito dovrebbero diventare obbligatorie, chiare e, entro certi limiti, responsabilizzanti alcune informazioni essenziali come quelle relative ai conflitti di interesse della banca con l’emittente; alle motivazioni per le quali viene effettuata la nuova emissione di Bond o ceduto il titolo in precedenza detenuto dalla banca o da un terzo cliente; al livello di compartecipazione al rischio da parte della banca stessa e alla valutazione della situazione economico-finanziaria del debitore;
• In un contesto come quello italiano - nell’ambito del quale cioè la gestione del risparmio viene effettuata in prevalenza da società appartenenti a gruppi bancari - dovrebbero inoltre essere introdotte delle norme più restrittive in relazione ai collocamenti intragruppo di prodotti finanziari, attualmente possibili fino al 60% della quota da collocare a disposizione di ogni singola banca. Questo al fine di impedire che i piccoli risparmiatori si trovino a sottoscrivere prodotti indesiderati senza neanche saperlo, attraverso i propri fondi comuni di investimento.
Infine, c’è un principio generale che potrebbe trovare cittadinanza anche in Italia, come del resto già accade nei paesi di stampo anglosassone: in casi di oggettivo e grave conflitto d’interesse nei confronti della clientela, dovrebbe entrare in gioco l’inversione dell’onere della prova. Sarebbe cioè la banca a dover dimostrare che nonostante il conflitto di interesse ha sostanzialmente e formalmente rispettato le regole e fatto tutto quanto avrebbe dovuto a tutela del piccolo risparmiatore. Unitamente alla “class action”, cioè alla possibilità di effettuare azioni di ricorso collettivo, sarebbe un elemento importante per conciliare le esigenze di sviluppo dei mercati con quelle di tutela dei piccoli risparmiatori.
Per il momento, in attesa che la fiducia dei risparmiatori possa essere rassicurata da nuovi provvedimenti, è sicuramente positiva la scelta di quasi tutte le principali banche coinvolte nei casi Cirio e Parmalat di procedere ad un rimborso totale o parziale dei Bond collocati ai propri clienti, sia pure con valutazione caso per caso. Una decisione che va nella giusta direzione della responsabilizzazione del sistema bancario e che, al di là delle dichiarazioni ufficiali, ha tutta l’aria di essere un’ammissione di responsabilità, quantomeno oggettiva se non proprio giudiziaria.
8. Il problema della vigilanza
La gravità degli eventi ha sollevato il tema dell’eventuale responsabilità delle autorità di vigilanza.
Innanzitutto perché non avrebbero saputo impedire il verificarsi di episodi indubbiamente incresciosi. La Consob è sicuramente intervenuta su Parmalat, ma lo ha fatto con molto ritardo. E non sembra essere stata particolarmente efficace nel controllo delle emissioni di Bond da parte della Cirio. In generale, peraltro, il suo “track record” non è particolarmente positivo e la sua indipendenza dalla politica un aspetto ampiamente migliorabile. La Banca d’Italia, da parte sua, ha negato qualsiasi responsabilità formale, difendendo al contempo - forse persino più di quanto abbia fatto la stessa ABI - la solidità e la correttezza del sistema bancario. Eppure si è trattato di episodi troppo visibili per non essere stati colti e debitamente interpretati dal principale organismo di vigilanza sul sistema bancario. Che a dirla tutta, ha troppi obiettivi spesso in contraddizione tra loro, come la tutela della stabilità, la salvaguardia dei risparmiatori e il governo del settore. Nell’ambito di assetto proprietario non alieno da peculiari e pericolosi conflitti di interesse, peraltro aggravati dalla compartecipazione, diretta o mediata dal proprio fondo pensioni, al capitale di numerose imprese del settore. Senza considerare, infine, che pur essendo indipendente dalla politica, la Banca d’Italia si presenta eccessivamente teocratica ed autoreferenziale, il “peccato” opposto della subordinazione.
In realtà, di fronte ai numerosi scandali finanziari degli ultimi anni e alla dimensione di quanto è successo, è difficile per le autorità di vigilanza chiamarsi fuori.
Un secondo profilo di responsabilità da parte delle autorità di vigilanza riguarda l’attenzione prestata alla tutela del risparmio. Prima, con l’emanazione di adeguate regole o indicazioni di moral suasion, e successivamente, di fronte cioè al manifestarsi dei primi allarmanti episodi, con l’adozione di vigorose azioni ispettive e efficaci interventi sanzionatori. Su questo aspetto, l’impressione è che gli organismi di vigilanza abbiano dimostrato più attenzione e sensibilità verso il governo, la stabilità e la salvaguardia della credibilità dei mercati e degli operatori che non verso la tutela del risparmio, lasciata di fatto alla competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria e delle associazioni di tutela dei risparmiatori. È vero che, come quella della stabilità, anche la tutela del risparmio passa anche per messaggi rassicuranti. Perché il panico è autolesionista, tende cioè a produrre proprio quegli effetti negativi dai quali si intende fuggire. Ma quando i risparmiatori incappati in spiacevoli incidenti superano le 500.000 unità, il problema è endemico e il silenzio delle autorità di vigilanza, così come la loro reale o apparente inerzia, diventa preoccupante, perché finisce col sortire l’effetto opposto.
Anche in questo caso, dunque, la vigilanza non si può appellare a fatti formali. La stabilità del sistema non è stata salvaguardata, il risparmio è stato mal tutelato e la trasparenza resta ancora un fatto troppo formale e poco sostanziale. Gli strumenti d’intervento c’erano, perché la vigilanza non è solo ispettiva ed anzi, quando funziona bene, è soprattutto preventiva, attraverso l’azione regolamentare o la cosiddetta “moral suasion”.
Proprio quest’ultima considerazione ci introduce alla terza, e forse più grave critica, che potrebbe essere rivolta al sistema di vigilanza. Quella che riguarda l’efficacia con la quale le autorità di controllo hanno saputo interpretare, almeno negli ultimi due anni, il loro ruolo di regulator del settore, per correggere con nuove disposizioni di vigilanza regolamentare - rapidamente ed efficacemente - le numerose lacune evidenziate dalla lunga catena di gravi episodi verificatisi in questo periodo, tanto in Italia quanto in altri paesi.
La sensazione è che più di ogni altro sia mancato appunto questo particolare intervento nel nostro sistema. E, a prescindere da valutazioni di opportunità politica, è proprio il dubbio che sia stata svolta in modo adeguato quest’ultima funzione ad attribuire alla riforma del sistema di vigilanza una valenza prioritaria. Per evitare in futuro nuove criticità endemiche.
Certamente, nell’attuale contesto italiano non si può sottovalutare il timore che molte critiche abbiano un significato squisitamente politico e che la soluzione che sarà prospettata possa essere peggiore del male. Purtroppo il dibattito sulla riforma della vigilanza, di per se doveroso ed opportuno in un paese moderno, è finito per degenerare in una deteriore polemica personale e istituzionale, che non prelude a nulla di buono.
Nonostante ciò, per diverse ragioni è positivo il fatto che si sia finalmente aperto in Italia un dibattito del genere. Il tabù su questo argomento, legato ai noti e spiacevoli episodi della fine degli anni ’70, è caduto. Dopo il trasferimento del controllo sulla base monetaria alla Banca Centrale Europea e la creazione dell’Antitrust, era arrivato il momento di affrontare il tema di una modernizzazione dell’intera struttura di vigilanza sui mercati e gli operatori. Inoltre, i numerosi scandali finanziari degli ultimi anni hanno posto un rilevante problema di internazionalizzazione dei controlli. L’esigenza di una riforma era ormai già da tempo condivisa da molti.
Il che ci conduce ad una rapida analisi del sistema di vigilanza in Italia, che in linea di principio è attualmente tripartito, con una distinzione per finalità nell’ambito della quale la Consob tutela la trasparenza delle imprese, la Banca d’Italia tutela la stabilità degli intermediari creditizi e dei mercati e ha le competenze in materia di concorrenza nel settore creditizio mentre l’Antitrust tutela la concorrenza, con esclusione del sistema bancario.
Non mancano, tuttavia, alcune anomalie, tra le quali ad esempio:
• La presenza di autorità competenti per specifici settori, come la Covip per i fondi pensione e l’Isvap per le assicurazioni (con il rischio di un’eccessiva comprensione delle ragioni delle imprese che dovrebbero controllare);
• La sottrazione all’Antitrust delle competenze in materia di concorrenza del settore creditizio;
• La non sempre chiara ripartizione di competenze tra Banca d’Italia e Consob su alcuni profili di vigilanza, trasparenza e tutela dei risparmiatori.
Se questo è il sistema attuale, la sua riforma richiede innanzitutto la scelta chiara di un modello. Quelli più diffusi sono ad autorità unica o tripartita per finalità (simili quindi al modello italiano). Uno sguardo agli altri paesi mostra che non esiste una soluzione prevalente. In Europa entrambe le soluzioni sono ampiamente adottate, in modo quasi equamente suddiviso. Anche l’analisi teorica non fornisce risposte univoche. Peraltro l’autorità unica è un modello di recente applicazione, sul quale manca quindi la possibilità di una valutazione empirica.
Volendo optare pragmaticamente per una soluzione a tre autorità, coerente con l’attuale assetto italiano e con il potenziale beneficio di una certa dialettica tra organismi di controllo, i principi sui quali si potrebbe realizzare un miglioramento dell’attuale sistema sono i seguenti:
• Mantenere la vigilanza per finalità, riducendo a tre il numero di autorità, e nel contempo:
• Potenziare la Consob, che oggettivamente ha competenze estremamente ampie e articolate;
• Assegnare la tutela della concorrenza bancaria all’Antitrust;
• Eliminare le attuali aree di sovrapposizione o incertezza nelle rispettive competenze delle diverse autorità;
• Garantire la massima autonomia e indipendenza dalla politica a tutte le autorità di controllo;
• Responsabilizzare l’attività di vigilanza (accountability) verso il Parlamento e la società civile (non verso il Governo);
• Eliminare particolari situazioni di conflitto di interesse (come ad esempio, nel particolare caso della Banca d’Italia, quelli associati alla struttura del suo capitale sociale oppure derivanti dalle partecipazioni conseguite attraverso l’impiego di liquidità o del patrimonio del fondo pensione dei dipendenti);
• Potenziare il coordinamento internazionale dell’attività di vigilanza, a cominciare da quello Europeo nell’ambito della BCE.
In ogni caso, un tema come quello della vigilanza dovrebbe avere una valenza di ampio respiro parlamentare, alla stregua delle norme di carattere costituzionale. L’augurio è che eventuali revisioni dell’attuale assetto dei controlli siano realizzate con larghe intese. Non si può pensare di cambiare sistema o modalità di vigilanza ogni volta che cambia un Governo.
[1] Ai quali si potrebbero aggiungere altri casi minori, come quello Giacomelli o, più recentemente, Finmatica
[2] Difficile dire, inoltre, quanto è stato eventualmente acquistato da fondi comuni e, per questa via, sottoscritto dai risparmiatori senza neanche saperlo.
[3] Una curiosità: il primo “EuroBond” è stato emesso nel lontano 1963 proprio da una società italiana, Autostrade. Per un importo a quel tempo di tutto rispetto: 15 mln di dollari