1. Povertà vecchie e nuove
In teoria ci sono quattro definizioni della povertà generalmente accettate, ognuna delle quali specifica una classe diversa di “poveri”:
1. “POVERTA’ ASSOLUTA: è la definizione “più classica” di povertà, ovvero: “mancanza di risorse per consumare un certo insieme di beni e servizi per soddisfare le necessità essenziali”;
2. POVERTA’ RELATIVA: ovvero basata su un confronto relativo tra i diversi gruppi componenti la società;
3. POVERTA’ SOGGETTIVA: valutazione personale del proprio stato di benessere. È comunque la definizione meno usata proprio per la sua soggettività;
4. POVERTA’ UMANA: o mancanza di beni essenziali e di particolari capacità e abilità per soddisfare i bisogni ritenuti fondamentali” [1].
Va poi analizzato un altro aspetto: Povero non è solo chi non ha una opportuna quota di reddito per la sussistenza, ma anche chi non può consumare una quantità necessaria di prodotti essenziali perché è una figura marginale del mercato del lavoro. Vi è infatti una parte della popolazione che, pur lavorando e ricevendo quindi un regolare stipendio, risulta inclusa tra i poveri perché il salario risulta l’unica fonte di sostentamento per la famiglia ed è totalmente inadeguato per vivere una vita dignitosa.
Comunque povertà è soffrire la fame, è vivere senza un tetto, è essere ammalati e non poter essere visitati da un medico; povertà significa non andare a scuola e non sapere leggere, è non avere un lavoro o avere un lavoro precario, intermittente, è vivere arrangiandosi, è paura del futuro.... Si potrebbe continuare all’infinito nell’elenco dei significati di povertà, ma oggi si parla sempre più di povertà relativa oltre alla povertà assoluta, di nuove povertà, di lavori poveri, di impoverimento dei ceti medi.
In passato la povertà è stata quasi del tutto associata ai paesi meno industrializzati, meno sviluppati, più “emarginati” dal moderno sistema economico di sviluppo e si tendeva, quindi, ad allontanare il problema dai paesi a capitalismo maturo che sembravano essere ricchi. Ma ormai negli ultimi anni questa non è assolutamente la situazione reale.
In realtà molte analisi e ricerche anche da parte di istituti e centri studi legati ad organismi internazionali, quali l’ONU, la Banca Mondiale, ecc, hanno accertato che la disoccupazione, le disuguaglianze distributive anche legate alla crescita smisurata dei prezzi alla produzione e al consumo e la sempre maggiore precarizzazione di un gran numero di persone nel mercato del lavoro hanno fatto sì che il “problema nuova povertà” sia diventato sempre più grave e in continua crescita.
La globalizzazione neoliberista, l’internazionalizzazione dei processi produttivi si accompagnano alla realtà di centinaia e centinaia di milioni di lavoratori disoccupati e precari in tutto il mondo.
Il sistema fordista ci aveva abituato al lavoro a tempo pieno e di durata indeterminata, ora invece un grande numero di lavoratori ha un contratto di breve durata o con orario breve, i nuovi lavoratori possono essere impegnati per poche ore al giorno per cinque giorni a settimana, oppure per molte ore al giorno ma solo per due o tre giorni a settimana.
Contratti di formazione lavoro, borse di dottorato, apprendistato, piani di inserimento professionale, borse di lavoro, contratti temporanei di anziani in possesso dei requisiti per il pensionamento, lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità, contratti atipici nella pubblica amministrazione, sono solo alcune delle decine di forme e combinazioni dei lavori atipici. Se guardiamo la situazione dal punto di vista dei lavoratori si hanno insicurezza economica, totale mancanza di prospettive, difficoltà di conciliazione dei tempi, precarietà in ogni fase della propria esistenza, ecc.
È necessario ricordare che l’aumento della precarizzazione del lavoro porta con sè una crescita dell’instabilità del reddito da lavoro; a ciò si aggiunge il graduale abbattimento del welfare soprattutto in campo previdenziale e sanitario. Tutto questo fa si che la situazione peggiori incessantemente e determini uno stato di precarietà permanente nel e del vivere sociale.
“La precarizzazione è un processo generale, un processo che condiziona l’esistenza di tutta la forza lavoro postfordista. Il processo di precarizzazione del lavoro, quest’esperienza d’incertezza comune al lavoro vivo postfordista si è affermata seguendo tappe, svolte, passaggi cruciali. Prime fra tutte le tappe degli interventi legislativi che hanno abbattuto, piano piano, l’intero edificio di garanzie acquisite dal lavoratore fordista e hanno, di fatto introdotto la possibilità di utilizzare la forza lavoro in un regime flessibile” [2]
Ed è proprio con la flessibilità imposta dalle regole di efficienza di impresa che si arriva alle condizioni di lavoro precarie, non continuative e temporanee nelle quali il lavoratore è lasciato a se stesso e si trova solo davanti all’imprenditore con il quale deve trattare le condizioni economiche e di tempo del proprio lavoro.
La nuova condizione del lavoro diventa sempre più privata dei diritti, degli ammortizzatori sociali, della democrazia stessa; il tutto diventa precario, senza alcuna sicurezza di continuità.
“Il precario si trova, oltre che in un confine incerto tra occupazione e inoccupazione, anche in un non meno incerto riconoscimento giuridico dinanzi alle garanzie sociali. Flessibilità, deregolamentazione del rapporto di lavoro, assenza di diritti. Qui la flessibilità non è ricchezza. La flessibilità, per la parte contraente più debole, la forza lavoro, è un fattore di rischio, e l’assenza di garanzie accresce questa debolezza. In questa guerra di logoramento la forza lavoro è lasciata completamente scoperta, sia rispetto al proprio lavoro presente, per il quale non possiede certezze spesso neanche di pagamento, sia rispetto al futuro, come sicurezza di reddito, dato che nessuno lo assicura dai momenti di in occupazione” [3]
Tutto ciò si aggiunge e non si va a sostituire alle cosiddette vecchie forme di povertà. I dati ufficiali continuano a segnalare che nei vari Sud del mondo sono più di 100 milioni i bambini che vivono sulla strada, sono 250 milioni i bambini che lavorano, più di 300 milioni di bambini sono soldati e più di un milione di donne giovani sono obbligate a prostituirsi. E tali dati non considerano il “profondo Sud” dove qualsiasi stima è impossibile. Basta ricordare solo che l’80% della popolazione del mondo vive nei paesi del Terzo mondo ed ha a sua disposizione meno del 20% della ricchezza mondiale ed ogni anno oltre 14 milioni di bambini muoiono prima di arrivare a 5 anni. A ciò si aggiunge il fatto che “Un terzo della popolazione che vive nei paesi più poveri - che sono soprattutto paesi africani - ha una speranza di vita alla nascita che non supera i 40 anni...., oltre 1 miliardo di persone non ha accesso all’acqua potabile, 850 milioni di adulti sono analfabeti, 325 milioni di bambini abbandonano le scuole elementari, 700 milioni di persone lavorano con remunerazioni inferiori al livello di sussistenza “ [4]. Questa è la situazione.
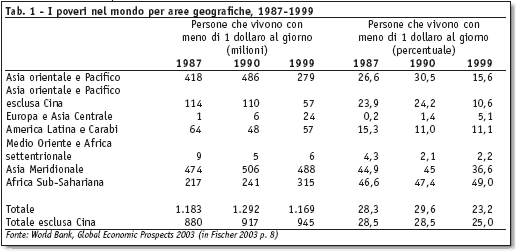
Per dare un idea del problema della povertà basta pensare che nel 2001 oltre 1 miliardo e 200 milioni di persone non aveva neanche un dollaro al giorno per soddisfare tutte le proprie necessità di vita (nell’Africa sub-sahariana il 48% della popolazione e nel sud dell’Asia, il 40% hanno meno di un dollaro al giorno mentre in America Latina il 16% della popolazione vive ancora con meno di un dollaro al giorno). Mentre sempre va ricordato che un settimo della popolazione mondiale possiede i quattro quindi della ricchezza, consuma il 70% dell’energia globale e l’85% del legno del pianeta.
2. La disinformazione statistica e la povertà... da lavoro
Ma come misurare la povertà? Chi viene ritenuto povero e perché, in base a quali criteri?
Come convezione all’interno della Unione Europea si è adottato come limite - soglia della povertà un valore pari al 50% del reddito medio europeo pro capite, e quindi “viene considerato povero colui che percepisce annualmente una quota di denaro pari o inferiore al 50% del reddito annuale medio pro capite europeo”.

Nel Primo “Rapporto sulla povertà in Europa” dell’anno 2002 emerge che, dato come indicatore della soglia della povertà la metà del reddito medio, tra gli Stati membri dell’Unione la percentuale più elevata della popolazione povera tra il 1987 e il 1997 si registra in Italia (14,2%) e nel Regno Unito (13,4%).
In realtà però questo metodo analizza solo in modo aritmetico il problema in quanto, stabilendo la percentuale di coloro che sono al di sotto del 50% del reddito medio pro capite, si ha una estesa generalizzazione della situazione e non si comprende quale siano le differenze esistenti all’interno della classe dei soggetti al di sotto del “50% di reddito medio pro capite”.
Inoltre non va sottovalutato un altro elemento: la crescita del reddito pro capite medio in Europa, ad esempio, è sinonimo di una maggiore ricchezza o piuttosto è dovuto ad una diminuzione delle nascite e quindi della popolazione totale? Ed ancora: per misurare la povertà il conteggio deve essere fatto su base individuale o familiare?
Ad oggi comunque non vi è un indicatore generale valido in assoluto per la misurazione della povertà; non sussiste un limite fisso e valido entro cui collocare una persona tra i poveri o meno; non vi è neppure una unità di base sicura sulla quale lavorare (che sia reddito o che sia consumo) [5].
Tra le ipotesi studiate per misurare la povertà vi è l’indicatore dello sviluppo umano HDI (Human Development Index), che si basa sulla “speranza (o aspettativa) di vita”; sul livello di alfabetizzazione raggiunto dal paese considerato, sul tasso di iscrizione alla formazione scolastica; ed infine dal reddito pro capite. Con questo indicatore si calcola (in percentuale o in valori relativi da 0 a 1) il valore di ogni singola voce, poi si fa una media aritmetica per ogni paese considerato, per avere l’indice di sviluppo umano richiesto.
È interessante notare nella tabella n. 3 l’applicazione di questo indicatore HDI nei paesi industrializzati per l’anno 1997.
L’Italia e la Gran Bretagna raggiungono una percentuale più alta di poveri rispetto anche a paesi come Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia. I motivi della povertà in Europa - secondo il rapporto - sono da attribuirsi alle ripercussioni geopolitiche del crollo dell’Unione Sovietica e del blocco dell’Est, che ha causato la nascita di oltre 150 milioni di “nuovi poveri”.
A ciò si aggiunge la “recrudescenza dei conflitti nel mondo - compresa l’Europa orientale” che ha causato un aumento del numero di rifugiati, richiedenti asilo e immigrati. Da ultimo ma non ultimo come importanza si aggiunge l’accelerazione del processo di globalizzazione neoliberista, “occasione per una più grande ingiustizia”, denuncia il Rapporto. Infatti si sono globalizzati anche “la tratta di esseri umani, il traffico di stupefacenti e il terrorismo internazionale” [6].
Si evidenzia ancora la sproporzionata distribuzione delle risorse; ad esempio nel Regno Unito il 20% dei ricchi gode del 43% delle risorse disponibili mentre il 20% dei poveri utilizza soltanto il 6,6%.
Tra i nuovi poveri ci sono poi i disoccupati, i lavoratori poveri, gli anziani, le famiglie numerose.
“Disoccupati e “working poor”. La disoccupazione, soprattutto quella di lungo periodo (oltre 6 mesi), rappresenta una delle principali cause della povertà, collegata all’analfabetismo o a una scarsa formazione e acquisizione di competenze, ritenute “insufficienti per rispondere alle esigenze del mondo tecnologico attuale, in continuo cambiamento”. I disoccupati - soprattutto giovani, persone di mezza età e disabili, fisici o psichici - si trovano in tutta Europa: in Austria, ad esempio, il 32% dei disoccupati di lungo periodo vive sotto la minaccia della povertà. Nel 2000 il tasso di disoccupazione in Finlandia è aumentato del 9,8%: un dato che comprende il 21,4% dei giovani fra i 15 e i 24 anni. La Polonia, nel 2001, contava circa 3 milioni di disoccupati.
Poi ci sono i lavoratori poveri (“working poor”) a motivo dei salari esigui; fra loro anche medici e insegnanti. Nella Federazione russa e in Ucraina i bassi stipendi (circa 30 euro al mese), oltre ai ritardi nei pagamenti, provocano esodi di massa; per la scarsa retribuzione solo a Istanbul, in Turchia, oltre un milione di persone soffrivano di denutrizione lo scorso anno. Questa situazione incentiva, come “effetti collaterali”, conseguenze sociali negative: dalla tossicodipendenza in crescita fra i giovani norvegesi e slovacchi, all’alcolismo, che in Polonia coinvolge circa un milione di persone.
Gli anziani. In 17 Paesi europei - compresa l’Italia, in particolare il centro-nord - gli anziani sono fra i più poveri della società, per le pensioni troppo esigue. In Belgio, ad esempio, le pensioni rappresentano il 37% di un salario medio; in Bulgaria la pensione sociale media si aggira intorno ai 40 euro e quella minima ammonta a 23 euro. In un’Europa in cui la crescita demografica registra dati negativi e l’aspettativa di vita si allunga, gli anziani rappresentano “una delle fasce più importanti della società”, commenta Caritas Europa. “Dopo aver pagato per decenni contributi economici, le persone anziane dovrebbero avere la possibilità di vivere una vecchiaia serena”.
All’alba del terzo millennio il numero dei bambini che vivono in stato di povertà è causa di allarme. Un fenomeno che sembra riguardare 17 milioni di bambini in Europea. In alcuni stati 3 bambini su 10 vivono in famiglie con un reddito che è al di sotto del 60% rispetto alla media nazionale, ovvero la soglia per calcolare lo stato di povertà ormai ampiamente accettata in tutta Europa. All’interno dei Paesi dell’Unione Europea la situazione è molto diversa: si va da un minimo del 5,5% di bambini che vivono questa condizione in Svezia alla situazione della Gran Bretagna dove i minori in difficoltà risultano pari al 30,1%. Il secondo paese dopo la Gran Bretagna è proprio l’Italia con il 28,8% di minori in stato di povertà.” [7]
Non ci sono indicatori statistici che riescono a misurare con un livello certo l’insieme di queste condizioni di povertà, che evidenziano in tutta Europa un appiattimento verso il modello USA, con la “vecchia povertà” che si accompagna alle “nuove” forme di povertà da lavoro.
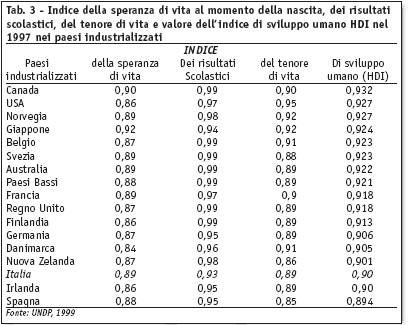
3. La via europea al capitalismo selvaggio: convivere con la povertà da lavoro
È molto importante evidenziare quanto riferito mercoledì 17 dicembre 2003 nella sede dell’UE a Bruxelles:
- BRUXELLES, 17 DIC - In tutta l’Unione europea è a rischio povertà il 15% della popolazione con grandi differenze tra paese e paese: dal 10% della Svezia al 21% dell’Irlanda. Per l’Italia invece il rischio, secondo i dati del 2001, riguarda una percentuale del 19%, così come per la Spagna. Ma il dato sale al 25% per la fascia di età dai 18 ai 24 anni: un giovane su quattro in Italia, così come in Spagna e in Portogallo, è a rischio povertà. È quanto rileva un rapporto della Commissione europea, in base al quale seppure la percentuale di poveri negli ultimi anni sia progressivamente diminuita, più di 55 milioni di persone e un bambino su cinque sono minacciati dalla povertà..
L’esecutivo europeo indica che la strada da seguire per raggiungere l’obiettivo di Lisbona, di sradicare totalmente la povertà entro il 2010, è un impegno coordinato tra gli Stati, la società civile e le autorità locali e regionali [8].
In sostanza negli anni che vanno dal 1995 al 2001 pur essendo diminuita la percentuale di persone a rischio completa povertà (si è passati dal 17% al 15%) restano comunque oltre 55 milioni le persone minacciate. Tra queste i giovani e i minori sono tra le categorie più a rischio anche perché pesa molto l’abbandono scolastico (l’Italia ha una percentuale del 29% a fronte di una media europea del 18,5%).
Uno studio della Commissione europea evidenzia che i paesi che investono maggiormente nella protezione sociale (come quelli del Nord Europa) registrano i più bassi livelli di povertà (ad esempio la Svezia ha solo il 10%).
“Sei le priorità indicate oggi dall’esecutivo guidato da Romano Prodi per poter raggiungere l’obiettivo di Lisbona, ossia quello di eliminare la povertà entro il 2010: investire in politiche attive del mercato del lavoro, favorire appropriati sistemi di protezione sociale, promuovere l’accesso all’abitazione di coloro che sono più a rischio povertà, concentrare gli sforzi per prevenire l’abbandono prematuro della scuola e facilitare un passaggio dolce dalla scuola al lavoro, contrastare la povertà infantile e quella degli immigrati e delle minoranze etniche. La strada da seguire, per Bruxelles, è quella di un sempre maggiore coordinamento tra gli stati, di un maggior coinvolgimento delle realtà territoriali e locali e della società civile.” [9]
Il Patto di Stabilità e Crescita approvato nel 1997 ha cominciato la sua verifica nel 1998, anno in cui i criteri del trattato di Maastricht sono stati attuati nei paesi dell’UE. I dati dell’Euro Panel (ECHP), dell’anno 1997 (ultimo anno disponibile) evidenziano che “il reddito netto mediano familiare equivalente rilevato nei 14 Paesi dell’Unione Europea era di circa 11.623 unità standard di potere d’acquisto; rispetto a questo valore si possono distinguere due gruppi di Paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Olanda e Regno Unito caratterizzati da livelli di reddito superiori alla media europea; Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo, Spagna e Svezia, con livelli di prosperità al di sotto della media” [10].
Negli anni che vanno dal 1994 al 1997 in Italia si è avuto un aumento del divario tra i livelli di reddito familiari nazionali da quelli medi europei, diversamente dalla Grecia, Portogallo e Spagna, paesi nei quali questa differenza è diminuita.
Di solito nei paesi UE con bassi livelli di reddito vi sono disuguaglianze distributive maggiori e viceversa; gli unici due paesi che non rispondono a questi criteri sono il Regno Unito e il Belgio che hanno alti livelli del reddito familiare nonostante gli alti valori dell’ “indice di Gini”, che descrive il livello delle disuguaglianze distributive.
Tra i paesi con una migliore distribuzione del reddito vi sono la Finlandia, la Danimarca, la Svezia e l’Irlanda mentre Grecia, Italia, Portogallo e Spagna sono quelli con la peggiore redistribuzione.
“Relativamente al problema della povertà, nel 1997 il 17,7% dei cittadini dell’Unione europea viveva in una famiglia con reddito inferiore alla linea nazionale di povertà. Le percentuali più elevate si registravano in Portogallo (23,5%) nel Regno Unito (22,4%) e in Grecia (22,3%) mentre quelle più basse in Danimarca (8%) e in Finlandia (8,5%). L’Italia era caratterizzata da un valore superiore alla media europea (19,2%). Tra il 1994 ed il 1997 si è comunque assistito ad una diminuzione del livello medio europeo dell’incidenza della povertà: se nel 1994 la percentuale di individui poveri nell’Unione europea era pari a 18,6%, nel 1997 questa percentuale si era ridotta a quota 17,7%. Ad eccezione della Svezia, sono le donne ad essere maggiormente interessate dal fenomeno rispetto agli uomini; anche le fasce d’età più giovani (0-16 anni) sono caratterizzate in tutti i Paesi ad esclusione della Svezia, Grecia, Finlandia e Danimarca da un tasso di povertà superiore alla media nazionale” [11].
Nei paesi dell’Unione la percentuale di popolazione che risulta essere povera per più di due anni consecutivi raggiunge una percentuale dell’11%. Questo valore arriva all’8% per persone povere da più di 3 anni e al 7% per persone povere per oltre 4 anni. Il Portogallo risulta essere il paese con la più alta percentuale di povertà persistente, in quanto l’11,8% della popolazione resta in condizione di povertà mediamente per 4 anni consecutivi. Il paese invece con la minore diffusione di povertà risulta essere la Danimarca.
Per quanto riguarda le retribuzioni nei paesi dell’Unione Europea lo sviluppo dei principi di flessibilità occupazionale e l’adesione al Trattato di Maastricht hanno portato ad un progressivo impoverimento dei salari con una conseguente diminuzione del peso dei redditi da lavoro sul PIL. Anche per la struttura e l’andamento del salario indiretto le condizioni europee tendono ad avvicinarsi sempre più alle determinanti del capitalismo selvaggio anglosassone. Infatti se si analizzano i sistemi di protezione sociale è evidente che negli ultimi 20 anni si è avuto un progressivo deterioramento di ogni sicurezza e di welfare. Infatti in tutti i paesi dell’UE sono stati avviati processi di riforma anche radicale dei precedenti sistemi di protezione sociale e nei mercati del lavoro, fino a giungere ad intensi processi di privatizzazione della sanità, della previdenza, dell’assistenza. A risentirne sono ovviamente le fasce più deboli della società, quelle prive di lavoro e quelle sempre più numerose dei lavoratori intermittenti, precari e atipici in genere. C’è anche un dato importante da evidenziare che riguarda la popolazione rientrante nella fascia cosiddetta della “terza età”. “Sono più di 60 milioni le persone che nei 15 Paesi dell’Unione europea hanno oltre 65 anni di età. Un esercito che rappresenta il 15% della popolazione totale, destinato a superare la soglia del 20% entro il 2020....... La logica dell’invecchiamento della popolazione richiede di essere reinterpretata, utilizzando gli anziani forti e vitali che sono alla ricerca di una ‘piena cittadinanza’ sotto ogni profilo”. Secondo il Rapporto ‘Essere anziano oggi’, il 90% delle persone ‘mature’ si trovano in condizioni discrete pur convivendo con qualche disagio. Per l’Italia il 12,6% degli anziani, si legge nel rapporto, dichiara di avere ‘qualche problema’ pur rimanendo autosufficiente. Questa categoria rappresenta solo il 5,6% in Francia, il 6% in Germania, il 10,2% in Gran Bretagna e il 10,7% in Spagna. Differenze sostanziali anche per quanto riguarda la condizione economica. Le famiglie anziane con un reddito superiore ai 1.000 euro passano dal 24,3% in Spagna fino al 90,6% in Francia. In Italia, la percentuale si attesta al 42,8%, in Gran Bretagna al 49,2% e in Germania al 78,5%... E allora, parte l’appello alle istituzioni europee perché vengano incontro alle esigenze della popolazione over 65... Secondo la ricerca - sottolinea Delai - le risorse economiche che gli anziani sono in grado di trasferire alla famiglia arrivano a 82 miliardi di euro l’anno, pari al 15% del totale delle spese delle famiglie italiane”. [12]
La tabella n. 4 evidenzia la percentuale delle persone a rischio povertà in ogni paese dell’Unione Europea per gli anni 1995 e 2001.
Ma il precedente dato va supportato e analizzato in funzione della potenzialità di povertà derivante anche dalla disoccupazione e dal lavoro precario in genere. La tabella n. 5 riporta i dati disponibili a livello europeo ed evidenzia sia gli occupati che le persone in cerca di occupazione e in età lavorativa nell’UE a 15 paesi tra il 1993 e il 2000.
I dati dell’Eurostat riferiti a dicembre 2003 evidenziano che la disoccupazione nella zona dell’euro è dell’8,8% e dell’8% nell’UE a 15 (si consideri che nel dicembre dell’anno 2002 la disoccupazione era dell’8,6% nella zona dell’euro e del 7,9% nei paesi dell’UE a 15).
Se si considera la disoccupazione su base annuale l’Eurostat segnala che il Lussemburgo (3,9%), l’Olanda (4,1%), l’Irlanda (4,5%) e l’Austria (4,6) sono i paesi con tassi minori mentre la Spagna registra la percentuale più alta (11,2%).
Sempre a dicembre 2003 il tasso di disoccupazione per i giovani con meno di 25 anni è stato del 16,6% nella zona euro e del 15,4% nell’Ue a 15. [13]
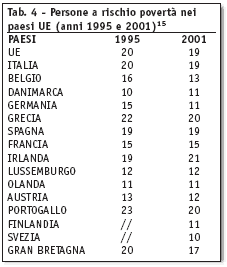
Per quanto riguarda il lavoro temporaneo i dati del 1995, registrano un valore di ore di lavoro temporanei pari 1.671.000 posti di lavoro a tempo pieno annuo nella sola Unione Europea. Il Regno Unito e l’Olanda sono i paesi che hanno utilizzato maggiormente il lavoro temporaneo: la percentuale di richiesta di questa forma di flessibilità è del 3,31% in Gran Bretagna e del 2,68 in Olanda; nel 1997 poi si parla di 880mila lavoratori temporanei occupati giornalmente nel Regno Unito e 225mila in Olanda.
-----
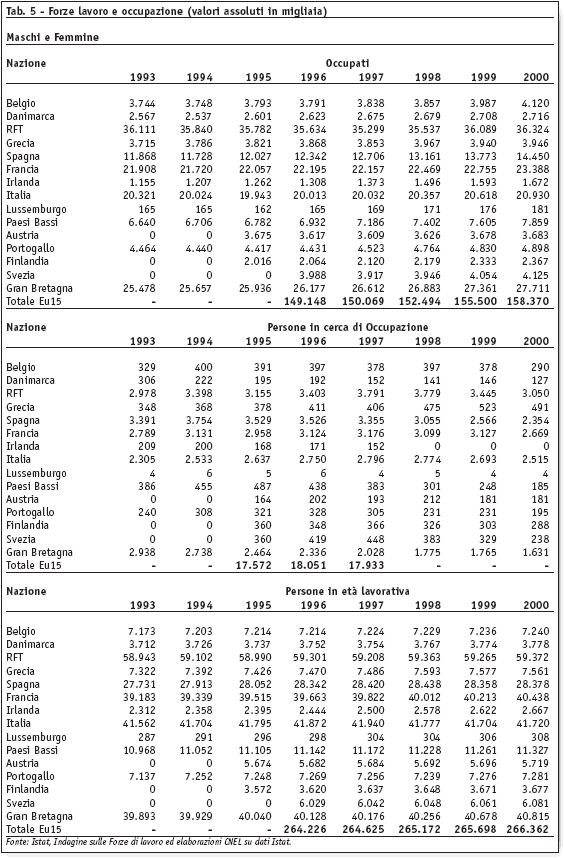
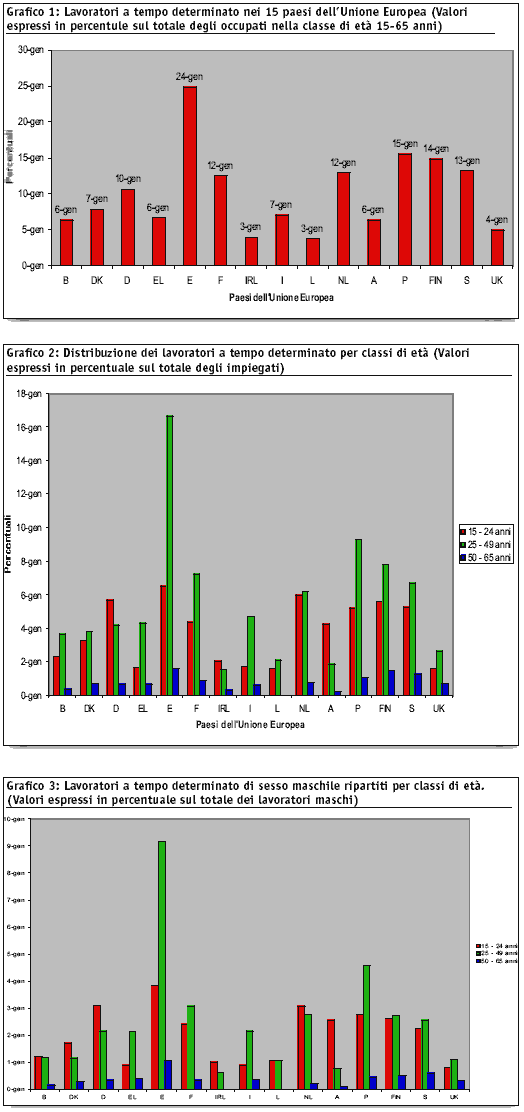
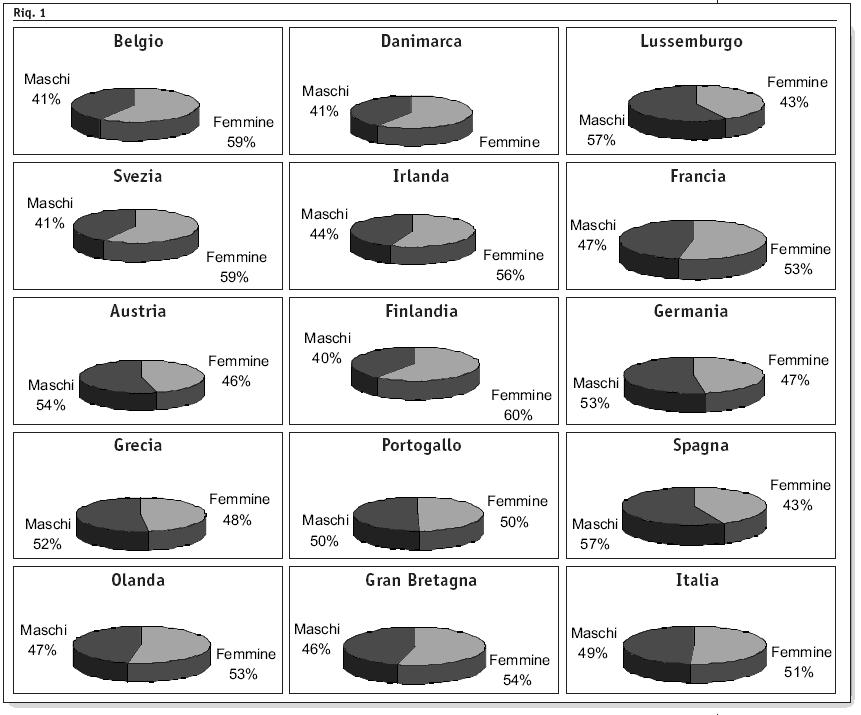
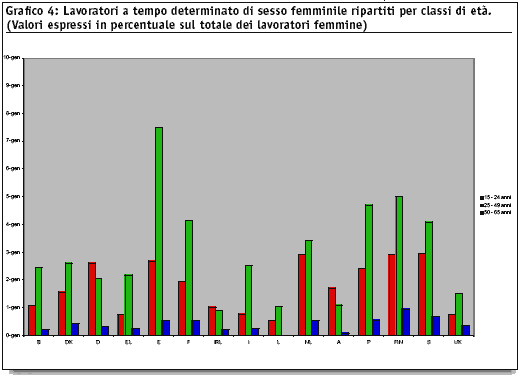
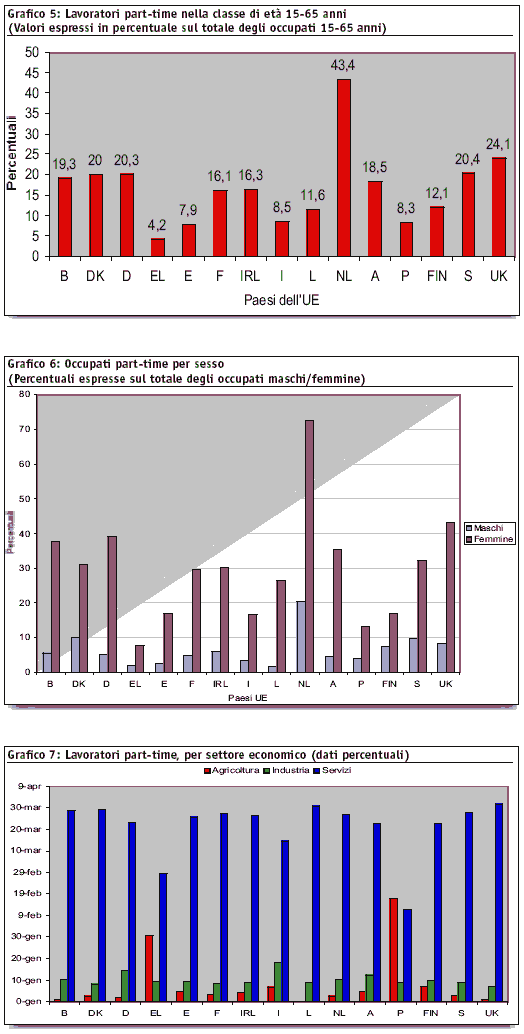
-----
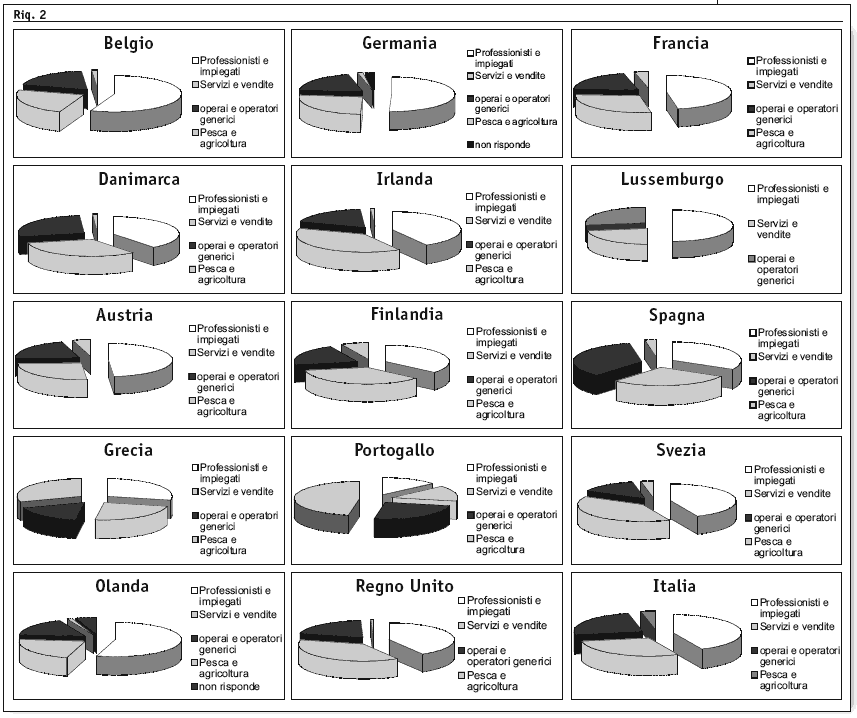
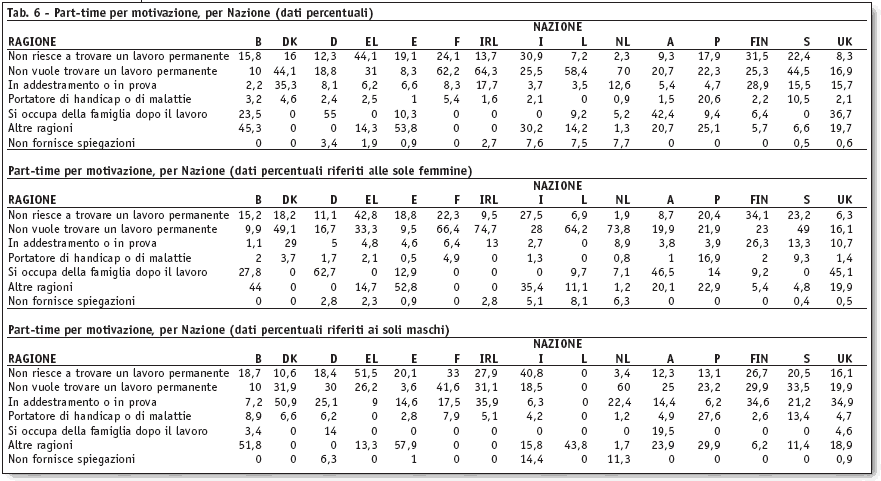

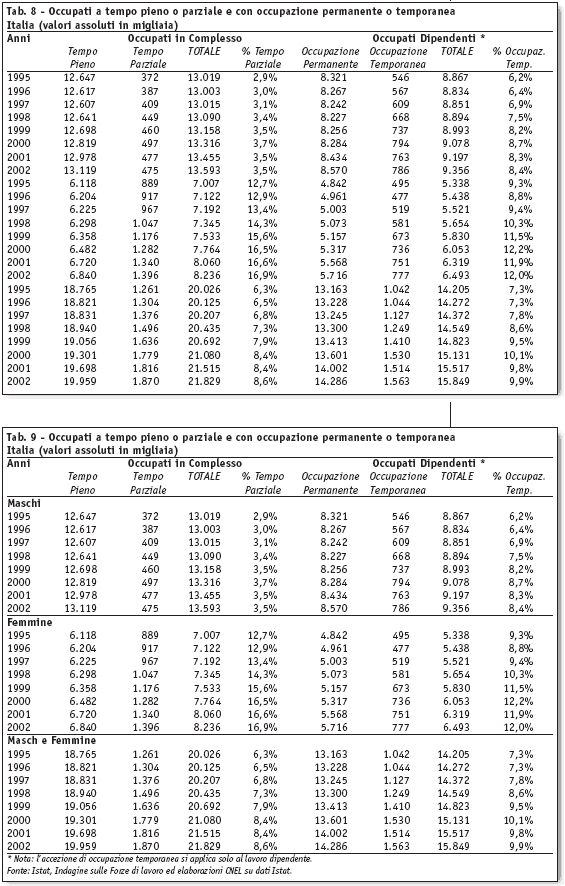
-----
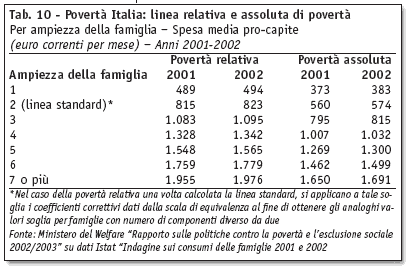
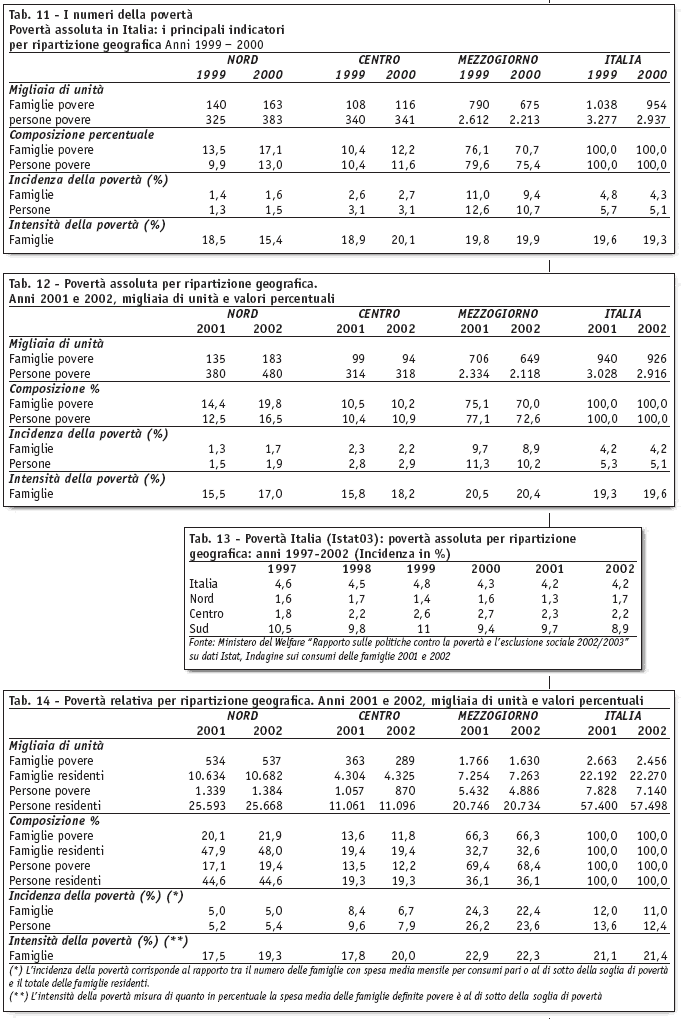
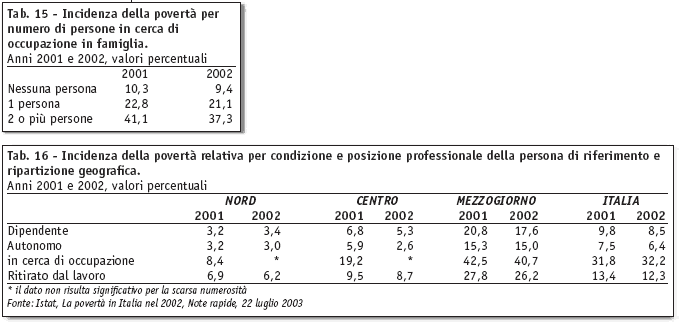
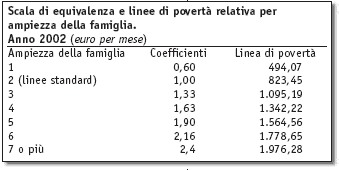
-----
Si evidenziano di seguito le caratteristiche prevalenti (età, istruzione, settore economico di impiego) dei lavoratori a tempo determinato per ciascun paese dell’Unione Europea.
I dati, relativi al 2002, sono ricavati dall’indagine annuale sulle forze di lavoro condotta dall’Eurostat.
Le tabelle di tale indagine considerate in questa analisi sono:
• Table 29: Temporary employees by age group (15-65) and educational attainment level (valori espressi in migliaia)
• Table 30: Temporary employees by economic activity (valori espressi in migliaia)
I dati, espressi in valore assoluto, sono stati opportunamente trasformati in percentuali, sia in riferimento al totale degli occupati, sia al totale dei lavoratori a tempo determinato. I valori mancanti sono stati ricavati attraverso opportuna interpolazione.
Si considerano, inizialmente, la percentuale dei lavoratori a tempo determinato sul totale degli impiegati nei paesi membri dell’Unione Europea, nella fascia di età 15-65.
Si nota subito come la Spagna si distingua dagli altri paesi per una maggiore incidenza di questo tipo di occupati (24,8%).
È importante notare, come in questo paese un lavoratore su quattro ha un contratto a scadenza. Seguono, benché su valori percentuali nettamente più bassi, la Francia (12,5%), il Portogallo (15,5%), la Finlandia (14,9%), la Svezia (13,2%) e la Germania (10,6%), con quota di lavoratori a tempo compresa tra il dieci e il quindici per cento.
Gli altri paesi, Italia compresa, si collocano su valori inferiori al 10%.
Meritano un attenzione particolare l’Irlanda, il Lussemburgo e la Gran Bretagna, che si attestano su valori inferiori al 5%, denotando uno scarso interesse verso una politica lavorativa a breve termine. Si analizza poi la ripartizione in classi di età dei lavoratori a tempo determinato, dapprima sul totale degli occupati e successivamente tenendo conto della divisione per genere.
Le classi di età considerate sono:
• 15-24 anni
• 25-49 anni
• 50-65 anni
Austria, Germania e Irlanda presentano un andamento decrescente, con i giovani che costituiscono la parte più rilevante di lavoratori con contratto a tempo. Negli altri paesi dell’Unione Europea si riscontra una prevalenza di occupati a tempo nella fascia 25-49 anni, con punte superiori al 6 % in Francia, Spagna, Portogallo, Finlandia e Svezia. Resta da evidenziare come, nei paesi considerati, la quota dei lavoratori di questo tipo, tra i 50 ed i 65 anni, non superi mai il 2 %.
Di seguito si mostra, nel Riquadro 1 attraverso dei grafici “a torta” per ogni paese, la composizione per sesso dei lavoratori a tempo determinato.
Irlanda, Belgio, Finlandia, Svezia, Danimarca presentano una percentuale maggiore di lavoratrici a tempo determinato, mentre in Spagna, Lussemburgo e Austria sono i maschi ad avere la prevalenza. Nei restanti paesi, non emergono differenze significative.
Si analizza ora la composizione dei lavoratori a tempo determinato, sia maschi che femmine, per classi di età.
Guardando i dati riferiti alle lavoratrici divisi per classi di età, emerge una maggiore quota di occupati nella fascia 25-49 anni, tale tendenza non si riscontra negli uomini, ad eccezione dei paesi della penisola iberica.
L’analisi dei lavoratori a tempo determinato per sesso e classi di età denota una maggiore percentuale di donne verso un lavoro a tempo determinato anche in età adulta; questo non accade negli uomini per i quali questo tipo di contratto rappresenta probabilmente l’inizio di collaborazione lavorativa in attesa di un impiego a tempo prolungato.
In Spagna e Portogallo, l’andamento degli occupati a tempo assume un comportamento speculare sia in riferimento alle classi di età che al sesso, sottolineando non solo il “massiccio” utilizzo di contratti provvisori, ma anche l’insufficienza di sbocchi professionali a tempo indeterminato dai 25 anni in poi.
Si sono analizzate di seguito le caratteristiche prevalenti dei lavoratori part-time dei paesi dell’Unione Europea. I dati, relativi al 2002, sono ricavati dall’indagine annuale sulle forze di lavoro condotta dall’Eurostat.
Le tabelle di tale indagine considerate in questa analisi sono:
• Table 36: Part-Time employment by economic activity (valori espressi in migliaia)
• Table 38: Part-Time employment by reason (valori espressi in percentuale sul totale dei lavoratori part-time)
• Table 30: Part-Time employment as percent of each age group total employment (valori espressi in percentuale sul totale degli occupati, sul totale degli occupati maschi/femmine)
I dati relativi alla originale Table 36 sono stati trasformati in percentuali sul totale dei lavoratori part-time. I dati mancanti sono stati ricavati con degli opportuni metodi di regressione lineare.
Di seguito si riporta la percentuale di lavoratori part-time sul totale degli occupati, i dati sono relativi alla classe di età 15-65.
Si nota, che in Olanda il 43,4% degli occupati presentano un impiego part-time. Seguono con una percentuale compresa tra il 10 ed il 20 %, tutti gli altri paesi ad eccezione dell’Italia (8,5%), la Spagna (7,9%), il Portogallo (8,3%) e la Grecia (4,2%). Questo tipo di contratto ha molta presa in quasi tutti i paesi del centro e del nord Europa, mentre trova scarso utilizzo nei paesi spiccatamente mediterranei.
Si osserva ora se l’occupazione part-time è utilizzata allo stesso modo dagli uomini e dalle donne. Le percentuali riportate sono ottenute sul totale degli occupati uomini o donne nella classe di età 15-65.
Si nota subito come in tutti i paesi dell’Unione Europea, la percentuale di donne occupate con contratto part-time è nettamente superiore a quella degli uomini. In Olanda più del 70% delle donne occupate ha un impiego “ a tempo ridotto”, seguono la Gran Bretagna, l’Austria, la Germania e il Belgio con valori prossimi al 40 %. Per gli uomini, il paese con il maggior numero di lavoratori part-time risulta ancora l’Olanda, dove un lavoratore su cinque ha questo tipo di contratto.
Gran Bretagna, Germania e Svezia presentano percentuali vicine al 10%, mentre tutti gli altri paesi si attestano su valori più bassi. Analizziamo ora come si distribuiscono i lavoratori part-time nei principali settori economici: agricoltura, industria e servizi. I valori, espressi in percentuale, sono ottenuti sul totale dei lavoratori appartenenti a questa categoria.
Il part-time è utilizzato prevalentemente nel settore dei servizi, ad eccezione del Portogallo, dove questo tipo di contratto è sfruttato di più in agricoltura. Nei paesi considerati l’industria assorbe mediamente il 10 % dei lavoratori part-time, tranne che in Italia dove questo dato sfiora il 20 %.
Segue, per ogni paese, la distribuzione degli impiegati part-time per categorie professionali, evidenziate attraverso dei grafici “a torta” nel Riquadro 2.
Osservando come si distribuiscono gli occupati part-time per tipologia di impiego, si colgono alcune interessanti peculiarità dei paesi considerati.
In tutti i paesi UE la maggioranza relativa dei part-time è collocata tra i professionisti e gli impiegati, ad eccezione di Grecia e Portogallo, dove è invece importante la presenza di occupati nel settore agricolo ed in quello della pesca. Servizi e vendite hanno un andamento significativo comune a tutti i paesi. Per quanto riguarda gli operai e gli operatori generici, si nota come il contratto part-time sia molto utilizzato in Spagna (35,9 %) mentre si ricorre scarsamente ad esso in Svezia (14,1 %); negli altri paesi assume valori intorno al 20 %.
Le motivazioni che portano ad un impiego part-time sempre più frequentemente non dipendono dalla volontà del lavoratore. Più spesso risulta essere una scelta obbligata. In quasi tutti i paesi considerati, ed in particolare in Grecia ed in Italia, la ragione che porta a questa occupazione parziale è la difficoltà a trovare un posto permanente, con delle eccezioni, nello specifico Francia, Olanda e Irlanda.
Nei paesi scandinavi il part-time sembra essere utilizzato per i periodi di addestramento e di prova, tale massiccio utilizzo anticipa quasi sempre un contratto a tempo determinato.
Quelli presentati sono soltanto alcuni dati ufficiali che sottostimano fortemente, anche per le modalità di rilevazione, l’entità della disoccupazione reale, del lavoro precario, a tempo, atipico e comunque a salario bassissimo.
4. Una panoramica europea: vivere (!!!)...di solo pane
In questa sezione si vuole segnalare, come sempre attraverso i dati ufficiali, il dramma della povertà che si “tocca” nei paesi a capitalismo maturo, semplicemente dando una prima idea della situazione esistente in alcuni dei più rappresentativi paesi appartenenti all’Unione Europea. Si cercherà di analizzare il fenomeno della povertà in relazione anche ai programmi messi in atto dai vari governi per cercare di risolvere il problema, considerando, come si è visto nel paragrafo precedente, che parallelamente si flessibilizza, meglio si precarizza il mercato del lavoro determinando una condizione “normale”, tipica dell’ “atipicità” del lavoro per realizzare così una condizione permanente di precarizzazione del vivere sociale.
GERMANIA
Il governo nell’anno 2001 ha presentato vari progetti per ridurre il problema della povertà: un Rapporto su Povertà e ricchezza, un Piano Nazionale di Azione per combattere la povertà e l’esclusione sociale ed un Programma di azione 2015: riduzione della povertà, responsabilità globale.
Il Rapporto su Povertà e ricchezza ha rilevato che vi è stato un aumento nella disparità di reddito in quanto il rapporto 90/10 [14] si è aggravato in 10 anni passando da 3,04 nell’anno 1988 a 3,26 nel 1998 a conferma del gap sempre maggiore tra ricchi e poveri. Sempre nel 1998 l’11% delle famiglie rientrava nella fascia di povertà relativa. La disoccupazione riguarda più di 4 milioni di persone di cui più di 1,5 milioni sono disoccupati di lunga data. Altro fattore importante rilevato nel Rapporto è l’esistenza di un ampio settore di persone che pur lavorando fanno parte della fascia di poveri, in quanto soggetti a contratti cosiddetti atipici e a basso salario.
La tabella n. 7 mostra che nel 1998 il 9,1 % della popolazione era da considerarsi in stato di povertà; interessante è la differenza esistente tra le due Germanie (i valori sono dell’8,7% per la Germania ovest e del 10,7% per la Germania dell’est).
Nel bilancio nazionale dell’anno 2002 soltanto 92,2 miliardi di euro sono stati assegnati ai problemi del lavoro e ai problemi sociali. Nel settore dell’assicurazione pensionistica è stato aggiunto un assegno di anzianità collegato all’accertamento dei redditi e si è cercato di risolvere il problema di un aumento delle pensioni alle donne ma la grande svolta verso le pensioni private riduce considerevolmente l’efficacia di questi programmi. Anche nel settore della sanità si sono avute significative diminuzioni di servizi in determinate aree e ciò ha portato ad una sofferenza delle famiglie a più basso reddito che non possono permettersi l’assistenza sanitaria privata. Alla faccia del modello renano di tipo sociale!!
SPAGNA
In questi ultimi anni la Spagna ha dato di sè una rappresentazione ottimista della realtà, sbandierando i successi ottenuti in campo economico considerato un paese a capitalismo maturo al punto di dichiararsi una grande potenza mondiale. Attualmente occupa il sesto posto fra i paesi industrializzati in materia di investimenti diretti esteri ed è ottava nella ricezioni degli investimenti. Ma ciò nonostante i dati sulla evoluzione della povertà mostrano solo una piccola diminuzione della povertà relativa. Il tasso di povertà (ossia il reddito mensile equivalente al 50% del reddito medio) era circa del 18% nel 1994, del 17,6% nel 1995 e del 17,5% nel 1996. Nello stesso periodo la povertà assoluta (25% del reddito medio) è rimasta stazionaria attorno al 3%.
Inoltre va evidenziato che la Spagna negli anni 1994-96 registrava un tasso di povertà permanente del 9,8% a fronte di un tasso di povertà relativa del 17-18%. Nell’anno 1998, più di cinque milioni di famiglie prendevano aiuti finanziari. È importante, comunque, sottolineare che l’indennità di disoccupazione ha un ruolo fondamentale nella protezione sociale, seguita subito dopo dall’integrazione della pensione minima.
REGNO UNITO
Il Regno Unito più di altri paesi europei ha registrato un aumento delle disparità di reddito negli ultimi 20 anni. Dal 1998 tale disparità ha continuato a crescere e nel 1999-2000 più del 23% della popolazione sopravviveva in condizioni di povertà. Le politiche di privatizzazione sfrenata adottate in questo paese hanno fatto si che le disuguaglianze di trattamento in ambito lavorativo, ma anche in campo sanitario, abitativo ecc. divenissero sempre più marcate.
Solo di recente le politiche del governo hanno iniziato a porsi il problema della soluzione della povertà attraverso aumenti di indennità, di assistenza sociale, ecc. Il governo afferma che grazie a queste nuove politiche dal 1997 ad oggi si è avuta la riduzione di oltre 1 milione nel numero di bambini che vivono sotto la soglia di povertà, anche se solo 28 dei 50 indicatori economici fondamentali hanno evidenziato un miglioramento negli anni a noi più vicini.
In realtà però l’analisi dei bilanci delle famiglie rileva che le tasse sul reddito incidono per il 37,1% sul reddito lordo delle famiglie e distribuito in maniera tale da pesare per il 35,7% per il decimo più ricco della popolazione mentre arriva al 47,7% per il decimo più povero. Anche se recentemente il governo si è detto impegnato ad accrescere la spesa per la sanità (per cercare di avvicinarla alla media europea) in realtà diversi centri studi economici anche filogovernativi sostengono che con gli interventi in atto non diminuiranno ma si accresceranno le disparità sociali poiché è il mercato del lavoro che già in partenza discrimina in quanto è sempre più alta la percentuale di precari e lavoratori poveri.
È interessante riportare alcuni passi di un libro scritto da “Polly Toynbee, una delle giornaliste di punta del quotidiano The Guardian,. Il libro intitolato “Hard Work: Life in Low-Pay Britain” (Edizioni Bloomsbury) analizza con molta efficacia la situazione della Gran Bretagna sottopagata.
“Smessi gli abiti della commentatrice, Toynbee ha indossato quelli di portiera d’ospedale, impacchettatrice di torte, intervistatrice per ricerche di marketing, dipendente di una casa di cura.
Per mesi ha vissuto in un appartamentino assegnatole dal “council” (una casa popolare) in uno degli estate più poveri di Londra, Clapham Park East. Ha percorso mille volte la strada dalla sua casa popolare al “job centre” (l’ufficio di collocamento) per cercare lavoro, al “benefits office” (l’ufficio sussidi) per sapere se aveva diritto a qualche sussidio.
Ha vissuto insomma la vita di quel terzo di popolazione della Gran Bretagna sotto il “New Labour” che lei definisce “deserving poor”, cioè “i poveri meritevoli”, quei milioni di persone che lavorano anche più di quarantotto ore alla settimana per cercare di strappare i loro figli al deserto sociale che li circonda.
Sono uomini e donne di tutte le età che, nonostante gli orari di lavoro massacranti, a fine mese riescono a malapena a far quadrare i conti. Ma non certo ad andare in vacanza, a fare il pieno di benzina, a comprare un computer.
Toynbee ritiene che la Gran Bretagna ha il più alto numero di poveri, l’orario di lavoro più lungo ed è il paese che spende meno per i servizi in Europa, nonostante che il governo di Toni Blair affermi di aver debellato la piaga dei bassi salari attraverso la “minimun wage”. Per avvicinarsi alla “soglia di decenza” stabilita dall’Unione Europea, scrive Toynbee, la “minimum wage” dovrebbe essere di 7 sterline e 32 pence l’ora (circa undici euro, ndr): ma Tony Blair ritiene che le attuali 4 sterline e 10 pence siano più che sufficienti.
Il “New Labour” è arrivato al governo nel 1997 e al centro del suo manifesto c’era, tra le altre cose, una promessa, o meglio un valore: il lavoro. Secondo Blair, il “New Deal” (il patto tra cittadini e stato) avrebbe consentito il reinserimento nel mondo del lavoro di tanti disoccupati. Il salario minimo avrebbe garantito almeno un lavoro pagato dignitosamente.
Se è vero che l’introduzione della “minimum wage” (nel 1999, 3 sterline e 60 pence l’ora) ha incrementato i salari di un milione e trecentomila persone è altrettanto vero che si è trattato di un numero molto inferiore a quello che aveva in mente il governo.
E questo perchè le 3 sterline e 60 pence iniziali erano troppo basse (le 4 sterline e 10 pence attuali non hanno fatto una grande differenza). Il messaggio - scrive Toynbee - è: lavorate, lavorate, lavorate, ma 4 sterline e 10 non sollevano nessuno dalla povertà. Infatti tre milioni e mezzo di poveri vivono in nuclei familiari che lavorano. Ci sono - sottolinea Toynbee - più lavoratori poveri che poveri disoccupati. Ci sono più lavoratori poveri che pensionati poveri. Questi lavoratori, che costituiscono la base dei nostri servizi pubblici, sono poveri perchè il lavoro che fanno è sottopagato.
Le professioni meno pagate nel 2002 erano concentrate nel settore delle pulizie, dell’assistenza (agli anziani, nelle case di cura o negli ospedali), del catering ma anche nella scuola (gli insegnanti di sostegno).
Rispetto al 1970, sottolinea la giornalista, oggi in Gran Bretagna sono tre volte di più i bambini che vivono al di sotto della soglia di povertà.
Se il decimo di popolazione “nata dalla parte fortunata” l’anno scorso si è vista incrementare il salario del 7.3%, il decimo di popolazione che sta “dall’altra parte” ha avuto in busta paga soltanto il 4.5% in più. Il paragone con il 1970 Toynbee lo fa perchè allora pubblicò un libro molto simile a quello uscito quest’anno. Si chiamava “A Working Life” ed era un’inchiesta sul salario e le condizioni di lavoro nel paese.
Oggi in “Hard Work: Life in Low-Pay Britain”, Toynbee torna a fare alcuni dei lavori che aveva fatto nel 1970 e arriva soprattutto ad una conclusione: il salario di oggi è, in termini reali, più basso di quello di trent’anni fa” [15]
In questo contesto la povertà è sentita come una sempre maggiore negazione dei principali diritti umani; ad esempio l’affluenza alle urne alle elezioni del 2001 ha registrato la sua punta negativa nelle fasce più povere della popolazione e la disaffezione verso tutte le istituzioni in genere è diventato fenomeno reale e di massa.
FRANCIA
La Francia è la quarta potenza economica mondiale dopo Stati Uniti, Giappone e Germania e ha rappresentato per lungo tempo un riferimento chiave di un capitalismo temperato e sociale europeo. Infatti lo Stato ha sempre avuto in questo paese un ruolo determinante nell’economia e ad oggi il 35% delle attività industriali e l’84% delle finanziarie sono controllate direttamente dallo Stato. L’economia francese si è sviluppata grazie ad una grande concentrazione delle imprese industriali e commerciali. I lavoratori in Francia sono circa metà della popolazione totale (26 milioni tra uomini e donne), di cui il 75% sono lavoratori dipendenti; vi è poi un 10% di disoccupati ufficiali.
Se si analizzano gli anni dal 1996 al 2000 si nota una leggera diminuzione del livello di povertà; si ricorda che in Francia la soglia al di sotto della quale si è considerati poveri è calcolata (per l’anno 2000) in 579 euro al mese per una persona e 869 euro per una coppia senza figli; per ogni figlio vanno aggiunti 174 euro di età minore ai 14 anni e 290 euro per ogni figlio con più di 14 anni). Il tasso di povertà relativa dell’anno 1996 era del 7,2% ed è sceso nel 2000 al 6,5%.
In questa situazione vanno analizzate le ultime novità in tema di sussidi sociali; infatti
“Da gennaio (2003), alcune cose sono cambiate. C’è la perdita del sussidio di disoccupazione per circa 200mila persone, dall’ 1 gennaio scorso, mentre ormai l’Ass, l’assegno accordato dallo stato ai disoccupati giunti alla fine del sussidio, non sarà più versato, come prima, a vita, ma solo per due anni (tre per chi già lo perpepisce). 372mla persone percepiscono l’Ass. Anche l’Rmi (il reddito minimo di inserimento) è cambiato, diventando Rma, reddito minimo di attività (non più versato dallo Stato ma dagli enti locali), con l’obbligo di accettare il lavoro proposto, pena la perdita del sussidio. 1.109.000 di persone percepiscono in Francia l’Rma oggi: tenuto conto della composizione familiare ci sono più di 2 milioni di persone che vivono con questo reddito minimo e che hanno pochissime possibilità di trovare un lavoro (dal `96 a oggi, solo la metà delle persone che hanno percepito l’Rmi ha trovato un lavoro e un terzo di esse è stato assunto con contratti che ricevono un aiuto pubblico, con una media di 610 euro al mese). Il governo Raffarin ha anche tagliato l’Ame, l’assicurazione malattia universale istituita dalla socialista Martine Aubry per offrire una copertura sanitaria a chi ne è escluso, in particolare i sans papiers. Più di 150mila persone potrebbero di nuovo trovarsi senza nessuna copertura in caso di malattia. Tre milioni di persone, secondo la Fondazione dell’Abbé Pierre, sono alloggiate in condizioni precarie. Il centro studi di Jacques Delors ha denunciato che un milione di bambini in Francia vivono in famiglie con un reddito al di sotto della soglia di povertà (per la Francia 1100 euro al mese), con gravi conseguenze per il loro futuro” [16].
5. La situazione italiana: l’economia della precarizzazione
In Italia (anno 2001), una famiglia di due persone con una entrata pari a 559,6 euro mensili è considerata appartenente all’ultima soglia di povertà, ossia quella della povertà assoluta; il nord del paese evidenzia una percentuale dell’1,3 %, il centro del 2,3% mentre il Mezzogiorno del 9,7%.
Vi sono poi i casi di povertà estrema rappresentati da coloro che vivono senza fissa dimora, dai nomadi, i clandestini,ecc..
“Una indagine campionaria svolta dalla Commissione governativa sulla povertà ha stimato che le persone senza fissa dimora in Italia ammonterebbero a 60.000, almeno 400.000 sarebbero gli immigrati clandestini, 76.000 i nomadi, 79.000 i malati di mente. Il 25 % delle persone senza fissa dimora non utilizza mai i servizi sanitari; il 45,7% ha un’età compresa tra i 25 e i 35 anni; il 75% è di sesso maschile; il 20,8% ha un diploma di scuola media superiore (il 4,1% ha una laurea); il 25% non conta su alcuna forma di sostegno economico; beneficenza e accattonaggio sono le fonti di reddito principali. Molti muoiono prima del compimento dei sessanta anni....Gli immigrati irregolari, o clandestini, sono disoccupati od occupati nel lavoro in “nero”... trovano alloggio in dormitori o ostelli, oppure in vecchi locali sovraffollati, senza servizi e con affitti elevati. .....Un’indagine dell’Opera Nomadi mostra che i nomadi in Italia, prevalentemente Rom, hanno una speranza di vita media che non supera i 40 anni...”. [17]
Tale situazione convive con le mille forme di nuova povertà da lavoro.
Una peculiarità del mercato del lavoro italiano fino ai primi anni ’90 è stata quella di una determinata struttura soggettiva di una disoccupazione a carattere per lo più congiunturale. Infatti la stragrande maggioranza dei disoccupati rientravano nella classe delle forze di lavoro più giovani e potevano quindi essere considerati inoccupati più che disoccupati. Questo portava ad una situazione di “relativa sicurezza” familiare in quanto in ogni nucleo familiare vi era almeno un adulto in grado di sostenere la disoccupazione del giovane.
In questi ultimi anni invece la situazione è molto cambiata; la nuova struttura del mercato del lavoro con l’introduzione della flessibilità, dei lavori temporanei e cosiddetti atipici ha diversificato la composizione per età della disoccupazione [18].
È interessante anche mostrare qual è la situazione occupazionale fino al 2002 analizzando sia gli occupati a tempo parziale e con occupazione permanente sia gli occupati temporanei. (cfr. tabb. 8 e 9)
Ed anche se il Rapporto Annuale dell’ISTAT del 2001 registra una crescita dell’occupazione nel nostro Paese di circa il 3% negli anni dal 1999 al 2001 va altresì evidenziato che tale aumento non registra una diminuzione delle persone in cerca di lavoro, né ben evidenzia la qualità del lavoro offerto.
Anche la distribuzione territoriale dell’occupazione è preoccupante; circa il 90% della crescita occupazionale si è infatti concentrata nelle regioni del Centro e del Nord Italia; infatti negli anni dal 1993 al 2001 si è avuta una diminuzione del 24% delle persone in cerca di occupazione al centro nord ed un aumento del 18% al sud. Nel 2001 la percentuale di disoccupati al Sud è superiore del 2,2% rispetto a quella registrata nel 1993. Le famiglie nelle quali non sono presenti reddito da lavoro sono per il 67,8% appartenenti al Sud d’Italia.
Se si guarda alle tipologie del lavoro i dati ISTAT del 2001 segnalano che le famiglie con almeno un componente impiegato nel lavoro atipico sono aumentate da una percentuale del 9,2% nel 1993 ad una del 15,5% nel 2001.
Una ricerca attuata dalla S3.Studium, diretta da Domenico De Masi, realizzata per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall’Ente bilaterale nazionale terziario, da Formaconf, da Performa-Confcommercio e da Tk Consultant [19] sostiene che la Legge 30 farà crescere l’occupazione entro il 2008 ma al contempo priverà i lavoratori di garanzie economiche, aumenterà la differenza esistente tra Nord e Sud del Paese. È prevista inoltre una crisi del lavoro nei rami assicurativo e bancario e un aumento nello sviluppo del terziario soprattutto legato ai servizi alla persona. È previsto che il numero dei lavoratori in questo settore arriveranno entro il 2008 a 15 milioni con una presenza significativa di donne, immigrati e giovani.
Sempre attraverso un’indagine “realizzata nell’ambito di Flexo 2008, su un campione di 59 piccole e medie imprese operanti nel settore commerciale e dei servizi, lo strumento di flessibilità più utilizzato è il contratto a tempo pieno determinato (scelto nell’11,6% dei casi), seguito dal part time orizzontale (11,1%) e dal contratto di apprendistato (8,2%). Tutte forme, precisa la ricerca, “flessibili di lavoro dipendente”. Al lavoro indipendente, invece, e in particolare alle co.co.co, ricorre solo il 6,2% delle aziende intervistate. Più frequente l’articolazione dell’orario di lavoro settimanale (7%) e del lavoro domenicale (6,4%). Un altro 6,2% sceglie l’elasticità dell’orario in entrata e in uscita e una quota equivalente i contratti di formazione lavoro. Il 5,9% opta per il lavoro festivo e il premio di produttività per obiettivi, mentre l’interinale è usato solo dal 5,2% delle aziende. Una percentuale, comunque, maggiore rispetto al part time verticale (4,4%). Ultime, nella classifica delle flessibilità, le collaborazioni occasionali, diffuse solo tra il 2,8% degli imprenditori del campione. Nessuno degli intervistati, infine, ha mai fatto ricorso al job sharing (il cui utilizzo era già ammesso prima della riforma Biagi) o al telelavoro. A spingere più del 70% delle imprese ad adottare forme contrattuali flessibili sono soprattutto i picchi di domanda, ma anche l’esigenza di migliorare l’efficienza del lavoro, razionalizzare l’organizzazione e ottimizzare la qualità del servizio. Segue, a distanza, l’obiettivo di essere più competitivi sul mercato, indicato dal 59,3% delle imprese intervistate. La riduzione del costo del lavoro, invece, incide per il 54,5% delle aziende. Il desiderio di aggirare i vincoli normativi sembra essere importante solo per il 9,6% del campione, mentre la necessità di far fronte agli esuberi di personale per il 15,4%. Poco influente, nella scelta di ricorrere a un lavoratore atipico, il bisogno di figure professionali specifiche (24,1%)” [20].
Inoltre va ricordato che i lavoratori atipici sono difficilmente classificabili in quanto offrono una prestazione lavorativa regolamentata in forma non tradizionale e quindi non inclusa in un modello di regolare classificazione.
Ciò determina che anche le statistiche sulla povertà, quella da lavoro, da lavoro povero, siano falsate e non capaci di fotografare la drammaticità del vivere quotidiano di milioni di famiglie.
I dati dell’ISTAT relativi all’anno 2001 basati sulla spesa media mensile pari a 814,5 euro, indicano che una famiglia di due persone viene classificata povera se spende meno di questa cifra al mese per i consumi mensili. Se si considerano le famiglie con 5 persone il 25% delle famiglie italiane sono da considerarsi povere. Se si parla di povertà relativa ed il dato arriva al 36% nel Mezzogiorno. La povertà relativa è ovviamente molto connessa alla disoccupazione e al lavoro precario. Infatti aumenta il numero dei lavoratori che non riescono ad arrivare alla fine del mese con il loro salario. E quindi a garantire condizioni di vita minimamente dignitose per sé e per la propria famiglia. Negli USA questi lavoratori sono chiamati working poors ossia i lavoratori poveri, ai quali pur avendo un lavoro sono molto vicini alla soglia di povertà assoluta e comunque costituiscono la schiera dei nuovi poveri da lavoro. In Italia il numero di questi lavoratori è in continua crescita. L’Ires-Cgil in un suo recente studio in corso di pubblicazione ha rilevato che ci sono almeno tre milioni di salariati con uno stipendio tra i 600 e gli 800 euro al mese, e quindi con un tenore di vita molto vicino a quello di un disoccupato; ci sono poi altri tre milioni di lavoratori il cui salario non supera i 1.000 euro. Si tratta quindi di lavoratori che sono ad elevato rischio di povertà. Ciò è dovuto oltre che alla crisi economica e all’inflazione anche ai sempre più massicci tagli al Welfare. Chi risente maggiormente di questo impoverimento sono i giovani in quanto i genitori non sono più in grado di assicurare un buon tenore di vita ai figli e a loro stessi.
I nuovi poveri sono oggi coloro che non possono accedere all’informazione, alla cultura, alle garanzie di reddito, sono coloro che stentano ad “arrivare alla fine del mese”; oggi il problema povertà riguarda quindi una larga fascia di persone che lavorano, ma che percepiscono redditi bassi, non adeguati.
L’ISTAT osserva che nel 2002 il 22,4% delle famiglie residenti nel Sud d’Italia sono povere, mentre al Nord la percentuale scende al 5%; al Centro la percentuale è del 6,7%.
L’ISTAT rileva che l’11% delle famiglie residenti (ossia 7 milioni 140 mila individui, pari al 12,4% dell’intera popolazione) vive in condizioni (stabili o temporanee) di povertà relativa, ossia non hanno una possibilità di spesa in grado di garantire loro le normali necessità della vita quotidiana.
Si calcola che come media un nucleo familiare può disporre di meno di 823 euro al mese per sopravvivere. Questo valore rappresenta la linea di povertà relativa calcolata su una famiglia composta da due persone. Questa cifra è impiegata per l’85% nei bisogni primari (ossia alimentazione, casa, trasporti, vestiti); solo il 2,8% della spesa di un mese è impiegato per l’istruzione e le spese mediche [21]. Tra le spese più rilevanti si trovano senza dubbio la casa e l’alimentazione che risultano rappresentare ben il 31,1% della spesa media mensile di una famiglia povera, ossia un terzo del totale; questa percentuale per le famiglie più ricche è invece del 18,3%.
Sempre nell’anno 2002 si calcola che può considerarsi sicuramente povero il 5,1% delle famiglie residenti (ossia 1 milione 137 mila famiglie), mentre viene definito appena povero il 5,9%, (ossia 1 milione 318 mila famiglie). La dicitura di quasi povero è per l’8% delle famiglie (1 milione 772 mila famiglie).
Quindi ci sono 2 milioni 916 mila cittadini (5,1% della popolazione) che sopravvivono in condizioni di povertà assoluta, ossia che non hanno la possibilità di nutrirsi adeguatamente, non hanno abitazioni stabili o comunque confortevoli e non possono viaggiare, leggere o comunicare in modo consono.
Va evidenziato che la mancanza di lavoro influenza molto la condizione di povertà dal momento che più di un quinto delle famiglie con un componente in cerca d’occupazione è povero. Il valore cresce ad oltre un terzo (37,3%) se i componenti in cerca di lavoro sono due o più. La povertà relativa incide molto più significativamente se ci si trova nella posizione di lavoratore dipendente rispetto all’autonomo e supera il 32% per i soggetti in cerca di occupazione.
Tre milioni di lavoratori con un salario netto compreso tra i 600 e gli 800 euro, altri tre milioni circa con una busta paga un po’ più consistente, ma che raggiunge a malapena i 1.000 euro. I “lavoratori poveri”, coloro che pur lavorando tutti i giorni gravitano intorno alla soglia di povertà, sono oltre sei milioni. Tanti. Dallo studio emerge un fatto nuovo, particolarmente inquietante: se è vero che il “lavoratore povero” nasce come prodotto dei contratti atipici, della flessibilità, del sommerso diffuso, è altrettanto vero che oggi il fenomeno ha ormai raggiunto “anche categorie storiche del cosiddetto “made in Italy”, del pubblico impiego e degli altri servizi, della piccola e media impresa, dell’edilizia, dell’artigianato. Milioni di lavoratori che sono poveri ma che lavorano, perchè hanno un livello di vita che è poco sopra quello di un disoccupato.
La situazione attuale mostra che la condizione di disagio e povertà riguarda soprattutto i lavoratori precari, i giovani in cerca di occupazione e i pensionati. Ma come si spiega tutto ciò?
In primo luogo va evidenziato che si è avuto un deciso rallentamento della produzione industriale in concomitanza ad un forte aumento dei prezzi ed aumenti salariali che non hanno rispettato neppure l’incremento dell’inflazione programmata; si pensi che l’inflazione reale ufficiale secondo i dati ISTAT si attesterebbe in media intorno al 2,7% ma già l’inflazione cosiddetta percepita è almeno il doppio, e quella misurata effettivamente sui beni di consumo quotidiano da parte di tali categorie di cittadini può considerarsi certamente al di sopra del 15 %. Si consideri poi quanto si è perso in termini di salario indiretto con i continui tagli allo Stato sociale ed anche con il continuo inasprimento fiscale generale in termini non solo di tassazione dei redditi ma anche dei consumi di prima necessità. In ultimo non si dimentichino gli incrementi di produttività che non sono tornati in alcun modo al fattore lavoro.
Ed a questo proposito sostiene Agostino Megale (uno degli autori del Rapporto IRES sui salari): “Abbiamo evidenziato che nel rapporto con il resto d’Europa, rispetto all’euro, si è verificato che, a fronte di 33 punti di crescita di produttività in Francia, nel decennio 1993-2002, al lavoro sono andati 9 punti; in Germania, su 21 punti, al lavoro ne sono andati 9,1, e in Italia su 18,7 punti, al lavoro è andato solo il 3,3%. Ci possiamo consolare solo guardando gli Stati Uniti, dove la crescita è stata del 40 mentre al lavoro è andato solo l’1,5%” [22]
Il problema è molto serio anche perché l’Italia oltre a registrare solo il 3,3% di restituzione al lavoro della crescita di produttività il resto è stato quasi tutto destinato a rendite e profitti e non ad investimenti produttivi o ricerca.
Ma occorre chiarire che a risentire della situazione non sono solo i giovani lavoratori precari o i pensionati al minimo, o i ceti sociali meno abbienti ma anche e soprattutto gli appartenenti al ceto medio il Rapporto Italia dell’Eurispes del 2004 segnala che il 96,7% degli italiani ha molto risentito nell’anno 2003 dei rincari dei prezzi soprattutto nei settori alimentari, dell’abbigliamento, ma anche della riduzione complessiva del potenziale salariale.
“Fatto 100 nel 1991 il potere di acquisto dei salari, in Italia adesso il livello è sceso a 98, mentre in Germania e Olanda è salito a 140. Messa in altri termini, vuol dire che lo stipendio di un quadro italiano è inferiore al 65% rispetto a quello di un inglese; che un insegnante italiano mediamente percepisce 1200 euro, mentre il collega di Francoforte ne guadagna 2500. È spaventoso, vuol dire che da noi si guadagna meno della metà. A pagare lo scotto maggiore in Italia sono gli strati consistenti di ceti medi.......Negli ultimi 3 anni, dall’adozione della moneta unica, gli stipendi degli impiegati si sono svalutati mediamente del 13%, con punte che arrivano al 15% nel settore delle nuove tecnologie....se paragonate alle retribuzioni lorde del 1991, quelle attuali sono addirittura inferiori di mezzo punto percentuale” [23]
“Quello che si sta verificando, forse per la prima volta in Italia, è l’ingresso tra i poveri di quote significative di occupati. Non è più solo la disoccupazione o la vecchiaia a determinare la condizione di povertà ma famiglie numerose monoreddito scivolano verso la soglia critica e spesso la superano......è evidente che l’impatto inflazionistico percepito dalle famiglie italiane è strettamente legato al fatto che il 20% delle famiglie più povere percepisce solo il 6% del reddito mentre al 20% più ricco va oltre il 42% della torta. Per le famiglie più povere e per i ceti medi l’inflazione ha un potere di erosione della capacità di consumo decisamente più alta che per le famiglie ricche....Ma il vero impoverimento delle famiglie a reddito medio-basso è legato all’aumento dell’incertezza del futuro...”. [24]
Brevi conclusioni
Negli ultimi anni il modello di democrazia capitalistica, nato negli USA con il fordismo, è scomparso, provocando una frantumazione della intera struttura produttiva preesistente e distruggendo le stesse forme di convivenza civile determinate dal modello di mediazione sociale di forma keynesiana.
L’andamento demografico, la globalizzazione neoliberista, la comunicazione, il livello di istruzione, il progresso tecnologico e lo sviluppo organizzativo sono i fattori che influenzano il rapporto tra domanda e offerta di lavoro. Mentre nel mondo cosiddetto “sviluppato” dove si concentrano tutte le attività scientifiche, il tasso di disoccupazione varia dal 4% al 14%, nel mondo dei paesi di “mezzo” (nei quali sono presenti le fabbriche delocalizzate) lo stesso tasso varia dal 10 al 20%. Nel cosiddetto “Terzo Mondo” invece, non è possibile quantificare la disoccupazione in quanto non esistono regole o strumenti per calcolare il numero di coloro che hanno un vero e reale lavoro.
Ed in questo quadro si inseriscono le nuove figure del lavoro caratterizzate dalla flessibilità sia delle mansioni sia degli orari.
Per la prima volta la crisi del lavoro, dunque, minaccia oltre che i disoccupati anche i lavoratori occupati; il cambiamento più grande si è avuto oltre che nel sistema del lavoro anche nel sistema di protezione sociale.
È necessario quindi comprendere fino in fondo il fenomeno per poter trovare al più presto delle strade da percorrere per consentire ai lavoratori di non perdere, ma al contrario di accrescere la loro sicurezza economica e di migliorare il proprio tenore di vita.
Siamo davanti a un crescente disfacimento di interi gruppi sociali ad un impoverimento di classi sociali che si ritenevano immuni da ogni crisi di sistema. Vi è una nuova intensità di povertà culturali, un sempre maggiore attacco alle forme di protezione sociale e di welfare, un indebolimento dei modelli di rappresentanza politica e forse per la prima volta ci si trova a dover salvaguardare l’identità, il ruolo e la funzione sociale dei ceti medi, costretti, a scontrarsi con un rischio di progressivo impoverimento, avendo come prospettiva immediata la precarizzazione di ogni forma e di ogni momento del vivere sociale.
L’abbattimento del Welfare State, che garantiva uno standard minimo di sicurezza relativamente alla salute, all’abitazione, ai bisogni primari insomma, si ripercuote non solo sugli emarginati e sulle persone collocate al livello di povertà assoluta, ma anche e in gran parte su coloro che fino a pochi anni fa si consideravano sicuri e garantiti.
Il modello produttivo capitalistico produce ricchezza che si diffonde però a “pelle di leopardo” ed è caratterizzato dalla scomparsa della stabilità del lavoro, della sicurezza economica. I nuovi poveri sono i professionisti di mezza età, il cosiddetto ceto medio, che molto spesso non parla e si nasconde per una sorta di “vergogna”.
In un sistema sociale in cui vengono rappresentate le varie forme di esclusione economica diventa ancora più evidente la marginalizzazione di settori sempre maggiori di popolazione.
E i vari governi confortati dagli economisti hanno cercato di giustificare l’aumento incessante del tasso di disoccupazione con un trucco anche piuttosto ingenuo; si è pensato di aumentare il tasso fisiologico della disoccupazione; infatti se negli anni 30 il tasso di disoccupazione considerato fisiologico era del 2% e negli anni ’50 del 3% ora è considerato ottimo il tasso di disoccupazione del 4% registrato in Danimarca.
Il rischio è che con i tagli al Welfare, lo spostamento dell’asse dei servizi dal pubblico al privato, l’aumento dell’inflazione, il numero dei lavoratori che non riescono ad arrivare a fine mese continui ad aumentare.
Di qui l’urgenza di tornare a parlare a partire dalle condizioni reali dei lavoratori e non più in termini di “media statistica”. Riaprire, dunque, la questione salariale, attraverso una nuova politica dei redditi che passi per il rilancio del sistema pensionistico pubblico per una occupazione buona a pieno salario e pieni diritti per tutti i cittadini, per la riduzione dell’orario di lavoro, per uno Stato sociale di nuova cittadinanza con il riconoscimento immediato di un Reddito Sociale per disoccupati, precari, pensionati al minimo; una nuova stagione di diritti del lavoro a partire dall’abolizione della Legge 30, dal rafforzamento e applicazione di pieni e larghi diritti per tutte le categorie di lavoratori, per una nuova politica fiscale a favore dei redditi più bassi e che colpisce i grandi capitali e le rendite finanziarie, per una società del reddito per tutti e che restituisca dignità ai soggetti del lavoro e del lavoro negato.
GLOSSARIO
Pensiamo sia utile per comprendere meglio i dati e le situazioni descritte inserire un piccolo glossario per spiegare i termini usati e i risultati delle indagini di cui si è scritto:
“Spesa media familiare: è calcolata al netto delle spese per manutenzione straordinaria delle abitazioni, dei premi pagati per assicurazioni vita e rendite vitalizie, rate di mutui e restituzione di prestiti, che non rientrano nel concetto economico di spesa per consumi.
Spesa media procapite: si ottiene dividendo la spesa totale per consumi delle famiglie per il numero totale dei componenti.
Linea di povertà standard (relativa): per una famiglia di due componenti è pari alla spesa media procapite nel Paese. Nel 2002 questa spesa è risultata pari a 823,45 euro mensili.
Scala di equivalenza: insieme dei coefficienti di correzione utilizzati per determinare la soglia di povertà quando le famiglie hanno un numero di componenti diverso da due. Ad esempio, la soglia di povertà per una famiglia di quattro persone è pari a 1,63 volte quella standard (1.342,22 euro), la soglia per una famiglia di sei persone è 2,16 volte quella standard (1.778,65 euro).
Incidenza della povertà: si ottiene dal rapporto tra il numero di famiglie con spesa media mensile per consumi pari o al di sotto della soglia di povertà e il totale delle famiglie residenti.
Intensità della povertà: misura di quanto in percentuale la spesa media delle famiglie definite povere è al di sotto della soglia di povertà.
Intervallo di confidenza: L’Indagine sui consumi delle famiglie osserva solo una campione della popolazione. Le stime sono affette da un errore (campionario) che può essere stimato. È infatti possibile definire un intervallo del valore rilevato (intervallo di confidenza) che comprende, con una probabilità del 95%, il valore che si otterrebbe osservando l’intera popolazione.
A parità di errore, se la stima è molto elevata in termini di livello, l’intervallo che si otterrà sarà più ampio, in termini assoluti, rispetto a quello che si otterrebbe per una stima più bassa. Nel caso delle povertà ciò fa sì che nelle regioni del Nord, dove il numero delle famiglie povere è molto ridotto, nonostante l’errore campionario sia più elevato, gli intervalli di confidenza, espressi in termini assoluti, sono meno ampi. Al contrario, nelle regioni del Mezzogiorno, dove il numero delle famiglie povere è molto più elevato, l’errore è più contenuto (cioè la precisione delle stime è maggiore) e tuttavia gli intervalli di confidenza sono più ampi.” [25]
NOTE
1 Ricercatrice socio-economica, membro del Com.Scient. di CESTES e del Comit.Progr. Scientifica di PROTEO
[1] Le definizioni sono state date da: L. Frey, R. Livraghi in “Sviluppo umano, povertà umana ed esclusione sociale”, Franco Angeli, 1999
[2] A.Tiddi, Precari, percorsi di vita tra lavoro e non lavoro”, Derive Approdi, Roma, aprile 2002, pag. 25
[3] A.Tiddi, Precari, percorsi di vita tra lavoro...”, op. cit. pag.75
[4] Cfr. M.Zupi, Si può sconfiggere la povertà, Laterza edit., Roma, maggio 2003, pag.XXI
[5] In Italia ci sono 2 fonti principali dei dati a riguardo: l’indagine campionaria sulle famiglie della Banca d’Italia e l’indagine ISTAT annuale sui bilanci delle famiglie.
[6] Cfr. www.Caritas.it ; Caritas Europa , studio statistico e descrittivo della condizione sociale nel continente grazie ai contributi di 43 Caritas nazionali.
[7] Cfr. http://www.edscuola.it/archivio/handicap/poverta2.html
[8] http://www.ueitalia2003.it/ITA/Notizie/Notizia_12171735236.htm
[9] http://www.didaweb.net/fuoriregistro/leggi.php?a=4040
[10] Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro CNEL Commissione per l’Informazione Commissione Politica economica SESTO RAPPORTO CNEL SULLA DISTRIBUZIONE E REDISTRIBUZIONE DEL REDDITO IN EUROPA 2000 - 2001, Luglio 2002, pag. 9.
[11] Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro CNEL Commissione per l’Informazione Commissione Politica economica SESTO RAPPORTO CNEL SULLA DISTRIBUZIONE E REDISTRIBUZIONE DEL REDDITO IN EUROPA 2000 - 2001, Luglio 2002, pag. 10.
[12] Sabrina Rosci http://www.labitalia.com/articles/Approfondimenti/4361.html
[13] www.ansa.it
[14] Si tratta di un metodo di misurazione in cui il reddito del 10% più ricco è diviso per il 10% del più povero.
[15] Pubblicato da : lunedi 28 luglio 2003http://bellaciao.org/it/article.php3?id_article=530
[16] Cfr. http://www.ilmanifesto.it/Quotidiano-archivio/20-Febbraio-2004/art82.html
[17] Cfr. M.Zupi, Si può sconfiggere la...”, op. cit. pag.94-95
[18] Cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Commissione di indagine sull’esclusione sociale, Rapporto sulle politiche contro la poverta’ e l’esclusione sociale, anno 2003, Commissione di indagine sull’esclusione sociale (istituita ai sensi dell’art. 27 legge 8 novembre 2000, n. 328) , pagg.13-19
[19] ’Flexo 2008, le prospettive della flessibilità nelle aziende del terziario’
[20] http://www.labitalia.com/articles/Approfondimenti/2751.html
[21] Cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Commissione di indagine sull’esclusione sociale, Rapporto sulle politiche contro la poverta’ e l’esclusione sociale, anno 2003, Commissione di indagine sull’esclusione sociale (istituita ai sensi dell’art. 27 legge 8 novembre 2000, n. 328.
[22] Cfr. Carta settimanale n.2, “Chi lavora non mangia”, 2004 pag.20-21
[23] Cfr. Il Salvagente 29 gennaio -5 febbraio 2004, pag. 12
[24] G. Santagata , “L’inflazione erode i redditi più bassi”, La Rinascita, 16 gennaio 2004, pag.4
[25] Cfr. ISTAT, Statistiche in breve, La povertà e l’esclusione sociale nelle regioni italiane, 17 dicembre 2003, pag.18.