Introduzione [1]
l recente libro di Bertinotti e Gianni (2000) ha avuto il merito di riaprire in Italia il dibattito sulle teorie del valore e dello sfruttamento, mostrando la rilevanza politica di argomenti che fino a ieri eravamo stati abituati a considerare piuttosto accademici. Cavallaro (2000), Bellofiore (2000) e Mazzetti (2001) hanno dato dei primi contributi a questo rinnovato dibattito. E l’appello di Cavallaro a stare in guardia nei confronti della mistica del valore-lavoro lascia sperare che la ricerca possa procedere oggi lungo i binari giusti, evitando certe forzature scolastiche cui abbiamo assistito in passato, anche se gli interventi di Carchedi (2001), Freeman (2001) e Kliman (2001) sembrano voler uccidere sul nascere questa speranza.
Le domande da porci sono ormai chiare: è proprio vero che per salvare le parti vive dell’analisi marxiana del capitalismo si deve gettare a mare la teoria del valore-lavoro? E che insieme a questa si deve gettare a mare anche la teoria dello sfruttamento, col rischio che di parte viva resti infine ben poco? La mia risposta alla seconda domanda è: no. Alla prima: sì e no. In questo saggio proverò a giustificare tali risposte.
Tenterò innanzitutto una decostruzione della teoria marxiana dello sfruttamento e del valore. Non dirò nulla di nuovo. Mi limiterò a richiamare alcuni risultati della ricerca che sono acquisiti già da qualche decennio. Cercherò però di portare alla luce certe loro implicazioni critiche in merito ai fondamenti ontologici e metodologici della teoria di Marx. Mostrerò che la metafisica su cui poggia la dottrina del valore-lavoro la rende inadatta a dar conto dei rapporti di classe in un’economia capitalistica, mentre la espone a una critica d’incoerenza logica e a una, ancora più grave, di debolezza metodologica. Sosterrò infine che non è possibile dar conto dello sfruttamento in modo coerente ed efficace se si usa la teoria del valore-lavoro. Tutto ciò farò nella prima parte del saggio.
Non è tanto la concezione dello sfruttamento in sé a creare problemi, quanto la stretta connessione che Marx instaurò tra essa e la teoria del valore-lavoro. Perciò l’abbandono di questa teoria non comporta una rinuncia all’analisi dello sfruttamento. Nella seconda parte del saggio enucleerò il nocciolo dell’analisi marxiana del rapporto di sfruttamento e ne tenterò una ricostruzione ricorrendo a un approccio di tipo controfattuale. Eviterò di far ricorso a teorie universali della giustizia o a verità che affermano certezze ontologiche. L’analisi che proporrò fa leva piuttosto sull’assunzione di un punto di vista di classe, sulla base del quale costruirò un modello di mondo ipotetico che può essere usato come pietra di paragone per studiare il capitalismo. Poi, facendo uso di una teoria del valore basata sui prezzi di produzione, mostrerò che è possibile esprimere il saggio di sfruttamento in termini di quantità di lavoro, comandato e incorporato. Cercherò infine di portare alla luce alcune caratteristiche fondamentali del capitalismo, cioè alcune condizioni istituzionali che rendono possibile l’estrazione del plusvalore dal processo produttivo.
Il superamento della teoria del valore-lavoro non implica che questa debba essere gettata a mare. Si tratta soltanto di cambiarne l’uso metodologico. Così, nella seconda parte del saggio mostrerò anche che una misura dei valori in lavoro contenuto può tornare utile proprio per definire le condizioni di scambio prevalenti nel modello di mondo ipotetico usato come controfattuale.
1. Sfruttamento e valori-lavoro La dottrina ortodossa dello sfruttamento
A fondamento della teoria marxiana del valore-lavoro ci sono due assiomi. Il primo è quello che potrebbe essere definito “assioma della sostanza del valore”: “un valore d’uso o bene ha valore soltanto perché in esso viene oggettivato, o materializzato, lavoro astrattamente umano” (Marx, 1964, I, p. 70). Il secondo potrebbe essere definito “assioma della grandezza del valore”: “come misurare ora la grandezza del suo valore? Mediante la quantità della ‘sostanza valorificante’, cioè del lavoro, in esso contenuta” (Marx, 1964, I, p. 71).
In base a quest’ultimo assioma il valore di una merce coincide con la quantità di lavoro impiegato direttamente e indirettamente per produrla. Quello impiegato direttamente si chiama “lavoro vivo” e coincide col valore aggiunto. Quello impiegato indirettamente si chiama “lavoro morto” e coincide col “capitale costante”, cioè col valore dei mezzi di produzione. Così il valore del prodotto netto aggregato non è altro che il lavoro vivo complessivo. Il salario viene chiamato da Marx “valore della forza lavoro”; se lo si misura in lavoro contenuto si scopre che è uguale alla quantità di lavoro impiegata per produrre i beni salario. Il “plusvalore” infine consiste nella differenza tra il valore del prodotto netto e quello della forza lavoro.
Ora concentriamo l’attenzione su quanto produce un operaio in una giornata di 8 ore lavorative, e poniamo che il valore della forza lavoro, cioè il valore-lavoro del salario giornaliero, sia pari a 4 ore di lavoro. Ciò vuol dire che per produrre i beni salario consumati da un operaio in una giornata lavorativa si deve lavorare 4 ore. Il plusvalore sarà pari a 8-4=4 ore di lavoro. Il saggio di plusvalore, definito come il rapporto tra il plusvalore e il valore della forza lavoro, sarà pari al 100%, cioè a 4/4. Si può dire che l’operaio lavora 4 ore per sé e 4 per il padrone. In forza dell’assioma della grandezza del valore, risulta che il plusvalore coincide con un pluslavoro. E ciò sembrerebbe confermare l’assioma della sostanza del valore, per il quale, si ricorderà, il valore è creato dal lavoro. Sembrerebbe evidente che il plusvalore guadagnato dal capitalista è stato prodotto, cioè creato, dal pluslavoro dell’operaio. Il profitto, in quanto coincide col plusvalore, è il risultato di uno sfruttamento dei lavoratori. Il rapporto tra profitto e salari, se coincide col saggio di plusvalore, sarebbe una misura dell’intensità dello sfruttamento.
Due osservazioni sono degne di nota. La prima è che, siccome i valori-lavoro non sono altro che le quantità di lavoro impiegate per produrre le merci, per determinarli è sufficiente conoscere la tecnica produttiva in uso, cioè i coefficienti di lavoro vivo e morto impiegati nella produzione; non è necessario conoscere la distribuzione del reddito, la grandezza del profitto, del salario e del saggio di sfruttamento. La seconda è che la produttività del lavoro misurata in valori-lavoro, cioè il rapporto tra il valore del prodotto netto e il livello dell’occupazione, è uguale a 1.
-----
Due paradossi
La teoria è logicamente incoerente se applicata a un modo di produzione capitalistico. In un sistema che si trova in equilibrio concorrenziale, le merci si scambiano a prezzi di produzione che garantiscono un saggio di profitto uniforme. Per determinare i prezzi di produzione, dunque, non basta conoscere la tecnica produttiva. È necessario conoscere anche il saggio di profitto o quello di salario.
In generale, se il saggio di profitto è positivo, i prezzi di produzione non coincidono coi valori-lavoro. Inoltre nessuno dei rapporti tra variabili aggregate, misurate in valori-lavoro, coincide con il rapporto tra le stesse variabili misurate in prezzi di produzione. In particolare il saggio di plusvalore non coincide col rapporto profitti-salari. I prezzi di produzione coincidono coi valori-lavoro solo nel caso in cui saggio di profitto è zero.
Marx riteneva che esistesse un algoritmo matematico capace di trasformare i valori-lavoro in prezzi di produzione in modo tale che il saggio di plusvalore aggregato restasse invariato nel passaggio dalla misura in valori-lavoro a quella in prezzi di produzione, così che il saggio di plusvalore fosse comunque uguale al rapporto profitti-salari. In tal modo poteva continuare a trattare il profitto come evidenza immediata del pluslavoro. Ma è stato dimostrato che, quale che sia l’algoritmo usato nella trasformazione, si ottiene sempre un risultato paradossale: in un’economia in cui si producono diverse merci il saggio di sfruttamento resta invariato nella trasformazione dei valori-lavoro in prezzi se e solo se non c’è sfruttamento.
Né si può ripiegare sulla tesi secondo cui non è necessario che il saggio di sfruttamento in valori-lavoro sia uguale a quello in prezzi. Infatti, poniamo che il secondo sia superiore al primo. È possibile misurare il monte salari in modo da farlo coincidere con il valore della forza lavoro. Ma allora il plusvalore in prezzi sarebbe superiore al plusvalore in valori-lavoro. Ne deriva che esisterebbe una parte di profitto che non è stata prodotta dal pluslavoro. Così risulterebbe che possa esserci profitto senza sfruttamento! Comunque la si rigiri, è evidente che la teoria del valore-lavoro fa un pessimo servizio alla teoria dello sfruttamento.
La ragione di questa difficoltà è che i valori-lavoro esprimono rapporti puramente tecnici e astraggono dalle relazioni tra classi sociali. Come ho già osservato, è sufficiente conoscere la tecnica produttiva per determinare i valori-lavoro. Non è necessario sapere nulla sull’assetto istituzionale che regola la produzione, sulle classi sociali che si confrontano nel processo produttivo, sul modo in cui le classi si spartiscono il reddito. Non è necessario nemmeno sapere che si tratta di una economia capitalistica, di un’economia in cui una classe guadagna un profitto e un’altra un salario. Contrariamente ai prezzi di produzione, i valori-lavoro non variano al variare dei rapporti tra classi sociali, ad esempio al variare della distribuzione del reddito. Il valore è un rapporto sociale, secondo Marx (1964, I, p. 106n), “un rapporto tra persone [...] celato nel guscio di un rapporto tra cose”. Dunque dovrebbe esprimere i rapporti sociali e variare col loro cambiamento. Invece i valori-lavoro sono insensibili ai rapporti sociali. Marx appare consapevole di questa proprietà dei valori-lavoro, del fatto che la loro definizione presuppone l’astrazione dall’assetto sociale e istituzionale del capitalismo. Infatti, proprio nel capitolo in cui costruisce la teoria del valore-lavoro, dichiara esplicitamente di astrarre dal salario: “La categoria del salario del lavoro non esiste in genere ancora, a questo grado della nostra esposizione” (Marx, 1964, I, p. 76n). E in una lettera a Engels del 13 gennaio 1859 dichiara altrettanto esplicitamente che astrae dal capitale: “questi fascicoli non contengono ancora nulla sul capitale, ma soltanto due capitoli: 1) La merce, 2) Il denaro” (Marx, 1969, p. 219). “Questi fascicoli” sono quelli di Per la critica dell’economia politica, e contengono la prima versione della teoria del valore che verrà poi ripresentata nel primo capitolo del Capitale.
Emerge qui un paradosso metodologico che è ancora più grave di quello analitico che ho mostrato sopra, del quale peraltro costituisce la causa. Per fondare una teoria dello sfruttamento che è una teoria delle relazioni sociali, si usa una teoria del valore che astrae dalle relazioni sociali (Screpanti, 1993).
Come giustificare gli assiomi marxiani?
Sia che il saggio di sfruttamento venga misurato in valori-lavoro, sia che venga misurato in prezzi, resta vero che esiste sfruttamento perché la produttività del lavoro è maggiore del salario. Questo, in poche parole, dice la teoria marxiana: il salario è minore della produttività del lavoro. Ma dal punto di vista “filosofico” l’assioma della sostanza del valore vuole dire molto di più. Afferma, tra l’altro, che il contributo produttivo del lavoro coincide con la produttività media del lavoro. Quindi sostiene che solo il lavoro produce plusvalore. Ora, un assioma è vero per assunzione. Si suppone che la verità che afferma sia evidente e che non abbia bisogno di essere dimostrata. Un assioma rappresenta un presupposto metafisico sulla base del quale altre proposizioni possono essere dimostrate vere. Dunque, è proprio così evidente l’assioma della sostanza del valore?
Perché il contributo del lavoro dovrebbe coincidere con la produttività media? Qualcuno potrebbe preferire postulare che esso coincida con la produttività marginale, cioè con quella del meno produttivo dei lavoratori occupati. E sulla base di tale nuovo assioma sarebbe facile dimostrare che dei lavoratori remunerati con un salario uguale alla produttività marginale del lavoro non risulterebbero essere sfruttati, anche se il profitto fosse positivo. In altri termini l’“evidenza” dell’assioma marxiano deve essere corroborata con qualche argomento convincente. Se un assioma non ha bisogno di essere dimostrato, deve però comunque essere “giustificato”. Postulare che il contributo produttivo del lavoro coincide con la produttività media equivale ad assumere che gli altri requisiti produttivi, i beni capitali e le risorse naturali, non danno alcun contributo. Come può essere giustificata una tale tesi?
Una strategia spesso seguita per rispondere a questa domanda è basata sull’osservazione che il capitale stesso è prodotto dal lavoro, cosicché il suo contributo produttivo si risolve in un contributo del lavoro (Elster, 1978, pp. 10-11). Tale strategia però può solo servire per sostenere che la remunerazione del contributo del capitale, supponendo che un tale contributo esista, deve essere pagata ai lavoratori. Non può servire a dimostrare che il capitale non dà contributi produttivi. Ma è evidente che quella remunerazione dovrebbe affluire ai lavoratori che legittimamente possiedono il capitale, ad esempio perché lo hanno accumulato effettuando dei risparmi, non a quelli che lo hanno prodotto (Van Parijs, 1995). I lavoratori che posseggono del capitale sarebbero dei capitalisti e verrebbero remunerati con un plusvalore corrispondente al suo contributo produttivo. Nel qual caso il salario non potrebbe coincidere con la produttività media del lavoro.
Un’altra strategia mira a giustificare l’assioma facendo ricorso all’argomento secondo cui il contributo produttivo del capitale non dovrebbe essere pagato ai capitalisti, anche se la sua proprietà fosse stata acquisita solo con il lavoro e il risparmio. Si ammette l’esistenza di un contributo produttivo del capitale in termini di produttività reale. Tuttavia il fatto che il capitale non sia remunerato implica che in termini di valore solo il lavoro dà un contributo produttivo. Ma perché il contributo del capitale in termini reali non dovrebbe essere remunerato? La ragione sarebbe che i beni capitali sono stati prodotti per mezzo di risorse naturali che, presumibilmente in forza di un qualche diritto naturale, appartengono all’umanità in quanto tale e non possono essere appropriate privatamente (Cohen, 1983, pp. 316-317; 1986, pp. 87-90). Ora, le risorse naturali dovrebbero includere i talenti naturali. È ammissibile che gli individui si approprino privatamente delle proprie dotazioni personali? Se la risposta a questa domanda è positiva, allora non si può sfuggire alla conclusione che i beni capitali prodotti mediante l’uso dei talenti personali sono posseduti legittimamente e quindi devono essere remunerati. Se la risposta è negativa, allora si deve concludere che neanche il lavoro vivo ha diritto di essere pagato secondo il proprio contributo produttivo, dal momento che questo consiste in un flusso di servizi scaturenti da dotazioni di risorse personali.
Marx ad ogni modo ha messo bene in chiaro che anche la terra e il capitale contribuiscono alla produzione delle merci [2]. Ma ha insistito sull’idea che solo il lavoro produce nuovo valore, solo esso è sostanza di valore. La sua strategia per giustificare l’assioma della sostanza del valore fu molto semplice: postulò l’assioma della grandezza del valore. Ovviamente, se è la creazione di valori-lavoro che conta, piuttosto che la produzione di beni fisici, e se la grandezza del valore coincide con una quantità di lavoro contenuto, l’assioma della sostanza del valore sembra piuttosto pacifico: poiché la produttività del lavoro è uguale a 1, cioè il valore prodotto con un’ora di lavoro equivale a un’ora di lavoro, sembra evidente che solo il lavoro può aver prodotto quel valore. Ma allora l’attenzione si sposta sull’assioma della grandezza del valore: qual è l’evidenza che tale grandezza coincide col lavoro contenuto? Dopo tutto una misura è una convenzione.
Marx in realtà riteneva che la misura in lavoro contenuto fosse qualcosa di più di una semplice convenzione. Pensava che fosse l’unica misura in grado di esprimere la sostanza del valore, di esprimerla in modo tale da spingere l’analisi dello sfruttamento al di là delle apparenze dei prezzi. Ma è chiaro che quella in lavoro contenuto può essere intesa come la misura autentica della grandezza del valore, e non come una convenzione contabile o un espediente euristico, solo se il lavoro è sostanza del valore. Così l’assioma della grandezza del valore acquista rilevanza ontologica proprio in quanto è sostenuto da quello della sostanza del valore.
In altri termini i due assiomi si sostengono l’un l’altro. Si può credere che la misura della grandezza del valore in lavoro contenuto rivela la sostanza del valore poiché si assume che il lavoro è “sostanza valorificante”. D’altra parte sembra che si possa far passare quest’assunzione come un semplice riconoscimento dell’evidenza perché si postula che la grandezza del valore sia misurata in lavoro contenuto. Ha senso tutto ciò? Il punto è che, se la misura in valori-lavoro avesse senso, sia pure solo a livello aggregato, le apparenze degli scambi effettuati in base ai prezzi non dovrebbero contraddire la sostanza del valore-lavoro, anche se contribuissero ad offuscarla. Invece, come ho mostrato nel paragrafo precedente, la contraddicono. Dunque la teoria è basata su due assiomi che si sostengono l’un l’altro, senza però che sia possibile giustificare né l’uno né l’altro. Sembra proprio non avere torto Sraffa, quando parla di “mistica del valore”.
2. Sfruttamento senza valori-lavoro Un controfattuale di classe
Ritengo che i lavoratori siano in grado di concepire un’alternativa ammissibile al capitalismo che giudicano migliore di esso. Ammissibile, nel senso che è realizzabile sulla base della dotazione delle risorse e delle tecniche in uso nell’economia capitalistica di riferimento, e solo cambiandone le istituzioni e la distribuzione del reddito. Migliore, nel senso che i lavoratori vivrebbero meglio in essa che nel capitalismo.
Chiamerò “Utopia” la migliore di tutte le alternative ammissibili. [3] I lavoratori, per definizione, si appropriano dell’intero prodotto netto in Utopia, cosicché il loro reddito medio coincide con la produttività media del lavoro. Potrebbero così pensare che, se possono aumentare il proprio reddito passando in Utopia e continuando a produrre come prima e con le stesse tecniche di prima, allora non è per ragioni tecniche che guadagnano meno della propria produttività nel capitalismo, ma solo a causa dell’assetto istituzionale. Potrebbero convincersi che, se possono appropriarsi di tutto il prodotto solo cambiando le istituzioni ed abolendo la classe dei capitalisti, vuol dire che non hanno bisogno dei capitalisti per produrre e quindi che tutto ciò che è prodotto lo producono loro. In altri termini, potrebbero pensare che il loro contributo produttivo coincide con ciò che guadagnano e producono in Utopia, visto che ciò che producono lì lo possono produrre ovunque, date le tecniche. Poi, confrontando il mondo capitalistico con Utopia i lavoratori si accorgono che nel primo essi stanno peggio perché il salario è più basso della propria produttività, e si sentono per ciò sfruttati nel capitalismo.
Il riferimento controfattuale [4] all’Utopia sembra un po’ intellettualistico e fantasioso, sembra allontanarci da quel sano richiamo al mondo concreto a cui ci ha abituato il primo capitolo de Il capitale. In realtà il ragionamento controfattuale è esperienza quotidiana di tutti noi. Ricorriamo ai controfattuali ogni volta che ci domandiamo se il prezzo di un prodotto non è troppo alto rispetto a uno che consideriamo, sia pur vagamente, come “equo”, o una pensione o un salario non sono troppo bassi. Ricorre a ragionamenti controfattuali l’operaio che valuta la misura dello sfruttamento e del benessere sociale dal tipo di automobili che ha il padrone e dall’inutilità della sua vita: sarei meno sfruttato se il valore di quella Ferrari si risolvesse in salari, e staremmo tutti molto meglio se quel porco volesse lavorare invece di trastullarsi col gioco in borsa.
La teoria che presento qui non è altro che una formalizzazione di questo tipo di argomentazione. L’idea dello sfruttamento implica un giudizio sulla destinazione del prodotto del lavoro. Il ragionamento controfattuale rinvia alla convinzione che una destinazione diversa da quella vigente nel capitalismo è ammissibile. La persuasione che è possibile migliorare le condizioni di vita dei lavoratori, senza dover necessariamente cambiare le tecniche in uso, è tutt’uno con quella secondo cui il profitto non remunera il contributo produttivo di alcunché. Sostengo che, a dispetto di ogni egemonia ideologica del capitale, queste idee, convinzioni, persuasioni sono componenti vitali del senso comune che esprime la condizione operaia contemporanea.
L’assunzione di un punto di vista di classe, piuttosto che di uno basato su una metafisica universale, orienta la filosofia marxista verso una rifondazione non essenzialista delle teorie del valore e dello sfruttamento.
Nel caso della teoria del valore, il punto di vista di classe consente di partire da assiomi che non assumono il significato di proposizioni relative all’essenza di qualcosa. Il problema di quale sia la sostanza del valore, o di chi lo “crei”, non si pone nemmeno. Infatti si tratta di prendere sul serio la tesi marxiana secondo cui il valore è una relazione sociale - prenderla sul serio, cioè, intendendola nel senso che il valore è soltanto una relazione sociale, che non c’è nessuna essenza dietro le relazioni sociali. Ci sono solo dei rapporti di produzione e di mercato, di lotta, di potere e di divisione del lavoro, attraverso cui gli agenti sociali producono e si spartiscono i beni. Questi rapporti non stanno dietro le relazioni sociali: essi sono le relazioni sociali.
Inoltre l’assunzione di un punto di vista di classe fornirà una giustificazione sensata all’assioma che fonda la teoria dello sfruttamento. Non sarà una giustificazione del tipo richiesto dall’assioma della sostanza del valore. D’altronde non c’è bisogno di far coincidere il plusvalore col pluslavoro per sostenere la tesi dello sfruttamento. Né sarà una giustificazione empirista del tipo che sostiene che la cosa è evidente alla luce di una semplice osservazione della realtà. Una giustificazione del genere non è convincente perché non c’è dato empirico che possa essere raccolto e interpretato senza far riferimento a una teoria e a un punto di vista. Non sarà infine una giustificazione di tipo etico, del tipo cioè che presuppone una universale filosofia della giustizia. Un tale approccio lo rifiuto perché mi sembra che nessuna onesta filosofia della giustizia può essere formulata ponendosi al “di sopra delle parti”.
-----
Una definizione, un assioma e un teorema
Come ho già notato, una volta sfrondata della metafisica, la concezione marxiana dello sfruttamento si riduce alla proposizione secondo cui il salario è minore della produttività media dellavoro.È possibile fondare una solida teoria dello sfruttamento su questa proposizione? Sostengo non solo che è possibile, ma anche che ne può risultare un’analisi molto più pregnante e illuminante di quella ortodossa.
Comincerò con una “definizione di sfruttamento capitalistico”: C’è sfruttamento capitalistico del lavoro nella produzione quando il contributo produttivo dei lavoratori è maggiore del loro salario. La definizione non specifica alcunché riguardo alla distribuzione dei diritti di proprietà. Così è possibile applicarla al capitalismo in generale. In Screpanti (2001a, 2001b) mostro che, per caratterizzare un modo di produzione come capitalistico, è sufficiente postulare che il reddito da lavoro si configura come salario e che il capitale si valorizza tramite la produzione e l’investimento di un plusvalore. Il capitalista estrae dai lavoratori un contributo produttivo. Se tale contributo lo mette in grado di guadagnare dei profitti, e quindi di valorizzare il capitale, dico che c’è sfruttamento capitalistico. La definizione implica che un qualche soggetto diverso dai lavoratori ha il controllo del loro contributo produttivo e che tale soggetto sia un capitalista, cioè che operi per la valorizzazione e l’accumulazione del capitale.
Sorge immediatamente il problema di stabilire in cosa consiste il contributo produttivo del lavoro. Sulla base dell’argomentazione controfattuale presentata nel paragrafo precedente, ritengo che si possa postulare il seguente “assioma della produttività”: Il contributo produttivo del lavoro coincide con la produttività media del lavoro.
Si consideri un’azienda in cui si produce grano per mezzo di grano e lavoro. Ci sono tre dipendenti, uno dei quali produce 20 quintali di grano l’anno, un altro 15 quintali e un altro 10. La produttività media del lavoro è (20+15+10)/3=15. Si supponga che ogni lavoratore sia remunerato con un salario pari a 10 quintali di grano l’anno. Allora l’assioma della produttività e la definizione di sfruttamento consentono di concludere che i lavoratori sono sfruttati [5] capitalisticamente e precisamente che sono sfruttati a un saggio del 50%, cioè al saggio (15-10)/10=1/2.
Il modello grano-grano è una semplificazione. Più in generale si può studiare un’economia in cui si producono molte merci per mezzo di se stesse e lavoro. Nel qual caso la produttività del lavoro, il salario e il saggio di sfruttamento saranno misurati in termini di prezzi. Lo sfruttamento può essere provato astraendo dalla merce scelta come unità di misura. Inoltre il saggio di sfruttamento può essere misurato con precisione in termini di prezzi ed è indipendente dalla merce scelta come misura.
Si può formulare il seguente “teorema dello sfruttamento capitalistico”: Si verifica sfruttamento capitalistico dei lavoratori quando il salario è inferiore alla produttività media del lavoro. La dimostrazione del teorema è immediata e può essere ottenuta da un semplice ragionamento basato sulla definizione di sfruttamento e sull’assioma della produttività.
Certo, è un teorema che sembra un po’ tautologico, ma chi può pretendere di più dalla logica? D’altra parte gli assiomi sono veri per assunzione, e non si può fare nulla per convincere chi non vuole essere convinto. L’importante è che non siano contraddittori, perché in tal caso non convincerebbero neanche chi vorrebbe esserlo. Così tutto fa leva su un punto di vista particolare, ché tale è sempre quello che sostiene la convinzione della validità degli assiomi. Ebbene sostengo che l’assunzione del punto di vista della classe operaia è sufficiente per giustificare la postulazione dell’assioma della produttività e il teorema che ne consegue.
Il saggio di sfruttamento
Nell’esempio fatto nel paragrafo precedente il saggio di sfruttamento, σ, è misurato in termini di grano, e risulta essere pari a σ = (45-30)/30 = 15/10-1, dove 45 è il prodotto netto, 30 il monte-salari, 15 la produttività media del lavoro e 10 il salario per addetto. Più in generale, se si producono molte merci, il prodotto netto viene calcolato in termini delle quantità di beni prodotti, y, moltiplicate per i loro prezzi, p, ed è py. Il monte-salari viene calcolato come il salario monetario, w, moltiplicato per il numero dei lavoratori occupati, L, ed è wL. Perciò il saggio di sfruttamento in prezzi è pari a
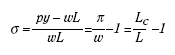
π=py/L è la produttività del lavoro in prezzi e Lc=py/w il lavoro “comandato” dal prodotto netto, cioè quello che può essere acquistato, al salario corrente, spendendo l’intero prodotto netto. Il secondo rapporto della formula è ottenuto dal primo dividendo numeratore e denominatore per L; il terzo è ottenuto dividendo per w.
Il fattore di sfruttamento, 1+σ=Lc/L, può essere interpretato come un rapporto tra il lavoro comandato dal prodotto netto e quello in esso contenuto. Si noti che, nonostante sia derivato da un rapporto tra redditi monetari, si presenta come un rapporto tra due quantità di lavoro. È maggiore di 1 se i capitalisti guadagnano un profitto e i lavoratori percepiscono un salario inferiore alla produttività del lavoro. Quando accade ciò, vuol dire che la quantità di lavoro che può essere comandata dal prodotto netto è maggiore di quella richiesta per produrlo. Questa misura dello sfruttamento ha qualche vantaggio rispetto a quella usata da Marx. Il saggio di sfruttamento marxiano è un rapporto tra due quantità di lavoro incorporato e quindi, come s’è visto, diverge da una misura in termini di prezzi. La misura in lavoro comandato/incorporato invece è sempre uguale a quella in termini di prezzi.
Tuttavia le variabili espresse in lavoro comandato e incorporato, pur essendo tecnologicamente omogenee, sono concettualmente differenti. Infatti quella che appare al numeratore di Lc/L è una quantità di lavoro comandato ex post, cioè dopo che il processo produttivo si è chiuso, mentre quella che appare al denominatore è una quantità di lavoro comandato ex ante, cioè prima della chiusura del processo produttivo. Il lavoro contenuto può essere inteso, sia come la quantità di lavoro che il capitalista ha comprato prima dell’avvio del processo produttivo, sia come il numero di lavoratori su cui il capitale esercita il comando nel processo produttivo. In tal modo il fattore di sfruttamento può essere interpretato come un moltiplicatore dell’accumulazione. Quando è maggiore di 1 si può dire che c’è un potenziale di valorizzazione e accumulazione del capitale, ovvero un potenziale di incremento del comando capitalistico sul lavoro. E si può dire che ciò accade perché i capitalisti possono comandare al termine della produzione più lavoro di quanto ne hanno comandato nella produzione stessa, più lavoro per avviare un nuovo processo produttivo di quanto ne è stato usato nel vecchio processo. Ciò è reso possibile dal fatto che i lavoratori non possono trattenere per sé l’intero reddito che producono. Ci può essere valorizzazione e accumulazione del capitale perché c’è sfruttamento.
Si noti che vale l’uguaglianza π/w=Lc/L. Il fattore di sfruttamento può anche essere interpretato come il rapporto tra il valore del prodotto netto nel capitalismo, nel quale gli scambi avvengono ai prezzi, e il valore del prodotto netto in Utopia, in cui gli scambi si verificano ai valori-lavoro. Questo rapporto dunque implica un raffronto controfattuale. Quando è maggiore di 1 vuol dire che la produttività del lavoro è maggiore del salario, che il capitalismo riesce ad estrarre dai lavoratori più reddito di quanto questi ne consumano per produrre il prodotto netto. Per questa ragione il valore del prodotto nel capitalismo è maggiore di quello che si avrebbe in Utopia.
Quando il fattore di sfruttamento è uguale a 1 non c’è valorizzazione del capitale, il saggio di profitto è nullo, i salari coincidono col prodotto netto, il lavoro comandato dal reddito coincide con quello in esso contenuto e le merci si scambiano ai valori-lavoro. Nel qual caso non c’è sfruttamento. I lavoratori staranno meglio in questa società piuttosto che in una in cui le merci si scambiano ai prezzi di produzione. Non è una questione di giustizia. È solo il fatto che, quali che siano le preferenze nel consumo e le preferenze sociali dei lavoratori, essi possono fare o comprare in Utopia tutto quello che possono fare o comprare nel capitalismo e qualcosa di più.
Alcune implicazioni istituzionali
Tornando alla formula dello sfruttamento, può essere utile riflettere su ciò che le sue diverse espressioni dicono, oltre che su certe cose che non dicono. Si potranno così afferrare alcune caratteristiche fondamentali del capitalismo.
In primo luogo quella formula dice qualcosa sull’assetto istituzionale di questo modo di produzione. Chiarisce che i lavoratori sono sfruttati attraverso il pagamento di un salario, che sono lavoratori dipendenti. 1+σ infatti può essere interpretato come un fattore di sfruttamento sulla base dell’assioma della produttività. Può essere espresso come π/w, cioè come un rapporto tra la produttività del lavoro e il salario. Quando la prima variabile è maggiore della seconda c’è sfruttamento in forza di quell’assioma. Così si viene a sapere che il salario, e quindi il contratto di lavoro, è un’istituzione fondamentale del capitalismo.
Marx è stato tra i primi ad afferrare il ruolo svolto dal sistema del salario nel creare le condizioni del dispotismo del capitale in fabbrica. Il meccanismo di estrazione del plusvalore poggia su un rapporto di potere. I lavoratori sono pagati per il valore d’uso del lavoro che offrono, non per il contributo produttivo del loro lavoro, né per il lavoro che in Utopia viene incorporato nel valore del prodotto netto. E in effetti la formula dello sfruttamento chiarisce che il prodotto netto: 1) non è una quantità di lavoro incorporato; 2) non è ciò che viene pagato ai lavoratori.
La formula dice che ci può essere sfruttamento capitalistico nella produzione se e solo se la produttività del lavoro è superiore al salario. Ma la produttività è determinata nel processo di produzione, non nel mercato. Così si viene anche a sapere che, per l’emergere dello sfruttamento, è necessario che il processo lavorativo sia sottratto al controllo dei lavoratori e sia controllato dai capitalisti. Lo sfruttamento è possibile, non perché i lavoratori vendono una merce il cui valore è superiore a quello della forza lavoro, ma perché i capitalisti hanno il controllo del processo lavorativo e possono quindi regolarlo in modo da estrarne un plusvalore. Il che, a sua volta, è reso possibile da un’istituzione transattiva che attribuisce ai datori di lavoro un potere di comando sui lavoratori. Tale istituzione è il contratto di lavoro (Ellerman, 1992; Screpanti, 2001a, 2001b), un contratto che i lavoratori accettano di stipulare in cambio di un salario.
Ma cos’è che i lavoratori effettivamente danno ai capitalisti in tale scambio? Be’, è un impegno all’obbedienza. I lavoratori vendono la rinuncia alla propria libertà per un certo numero di ore al giorno. “L’operaio libero [...] vende se stesso, e pezzo a pezzo. Egli mette all’asta 8, 10, 12, 15 ore della sua vita, ogni giorno, al migliore offerente” (Marx, 1945, p. 19). Ciò che Marx chiama “valore d’uso della forza lavoro”, e che identifica con ciò che i lavoratori danno in contropartita del suo “valore di scambio”, è in realtà la prerogativa all’uso dei lavoratori stessi nel processo lavorativo, una prerogativa che pertiene al capitalista in forza del contratto di lavoro. La possibilità che la produttività del lavoro sia maggiore del salario si fonda sul controllo capitalistico della produzione e non sullo scambio di mercato. Nel “mercato” viene fissato il prezzo che i lavoratori accettano per il loro impegno all’obbedienza, mentre la produttività del lavoro è determinata nel processo produttivo in forza del potere di comando che i capitalisti hanno acquistato col contratto di lavoro.
In secondo luogo la formula dello sfruttamento non dice nulla riguardo alla distribuzione dei diritti di proprietà, ed è compatibile con molte diverse forme capitalistiche, dalla proprietà privata a quella statale, dal capitalismo di mercato a quello di piano. Non dice niente neanche sull’esistenza di un saggio di profitto uniforme, ed è quindi compatibile sia con un sistema di mercato concorrenziale, sia col monopolio e l’oligopolio, sia infine con l’accentramento burocratico.
Le decisioni d’investimento e di allocazione delle risorse possono anche essere prese da un organo politico centrale. Quello che conta è che non vengano prese dai lavoratori. Altrimenti non si può parlare di sfruttamento del lavoro. Il prodotto netto è controllato da chi ha il controllo del processo produttivo e, se il contratto di lavoro sottrae quest’ultimo dalla portata dei lavoratori, vi sottrae anche il primo. D’altronde se i lavoratori controllassero il prodotto e la sua distribuzione, la loro remunerazione non si configurerebbe più come salario, bensì come divisione democratica del valore aggiunto. In conclusione la presenza del salario nella formula dello sfruttamento fornisce un’altra informazione essenziale, e cioè che, qualunque sia il regime di proprietà e la forma di mercato, i lavoratori non hanno il controllo dell’output.
In terzo luogo la formula dello sfruttamento dice che non è necessario che il plusvalore venga consumato dai capitalisti. È sufficiente che siano loro a decidere quanto consumarne e quanto investirne. I lavoratori sarebbero pur sempre sfruttati, visto che le decisioni di spesa del plusvalore resterebbero fuori della loro portata. La formula dice qualcosa sull’esistenza di un plusvalore, non sulla maniera in cui questo viene speso. Lo sfruttatore priva i lavoratori, non solo della libertà di scelta del modo di produrre, ma anche della libertà di scelta del modo di usare il plusvalore (Van Parijs, 1995, p. 139).
Infine la formula, benché non dica niente sui modi di spesa del plusvalore, dice però che esso costituisce un potenziale d’accumulazione e di valorizzazione del capitale. Infatti il fattore di sfruttamento, in quanto rapporto tra lavoro comandato dal prodotto netto e lavoro in esso contenuto, rappresenta una misura del fattore d’accumulazione massimo. Il quale sarà tanto più grande quanto più basso è il salario relativo, quanto minore è la quota di prodotto di cui si riappropriano i lavoratori. Insomma la possibilità dell’accumulazione è intrinseca al sistema del salario. Non solo i lavoratori come classe accettano le catene della produzione capitalistica sottoscrivendo un contratto di lavoro, ma accettano di lavorare al possibile rafforzamento delle proprie catene ogni volta che subiscono una riduzione della quota salari. Dunque la formula dello sfruttamento fa capire che l’accumulazione del capitale, in quanto possibilità intrinseca del capitalismo, è una sua caratteristica essenziale. Se il capitale è un rapporto di produzione, non lo è a causa della proprietà privata dei mezzi di produzione; lo è a causa della propria connaturata tendenza all’autovalorizzazione e all’accumulazione.
-----
Conclusioni
Il modello dell’Utopia del valore-lavoro è risultato utile nella formulazione della teoria qui proposta, perché ha consentito di definire il fattore di sfruttamento nei termini di un rapporto tra due quantità di lavoro, quello comandato dal prodotto netto e quello in esso contenuto. La differenza quantitativa e concettuale tra lavoro comandato e lavoro contenuto viene meno quando scompare lo sfruttamento. Ad ogni modo, ciò che rende veramente utile il modello dell’Utopia non è tanto il fatto che in esso lo scambio avviene ai valori-lavoro. Lo è piuttosto il fatto che i lavoratori interpretino la superiorità di Utopia in termini di assenza di sfruttamento. Volendo, quindi, si può generalizzare la teoria facendo a meno del valore-lavoro anche in Utopia.
Il merito principale dell’analisi controfattuale svolta nella seconda parte di questo saggio risiede nella sua capacità di enucleare alcune caratteristiche fondamentali dello sfruttamento capitalistico. E le caratteristiche enucleate risultano essere due. Una è di tipo economico, ed è la produzione di plusvalore. L’altra è di tipo istituzionale, ed è il contratto di lavoro. La prima crea le condizioni per l’autovalorizzazione del capitale. La seconda crea quelle del comando capitalistico nel processo lavorativo.
Qualsiasi società che abolisca queste due caratteristiche è una società che supera il capitalismo e lo sfruttamento. Cosicché è possibile generalizzare la teoria. Si può leggere il denominatore di Lc/L come una misura del valore del prodotto netto in Utopia, anche ammettendo che in essa le merci non si scambiano ai valori-lavoro. I redditi dei lavoratori possono essere differenziati, ad esempio in funzione delle abilità personali, dell’intensità degli sforzi individuali e delle vocazioni o preferenze lavorative, oppure il reddito netto può essere almeno in parte distribuito e prodotto in base al criterio “a ognuno secondo i suoi bisogni, da ognuno secondo le sue capacità”. Così i valori delle merci in Utopia non dipenderebbero più solo dalle quantità di lavoro contenuto. La formula ci dice ugualmente che, se non deve esserci sfruttamento capitalistico: 1) il profitto deve essere nullo, 2) nessuno potrà vendere il proprio tempo di vita in cambio di un salario. Quando ciò accadrà il valore del prodotto netto sarà uguale a quello della forza lavoro e questa cesserà di essere considerata “forza lavoro”.
BIBLIOGRAFIA
Bellofiore R. 2000, “Lavoro vivo, valore in processo e trasformazione”, Critica Marxista, n. 5, pp. 41-55.
Bertinotti F. e Gianni A. 2000, Le idee che non muoiono, Milano: Ponte alle Grazie.
Carchedi G. 2001, “Il problema inesistente: la trasformazione dei valori in prezzi in parole semplici”, Proteo, 2, pp. 96-99.
Cavallaro L. 2000, “Napoleoni e il problema della trasformazione dei valori in prezzi”, Critica Marxista, n.5, pp. 26-40.
Cohen G. A. 1983, “More on Exploitation and the Labour Theory of Value”, Inquiry, 26, pp. 309-31.
Cohen G. A. 1986, “Self-Ownership, World-Ownership and Equality”, Part II, Social Philosophy and Politics, 3, pp. 77-96.
Croce B. 1927, Materialismo storico ed economia marxistica, Bari: Laterza.
Ellerman D. P. 1992, Property and Contract in Economics: The Case for Economic Democracy, Oxford: Blackwell.
Elster J. 1978, “Exploring Exploitation”, Journal of Peace Research, 15, pp. 3-17.
Freeman A. 2001, “Valore e Marx: Perché sono importanti”, Proteo, 2, pp. 90-95.
Kliman A. 2001, “Se è corretto non correggetelo”, Proteo, 2, pp. 100-107.
Marx K. 1945, Lavoro salariato e capitale, Roma: Società Editrice ‘L’unità’.
Marx K. 1964, Il Capitale, 3 voll, Roma: Editori Riuniti.
Marx K. 1969, Per la critica dell’economia politica, Roma: Editori Riuniti.
Mazzetti G. 2001, “Lo sfruttamento è davvero anacronistico? La questione del valore lavoro al di là dell’economia e della filosofia”, Critica Marxista, n. 1, pp. 31-43.
Petri F. 1989, “Lo sfruttamento nel capitalismo e nel socialismo”, in B. Jossa (a cura di), Teoria dei sistemi economici, Torino: UTET, 1989, pp. 225-63.
Reiman J. 1989, “ An Alternative to ‘Distributive Marxism: Further Thoughts on Cohen, Roemer and Exploitation”, Canadian Journal of Philosophy, suppl. 15, pp. 299-331.
Roemer J. E. 1982, A General Theory of Exploitation and Class, Cambridge Mass.: Harvard University Press.
Screpanti E. 1993, “Sraffa after Marx: a New Interpretation”, Review of Political Economy, 5, pp. 1-21.
Screpanti E. 2001a, The Fundamental Institutions of Capitalism, London: Routledge.
Screpanti E. 2001b, “Contratto di lavoro, regimi di proprietà e governo dell’accumulazione: verso una teoria generale del capitalismo”, Proteo, prima parte: n. 1, pp.70-81, seconda parte: n. 2, pp. 108-123.
Van Parijs P. 1995, Real Freedom for All: What (if Anything) Can Justify Capitalism? Oxford: Clarendon.
[1] Riservandomi ogni responsabilità per eventuali errori, desidero ringraziare Fabio Petri per le critiche e i commenti che ha voluto fare a una precedente stesura di questo saggio.
[2] Data una tecnica produttiva che usa terra, lavoro e mezzi di produzione secondo determinati coefficienti tecnici, non è possibile ottenere nessuna merce senza usare terra e capitale. Dunque questi requisiti produttivi sono necessari all’attività lavorativa e contribuiscono alla produzione. Il problema è: quanto contribuiscono alla produzione del prodotto netto? La distinzione del prodotto netto da quello lordo rinvia a un sistema di contabilità e quindi presuppone una teoria del valore: il prodotto netto è il valore che nel processo produttivo viene aggiunto a quello delle anticipazioni tecnicamente necessarie. L’idea marxiana che il capitale contribuisca alla produzione delle merci non ha niente a che vedere con quella marginalista, secondo cui esso dà un contributo produttivo alla creazione del valore aggiunto.
[3] Non è la migliore di tutte le alternative possibili. L’ammissibilità, come l’ho definita qui, implica che le tecniche siano le stesse che vengono usate nell’economia capitalistica di riferimento. Va da se che in un mondo governato dai lavoratori cambierebbero radicalmente sia il modo di produrre che le cose da produrre. Ma la definizione di un’alternativa di questo tipo non è necessaria per sostenere il ragionamento con cui intendo giustificare la tesi dello sfruttamento.
[4] Un approccio del genere è stato sviluppato, tra gli altri, da Roemer (1982), ma in una direzione sostanzialmente diversa da quella seguita qui. Roemer, ad esempio, dà molta importanza alla distribuzione dei diritti di proprietà, che io invece ignoro del tutto. Per delle valutazioni critiche della teoria di Roemer vedi Petri (1989) e Reiman (1989).
Per quanto è a mia conoscenza, il primo a proporre un’interpretazione della teoria marxiana del valore-lavoro e dello sfruttamento in termini controfattuali fu Croce (1927), il quale però aveva la pretesa, secondo me erronea, che Marx stesso ragionasse in quei termini. Anche Bellofiore (2000) propone un uso controfattuale della teoria del valore-lavoro pretendendo di attribuire tale uso a Marx. Un interessante approccio controfattuale proposto da Petri (1989, p. 233) mostra che il pluslavoro si risolve in profitti solo per motivi istituzionali e non per motivi tecnici.
[5] Qui lo sfruttamento è riferito all’insieme dei lavoratori, non al singolo. Se fosse definito su base individuale, il lavoratore meno produttivo risulterebbe non essere sfruttato. Ma si assume che tutti e tre i lavoratori siano necessari per l’adempimento dei compiti produttivi.